
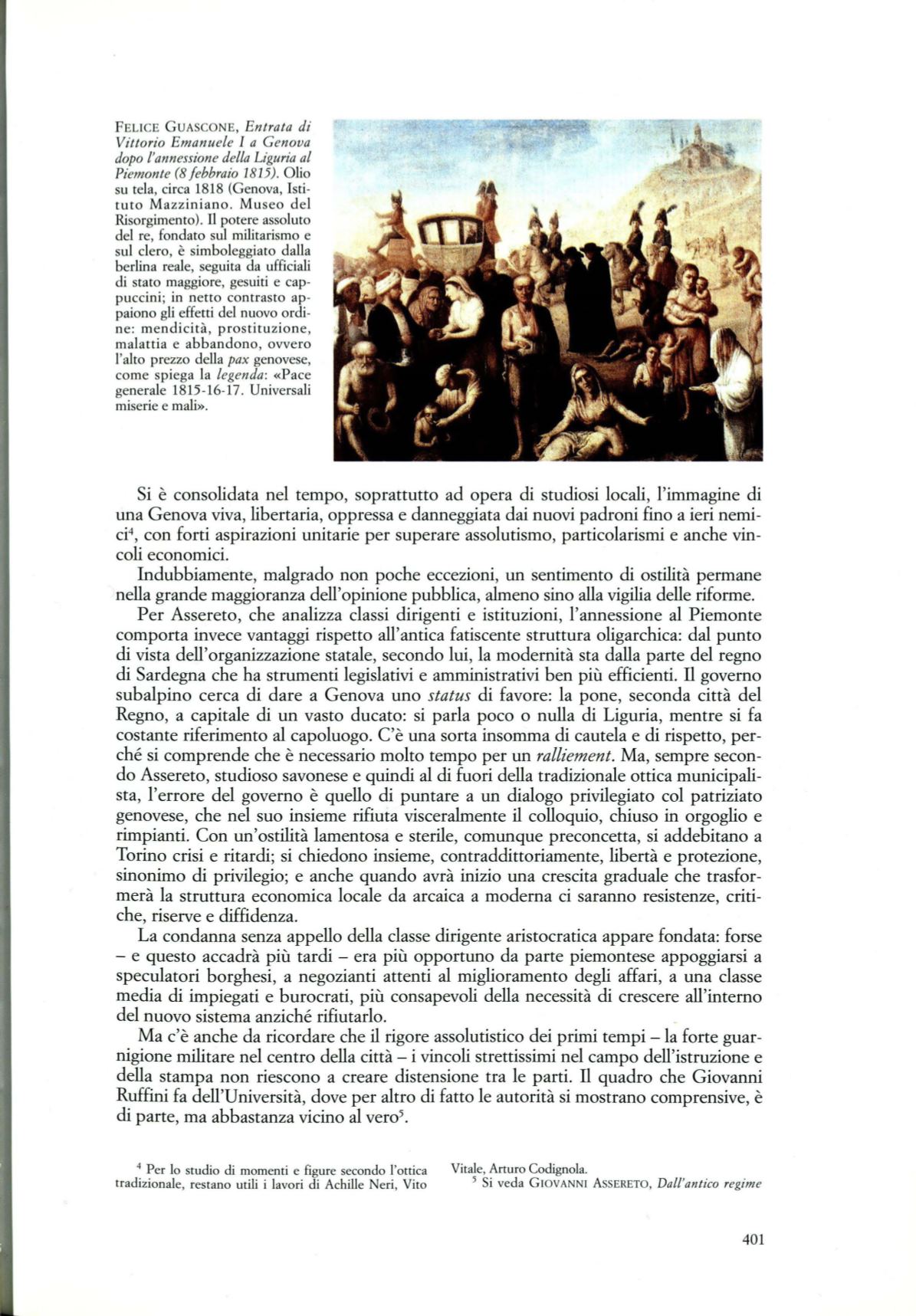
FELICE GUASCONE,
Entrata di
Vittorio Emanuele I a Genova
dopo l'annessione della Liguria al
Piemonte
(8
f ebbraio
1815). Olio
su tela, circa 1818 (Genova, Isti–
tuto Mazziniano . Museo del
Risorgimento). Il potere assoluto
del re, fondato sul militarismo e
sul clero, è simboleggiato dalla
berlina reale, seguita da ufficiali
di stato maggiore, gesuiti e cap–
puccini; in netto contrasto ap–
paiono gli effetti del nuovo ordi–
ne: mendicità, prostituzione,
malattia e abbandono, ovvero
l'alto prezzo della
pax
genovese,
come spiega la
legenda:
«Pace
generale 1815-16-17. Universali
miserie e mali».
Si è consolidata nel tempo, soprattutto ad opera di studiosi locali, l'immagine di
una Genova viva, libertaria, oppressa e danneggiata dai nuovi padroni fino a ieri nemi–
ci\ con forti aspirazioni unitarie per superare assolutismo, particolarismi e anche vin–
coli economici.
Indubbiamente, malgrado non poche eccezioni, un sentimento di ostilità permane
nella grande maggioranza dell'opinione pubblica, almeno sino alla vigilia delle riforme.
Per Assereto, che analizza classi dirigenti e istituzioni, 1'annessione al Piemonte
comporta invece vantaggi rispetto all' antica fatiscente struttura oligarchica: dal punto
di vista dell'organizzazione statale, secondo lui, la modernità sta dalla parte del regno
di Sardegna che ha strumenti legislativi e amministrativi ben più efficienti. Il governo
subalpino cerca di dare a Genova uno
status
di favore: la pone, seconda città del
Regno, a capitale di un vasto ducato: si parla poco o nulla di Liguria, mentre si fa
costante riferimento al capoluogo. C'è una sorta insomma di cautela e di rispetto, per–
ché si comprende che è necessario molto tempo per un
ralliement.
Ma, sempre secon–
do Assereto, studioso savonese e quindi al di fuori della tradizionale ottica municipali–
sta, l'errore del governo è quello di puntare a un dialogo privilegiato col patriziato
genovese, che nel suo insieme rifiuta visceralmente il colloquio, chiuso in orgoglio e
rimpianti. Con un' ostilità lamentosa e sterile, comunque preconcetta, si addebitano a
Torino crisi e ritardi; si chiedono insieme, contraddittoriamente, libertà e protezione,
sinonimo di privilegio; e anche quando avrà inizio una crescita graduale che trasfor–
merà la struttura economica locale da arcaica a moderna ci saranno resistenze, criti–
che, riserve e diffidenza.
La condanna senza appello della classe dirigente aristocratica appare fondata: forse
- e questo accadrà più tardi - era più opportuno da parte piemontese appoggiarsi a
speculatori borghesi, a negozianti attenti al miglioramento degli affari, a una classe
media di impiegati e burocrati, più consapevoli della necessità di crescere all'interno
del nuovo sistema anziché rifiutarlo.
Ma c'è anche da ricordare che il rigore assolutistico dei primi tempi -la forte guar–
nigione militare nel centro della città - i vincoli strettissimi nel campo dell'istruzione e
della stampa non riescono a creare distensione tra le parti. Il quadro che Giovanni
Ruffini fa dell'Università, dove per altro di fatto le autorità si mostrano comprensive, è
di parte, ma abbastanza vicino al ver0
5 .
4
Per lo studio di momenti e figure secondo l'ottica
tradizionale, restano utili i lavori di Achille Neri, Vito
Vitale, Arturo Codignola.
5
Si veda GIOVANNI ASSERETO,
Dall'antico regime
401


















