
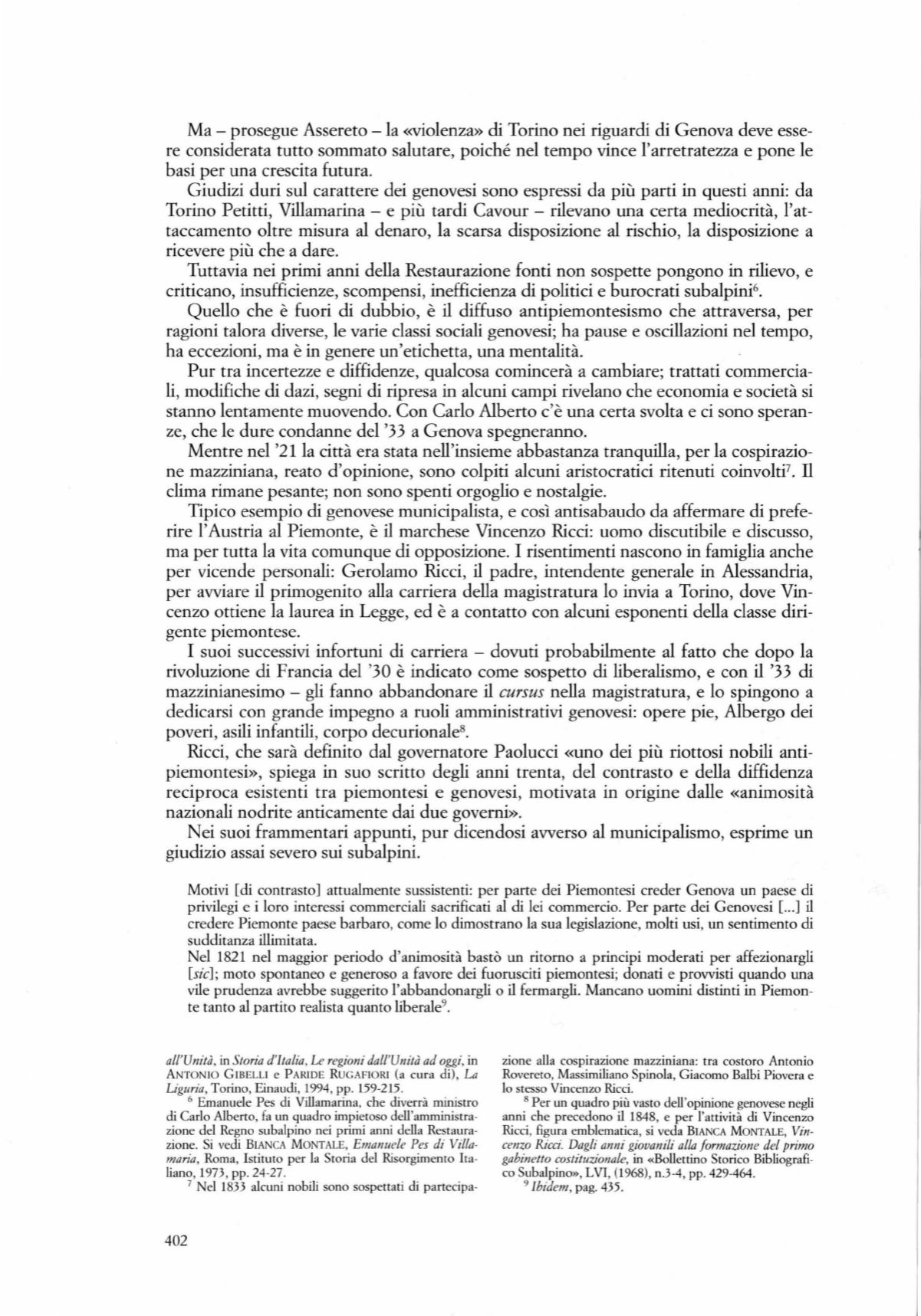
Ma - prosegue Assereto -la «violenza» di Torino nei riguardi di Genova deve esse–
re considerata tutto sommato salutare, poiché nel tempo vince l'arretratezza e pone le
basi per una crescita futura.
Giudizi duri sul carattere dei genovesi sono espressi da più parti in questi anni: da
Torino Petitti, Villamarina - e più tardi Cavour - rilevano una certa mediocrità, l'at–
taccamento oltre misura al denaro, la scarsa disposizione al rischio, la disposizione a
ricevere più che a dare.
Tuttavia nei primi anni della Restaurazione fonti non sospette pongono in rilievo, e
criticano, insufficienze, scompensi, inefficienza di politici e burocrati subalpini
6 •
Quello che è fuori di dubbio, è il diffuso antipiemontesismo che attraversa, per
ragioni talora diverse, le varie classi sociali genovesi; ha pause e oscillazioni nel tempo,
ha eccezioni, ma è in genere un' etichetta, una mentalità.
Pur tra incertezze e diffidenze, qualcosa comincerà a cambiare; trattati commercia–
li, modifiche di dazi, segni di ripresa in alcuni campi rivelano che economia e società si
stanno lentamente muovendo. Con Carlo Alberto c'è una certa svolta e ci sono speran–
ze, che le dure condanne del '33 a Genova spegneranno.
Mentre nel
'21
la città era stata nell'insieme abbastanza tranquilla, per la cospirazio–
ne mazziniana, reato d'opinione, sono colpiti alcuni aristocratici ritenuti coinvolti
7 •
Il
clima rimane pesante; non sono spenti orgoglio e nostalgie.
Tipico esempio di genovese municipalista, e così antisabaudo da affermare di prefe–
rire 1'Austria al Piemonte, è il marchese Vincenzo Ricci: uomo discutibile e discusso,
ma per tutta la vita comunque di opposizione. I risentimenti nascono in famiglia anche
per vicende personali: Gerolamo Ricci, il padre, intendente generale in Alessandria,
per avviare il primogenito alla carriera della magistratura lo invia a Torino, dove Vin–
cenzo ottiene la laurea in Legge, ed è a contatto con alcuni esponenti della classe diri–
gente piemontese.
I suoi successivi infortuni di carriera - dovuti probabilmente al fatto che dopo la
rivoluzione di Francia del '30 è indicato come sospetto di liberalismo, e con il '33 di
mazzinianesimo - gli fanno abbandonare il
cursus
nella magistratura, e lo spingono a
dedicarsi con grande impegno a ruoli amministrativi genovesi: opere pie, Albergo dei
poveri, asili infantili, corpo decurionale
8 •
Ricci, che sarà definito dal governatore Paolucci «uno dei più riottosi nobili anti–
piemontesi», spiega in suo scritto degli anni trenta, del contrasto e della diffidenza
reciproca esistenti tra piemontesi e genovesi, motivata in origine dalle «animosità
nazionali nodrite anticamente dai due governi».
Nei suoi frammentari appunti, pur dicendosi avverso al munidpalismo, esprime un
giudizio assai severo sui subalpini.
Motivi [di contrasto] attualmente sussistenti: per parte dei Piemontesi creder Genova un paese di
privilegi e i loro interessi commerciali sacrificati al di lei commercio. Per parte dei Genovesi L..] il
credere Piemonte paese barbaro, come lo dimostrano la sua legislazione, molti usi, un sentimento di
sudditanza illimitata.
Nel 1821 nel maggior periodo d'animosità bastò un ritorno a principi moderati per affezionargli
[sic];
moto spontaneo e generoso a favore dei fuorusciti piemontesi; donati e provvisti quando una
vile prudenza avrebbe suggerito l'abbandonargli o il fermargli. Mancano uomini distinti in Piemon–
te tanto al partito realista quanto liberale
9 .
all'Unità,
in
Storia d'Italia, Le regioni dall'Unità ad oggi,
in
ANTON IO GIBELLI e PARIDE RUGA FIORI (a cura di) ,
La
Liguria,
Torino, Einaudi, 1994, pp. 159-215.
6
Emanuele Pes di Villamarina, che diverrà ministro
di Carlo Alberto, fa un quadro impietoso dell'amministra–
zione del Regno subalpino nei primi anni della Restaura–
zione. Si vedi BIANCA MONTALE,
Emanuele Pes di Villa–
moria,
Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Ita–
liano, 1973, pp. 24-27.
7
Nel 1833 alcuni nobili sono sospettati di partecipa-
402
zione alla cospirazione mazziniana: tra costoro Antonio
Rovereto, Massimiliano Spinola, Giacomo Balbi Piovera e
lo stesso Vincenzo Ricci.
8
Per un quadro più vasto dell'opinione genovese negli
anni che precedono il 1848, e per l'attività di Vincenzo
Ricci, figura emblematica, si veda BIANCAMONTALE,
Vin–
cenzo Ricci. Dagli anni giovanili alla formazione del primo
gabinetto costituzionale,
in «Bollettino Storico Bibliografi–
co Subalpino»,
LVI,
(1968), n.3-4, pp. 429-464.
9
Ibidem,
pago 435 .


















