
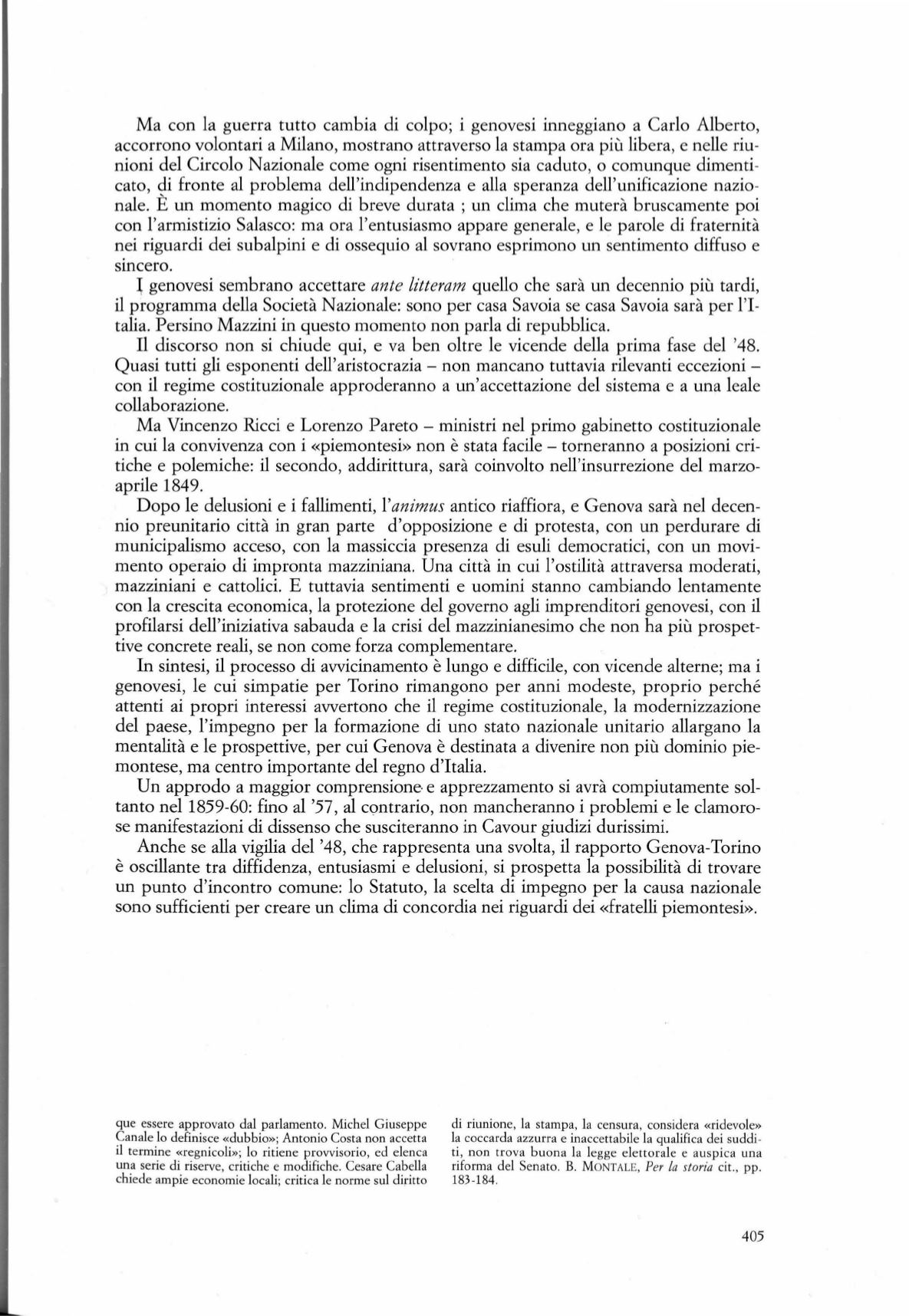
Ma con la guerra tutto cambia di colpo; i genovesi inneggiano a Carlo Alberto,
accorrono volontari a Milano, mostrano attraverso la stampa ora più libera, e nelle riu–
nioni del Circolo Nazionale come ogni risentimento sia caduto, o comunque dimenti–
cato, di fronte al problema dell'indipendenza e alla speranza dell'unificazione nazio–
nale.
È
un momento magico di breve durata ; un clima che muterà bruscamente poi
con l'armistizio Salasco: ma ora l'entusiasmo appare generale, e le parole di fraternità
nei riguardi dei subalpini e di ossequio al sovrano esprimono un sentimento diffuso e
SIncero.
~
genovesi sembrano accettare
ante litteram
quello che sarà un decennio più tardi,
il programma della Società Nazionale: sono per casa Savoia se casa Savoia sarà per l'I–
talia. Persino Mazzini in questo momento non parla di repubblica.
Il discorso non si chiude qui, e va ben oltre le vicende della prima fase del '48.
Quasi tutti gli esponenti dell' aristocrazia - non mancano tuttavia rilevanti eccezioni -
con il regime costituzionale approderanno a un' accettazione del sistema e a una leale
collaborazione.
Ma Vincenzo Ricci e Lorenzo Pareto - ministri nel primo gabinetto costituzionale
in cui la convivenza con i «piemontesi» non
è
stata facile - torneranno a posizioni cri–
tiche e polemiche: il secondo, addirittura, sarà coinvolto nell'insurrezione del marzo–
aprile 1849.
Dopo le delusioni e i fallimenti,
l'animus
antico riaffiora, e Genova sarà nel decen–
nio preunitario città
in
gran parte d 'opposizione e di protesta, con un perdurare di
municipalismo acceso, con la massiccia presenza di esuli democratici, con un movi–
mento operaio di impronta mazziniana. Una città in cui l'ostilità attraversa moderati,
mazziniani e cattolici. E tuttavia sentimenti e uomini stanno cambiando lentamente
con la crescita economica, la protezione del governo agli imprenditori genovesi, con il
profilarsi dell'iniziativa sabauda e la crisi del mazzinianesimo che non ha più prospet–
tive concrete reali, se non come forza complementare.
In sintesi, il processo di avvicinamento
è
lungo e difficile, con vicende alterne; ma i
genovesi, le cui simpatie per Torino rimangono per anni modeste, proprio perché
attenti ai propri interessi avvertono che il regime costituzionale, la modernizzazione
del paese, l'impegno per la formazione di uno stato nazionale unitario allargano la
mentalità e le prospettive, per cui Genova
è
destinata a divenire non più dominio pie–
montese, ma centro importante del regno d'Italia.
Un approdo a maggior comprensione· e apprezzamento si avrà compiutamente sol–
tanto nel 1859-60: fino al '57, al cQntrario, non mancheranno i problemi e le clamoro–
se manifestazioni di dissenso che susciteranno in Cavour giudizi durissimi.
Anche se alla vigilia del '48, che rappresenta una svolta, il rapporto Genova-Torino
è oscillante tra diffidenza, entusiasmi e delusioni, si prospetta la possibilità di trovare
un punto d'incontro comune: lo Statuto, la scelta di impegno per la causa nazionale
sono sufficienti per creare un clima di concordia nei riguardi dei «fratelli piemontesi».
que essere approvato dal parlamento. Michel Giuseppe
Canale lo definisce «dubbio»; Antonio Costa non accetta
il
termine «regnicoli»; lo ritiene provvisorio, ed elenca
una serie di riserve, critiche e modifiche. Cesare Cabella
chiede ampie economie locali; critica le norme sul diritto
di riunione, la stampa, la censura, considera «ridevole»
la coccarda azzurra e inaccettabile la qualifica dei suddi–
ti, no n trova buona la legge eletrorale e auspica una
riforma del Senato. B. MONTALE,
Per la storia
cit. , pp.
183-184.
405


















