
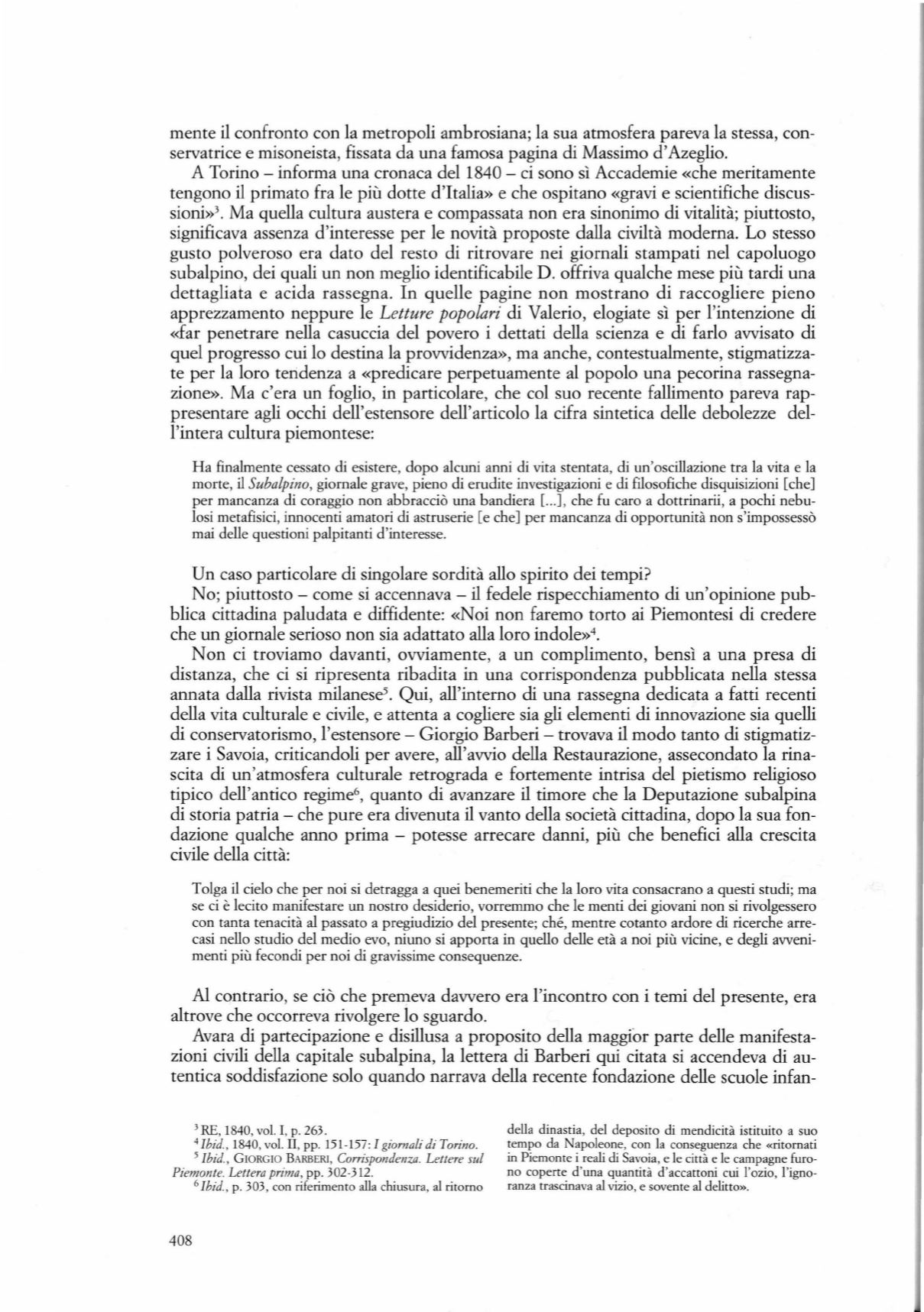
mente il confronto con la metropoli ambrosiana; la sua atmosfera pareva la stessa, con–
servatrice e misoneista, fissata da una famosa pagina di Massimo d'Azeglio.
A Torino - informa una cronaca del 1840 - ci sono sì Accademie «che meritamente
tengono il primato fra le più dotte d'Italia» e che ospitano «gravi e scientifiche discus–
sioni»3. Ma quella cultura austera e compassata non era sinonimo di vitalità; piuttosto,
significava assenza d'interesse per le novità proposte dalla civiltà moderna. Lo stesso
gusto polveroso era dato del resto di ritrovare nei giornali stampati nel capoluogo
subalpino, dei quali un non meglio identificabile D. offriva qualche mese più tardi una
dettagliata e acida rassegna. In quelle pagine non mostrano di raccogliere pieno
apprezzamento neppure le
Letture popolari
di Valerio, elogiate sì per l'intenzione di
«far penetrare nella casuccia del povero i dettati della scienza e di farlo avvisato di
quel progresso cui lo destina la provvidenza», ma anche, contestualmente, stigmatizza–
te per la loro tendenza a «predicare perpetuamente al popolo una pecorina rassegna–
zione». Ma c'era un foglio , in particolare, che col suo recente fallimento pareva rap–
presentare agli occhi dell'estensore dell' articolo la cifra sintetica delle debolezze del–
l'intera cultura piemontese:
Ha finalmente cessato di esistere, dopo alcuni anni di vita stentata, di un 'oscillazione tra la vita e la
morte,
il
Subalpino,
giornale grave, pieno di erudite investigazioni e di filosofiche disquisizioni [che]
per mancanza di coraggio non abbracciò una bandiera [. ..], che fu caro a dottrinarii, a pochi nebu–
losi metafisici, innocenti amatori di astruserie [e che] per mancanza di opportunità non s'impossessò
mai delle questioni palpitanti d'interesse.
Un caso particolare di singolare sordità allo spirito dei tempi?
No; piuttosto - come si accennava - il fedele rispecchiamento di un'opinione pub–
blica cittadina paludata e diffidente: «Noi non faremo torto ai Piemontesi di credere
che un giornale serioso non sia adattato alla loro indole»4.
Non ci troviamo davanti, ovviamente, a un complimento, bensì a una presa di
distanza, che ci si ripresenta ribadita in una corrispondenza pubblicata nella stessa
annata dalla rivista milanese
5 .
Qui, all'interno di una rassegna dedicata a fatti recenti
della vita culturale e civile, e attenta a cogliere sia gli elementi di innovazione sia quelli
di conservatorismo, l'estensore - Giorgio Barberi - trovava il modo tanto di stigmatiz–
zare i Savoia, criticandoli per avere, all'avvio della Restaurazione, assecondato la rina–
scita di un 'atmosfera culturale retrograda e fortemente intrisa del pietismo religioso
tipico dell'antico regimé , quanto di avanzare il timore che la Deputazione subalpina
di storia patria - che pure era divenuta il vanto della società cittadina, dopo la sua fon–
dazione qualche anno prima - potesse arrecare danni, più che benefici alla crescita
civile della città:
Tolga
il
cielo che per noi si detragga a quei benemeriti che la loro vita consacrano a questi studi; ma
se ci è lecito manifestare un nostro desiderio, vorremmo che le menti dei giovani non si rivolgessero
con tanta tenacità al passato a pregiudizio del presente; ché, mentre cotanto ardore di ricerche arre–
casi nello studio del medio evo, niuno si apporta in quello delle età a noi più vicine, e degli avveni–
menti più fecondi per noi di gravissime consequenze.
Al contrario, se ciò che premeva davvero era l'incontro con i temi del presente, era
altrove che occorreva rivolgere lo sguardo.
Avara di partecipazione e disillusa a proposito della maggior parte delle manifesta–
zioni civili della capitale subalpina, la lettera di Barberi qui citata si accendeva di au–
tentica soddisfazione solo quando narrava della recente fondazione delle scuole infan-
3
RE, 1840, voI. I,
p.
263.
4
Ibid. ,
1840, voI. II,
pp.
151-157:
I giornali di Torino.
5
Ibzd.,
GIORGIO BARBERI ,
Corrispondenza. Lettere sul
Piemonte. Lettera prima ,
pp. 302 -312.
della dinastia, del deposito di mendicità istituito a suo
tempo da Napoleone, con la conseguenza che «ritornati
in Piemonte i reali di Savoia, e le città e le campagne furo–
no coperte d'una quantità d'accattoni cui l'ozio, l'igno–
ranza trascinava
al
vizio, e sovente
al
delitto».
6
Ibid.,
p. 303 , con riferimento alla chiusura, al ritorno
408


















