
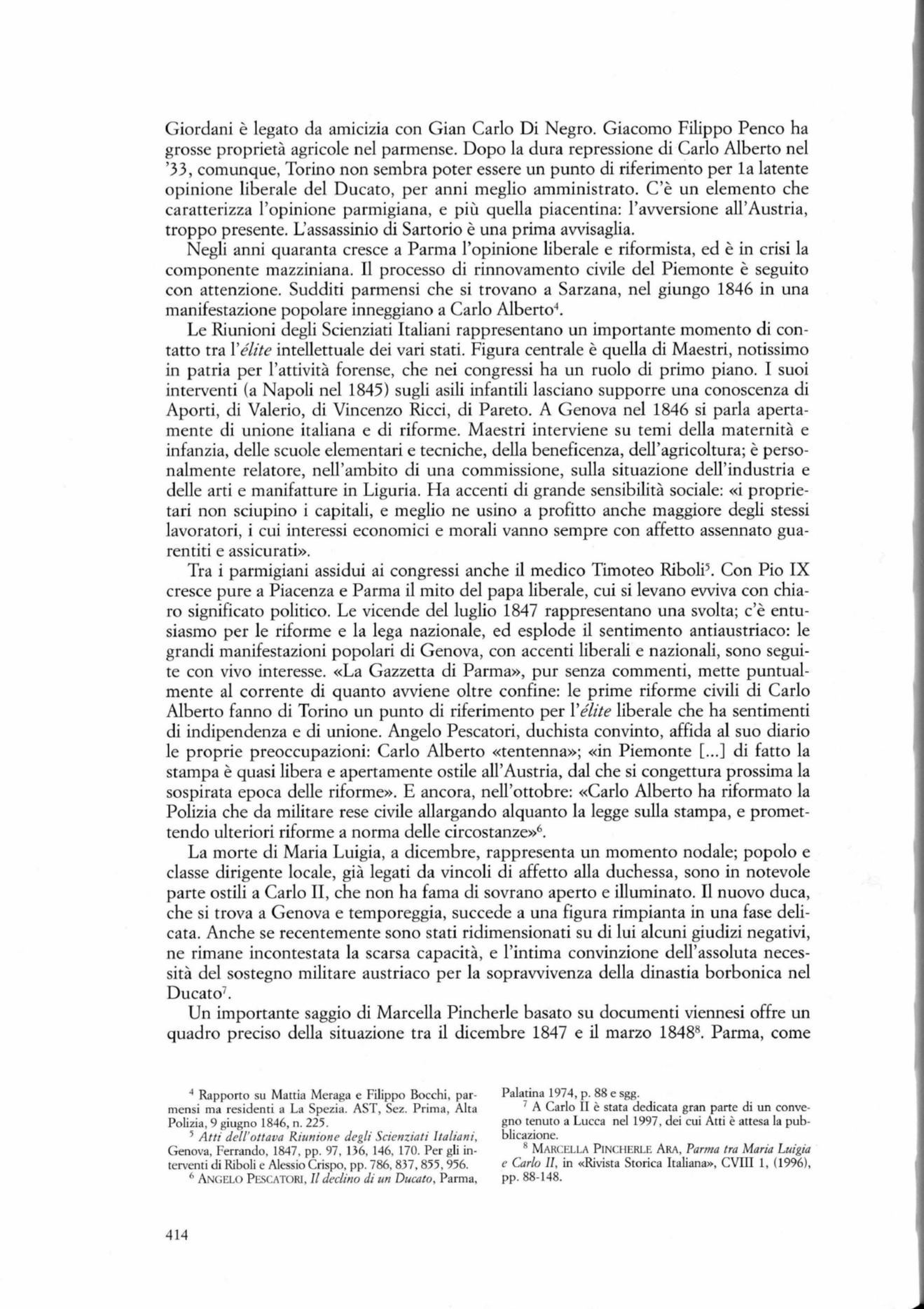
Giordani è legato da amicizia con Gian Carlo Di Negro. Giacomo Filippo Penco ha
grosse proprietà agricole nel parmense. Dopo la dura repressione di Carlo Alberto nel
'33, comunque, Torino non sembra poter essere un punto di riferimento per la latente
opinione liberale del Ducato, per anni meglio amministrato. C'è un elemento che
caratterizza l'opinione parmigiana, e più quella piacentina: l'avversione all'Austria,
troppo presente. L'assassinio di Sartorio è una prima avvisaglia.
Negli anni quaranta cresce a Parma l'opinione liberale e riformista, ed è in crisi la
componente mazziniana. Il processo di rinnovamento civile del Piemonte è seguito
con attenzione. Sudditi parmensi che si trovano a Sarzana, nel giungo
1846
in una
manifestazione popolare inneggiano a Carlo Alberto
4
•
Le Riunioni degli Scienziati Italiani rappresentano un importante momento di con–
tatto tra
1'élite
intellettuale dei vari stati. Figura centrale è quella di Maestri, notissimo
in patria per l'attività forense, che nei congressi ha un ruolo di primo piano. I suoi
interventi (a Napoli nel
1845)
sugli asili infantili lasciano supporre una conoscenza di
Aporti, di Valerio, di Vincenzo Ricci, di Pareto. A Genova nel
1846
si parla aperta–
mente di unione italiana e di riforme. Maestri interviene su temi della maternità e
infanzia, delle scuole elementari e tecniche, della beneficenza, dell' agricoltura; è perso–
nalmente relatore, nell'ambito di una commissione, sulla situazione dell'industria e
delle arti e manifatture in Liguria. Ha accenti di grande sensibilità sociale: «i proprie–
tari non sciupino i capitali, e meglio ne usino a profitto anche maggiore degli stessi
lavoratori, i cui interessi economici e morali vanno sempre con affetto assennato gua–
rentiti e assicurati».
Tra i parmigiani assidui ai congressi anche il medico Timoteo RiboliS. Con Pio IX
cresce pure a Piacenza e Parma il mito del papa liberale, cui si levano evviva con chia–
ro significato politico. Le vicende del luglio
1847
rappresentano una svolta; c'è entu–
siasmo per le riforme e la lega nazionale, ed esplode il sentimento antiaustriaco: le
grandi manifestazioni popolari di Genova, con accenti liberali e nazionali, sono segui–
te con vivo interesse. «La Gazzetta di Parma», pur senza commenti, mette puntual–
mente al corrente di quanto avviene oltre confine: le prime riforme civili di Carlo
Alberto fanno di Torino un punto di riferimento per
l'élite
liberale che ha sentimenti
di indipendenza e di unione. Angelo Pescatori, duchista convinto, affida al suo diario
le proprie preoccupazioni: Carlo Alberto «tentenna»; «in Piemonte [. ..
J
di fatto la
stampa è quasi libera e apertamente ostile all'Austria, dal che si congettura prossima la
sospirata epoca delle riforme». E ancora, nell' ottobre: «Carlo Alberto ha riformato la
Polizia che da militare rese civile allargando alquanto la legge sulla stampa, e promet–
tendo ulteriori riforme a norma delle circostanze»6.
La morte di Maria Luigia, a dicembre, rappresenta un momento nodale; popolo e
classe dirigente locale, già legati da vincoli di affetto alla duchessa, sono in notevole
parte ostili a Carlo II, che non ha fama di sovrano aperto e illuminato. Il nuovo duca,
che si trova a Genova e temporeggia, succede a una figura rimpianta in una fase deli–
cata. Anche se recentemente sono stati ridimensionati su di lui alcuni giudizi negativi,
ne rimane incontestata la scarsa capacità, e l'intima convinzione dell'assoluta neces–
sità del sostegno militare austriaco per la sopravvivenza della dinastia borbonica nel
Ducato
7 •
Un importante saggio di Marcella Pincherle basato su documenti viennesi offre un
quadro preciso della situazione tra il dicembre
1847
e il marzo
1848
8 •
Parma, come
4
Rapporto su Mattia Meraga e Filippo Bocchi, par–
mensi ma residenti a La Spezia. AST, Sez. Prima, Alta
Polizia, 9 giugno 1846, n. 225.
5
Atti dell'ottava R iunione degli Scienziati Italiani,
Genova, Ferrando, 1847, pp. 97, 136, 146, 170. Per gli in–
terventi di Riboli e Alessio Crispo, pp. 786, 837, 855, 956.
6
ANGELO PESCATORI,
Il declino di un Ducato,
Parma,
414
Palatina 1974, p. 88 e sgg.
7
A Carlo II
è
stata dedicata gran parte di un conve–
gno tenuto a Lucca nel 1997, dei cui Atti è attesa la pub–
blicazione.
8
MARCELLA PINCHERLE
ARA,
Parma tra Maria Luzgia
e Carlo II,
in «Rivista Storica Italiana», CVIII 1, (1996) ,
pp. 88-148.


















