
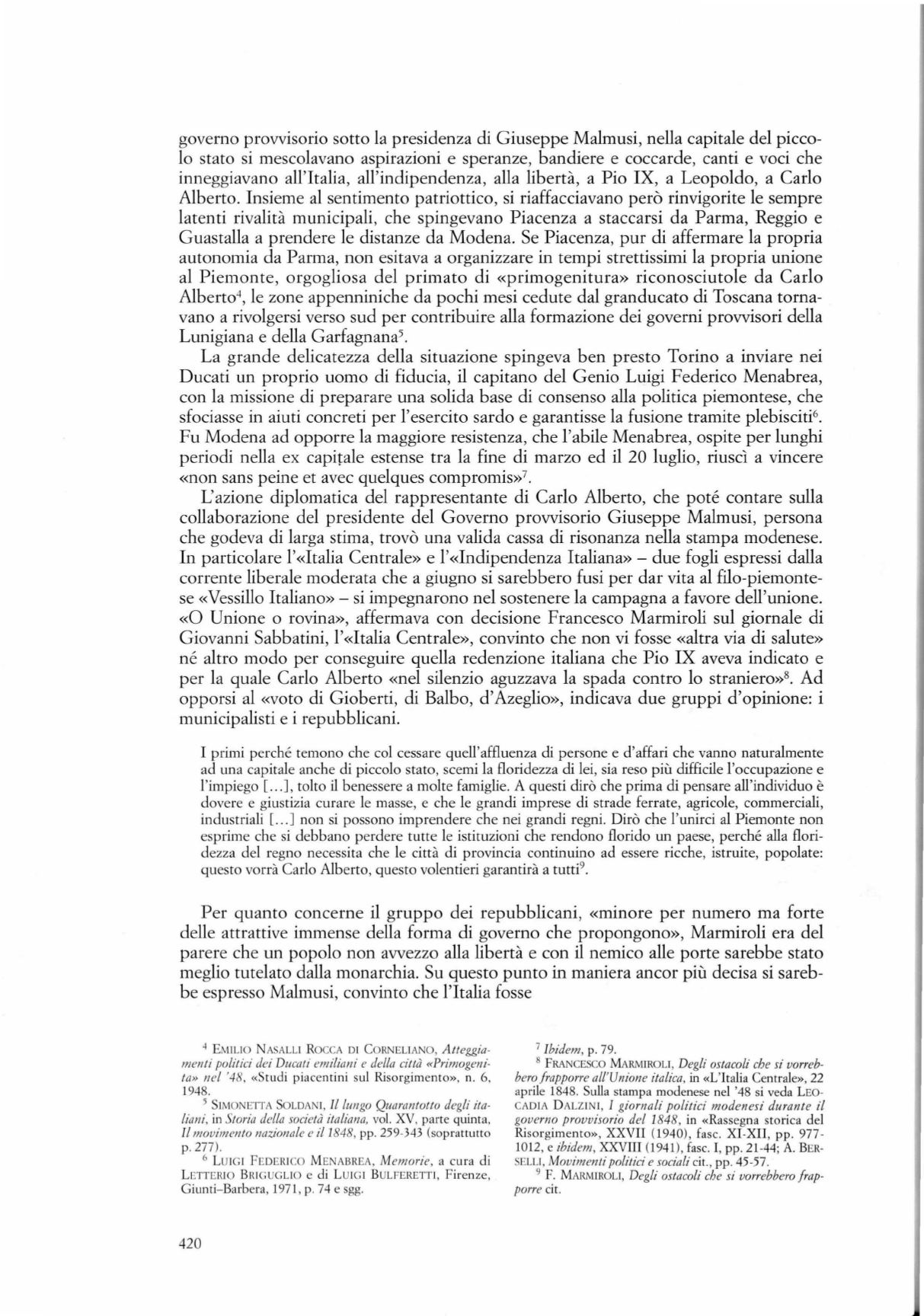
governo provvisorio sotto la presidenza di Giuseppe Malmusi, nella capitale del picco–
lo stato si mescolavano aspirazioni e speranze, bandiere e coccarde, canti e voci che
inneggiavano all'Italia, all'indipendenza, alla libertà, a Pio IX, a Leopoldo, a Carlo
Alberto. Insieme al sentimento patriottico, si riaffacciavano però rinvigorite le sempre
latenti rivalità municipali, che spingevano Piacenza a staccarsi da Parma, Reggio e
Guastalla a prendere le distanze da Modena. Se Piacenza, pur di affermare la propria
autonomia da Parma, non esitava a organizzare in tempi strettissimi la propria unione
al Piemonte, orgogliosa del primato di «primogenitura» riconosciutole da Carlo
Albert0
4 ,
le zone appenniniche da pochi mesi cedute dal granducato di Toscana torna–
vano a rivolgersi verso sud per contribuire alla formazione dei governi provvisori della
Lunigiana e della Garfagnana
5 .
La grande delicatezza della situazione spingeva ben presto Torino a inviare nei
Ducati un proprio uomo di fiducia, il capitano del Genio Luigi Federico Menabrea,
con la missione di preparare una solida base di consenso alla politica piemontese, che
sfociasse in aiuti concreti per l'esercito sardo e garantisse la fusione tramite plebisciti
6 .
Fu Modena ad opporre la maggiore resistenza, che l'abile Menabrea, ospite per lunghi
periodi nella ex capitale estense tra la fine di marzo ed il 20 luglio, riuscì a vincere
«non sans peine et avec quelques compromis»7.
L'azione diplomatica del rappresentante di Carlo Alberto, che poté contare sulla
collaborazione del presidente del Governo provvisorio Giuseppe Malmusi, persona
che godeva di larga stima, trovò una valida cassa di risonanza nella stampa modenese.
In particolare l'«Italia Centrale» e l'«Indipendenza Italiana» - due fogli espressi dalla
corrente liberale moderata che a giugno si sarebbero fusi per dar vita al filo-piemonte–
se «Vessillo Italiano» - si impegnarono nel sostenere la campagna a favore dell'unione.
«O Unione o rovina», affermava con decisione Francesco Marmiroli sul giornale di
Giovanni Sabbatini, l'«Italia Centrale», convinto che non vi fosse «altra via di salute»
né altro modo per conseguire quella redenzione italiana che Pio IX aveva indicato e
per la quale Carlo Alberto «nel silenzio aguzzava la spada contro lo straniero»8. Ad
opporsi al «voto di Gioberti, di Balbo, d'Azeglio», indicava due gruppi d'opinione: i
municipalisti e i repubblicani.
I primi perché temono che col cessare quell'affluenza di persone e d'affari che vanno naturalmente
ad una capitale anche di piccolo stato, scemi la floridezza di lei, sia reso più difficile l'occupazione e
l'impiego [.. .] , tolto il benessere a molte famiglie. A questi dirò che prima di pensare all'individuo è
dovere e giustizia curare le masse, e che le grandi imprese di strade ferrate, agricole, commerciali,
industriali [. ..] non si possono imprendere che nei grandi regni. Dirò che l'unirei al Piemonte non
esprime che si debbano perdere tutte le istituzioni che rendono florido un paese, perché alla flori–
dezza del regno necessita che le città di provincia continuino ad essere ricche, istruite, popolate:
questo vorrà Carlo Alberto, questo volentieri garantirà a tutti
9 .
Per quanto concerne il gruppo dei repubblicani, «minore per numero ma forte
delle attrattive immense della forma di governo che propongono», Marmiroli era del
parere che un popolo non avvezzo alla libertà e con il nemico alle porte sarebbe stato
meglio tutelato dalla monarchia. Su questo punto in maniera ancor più decisa si sareb–
be espresso Malmusi, convinto che l'Italia fosse
~
EMILIO NASALLI ROCCA DI CORNELIANO,
Atteggia–
menti politici dei Ducati emiliani e della città «Primogeni–
ta» nel
'48,
«Studi piacentini sul Risorgimento», n.
6,
1948.
5 S""IONETrA SOLDA " ,
Il lungo Quarantotto degli ita–
liani,
in
Storia della società italiana,
voI.
XV,
parte quinta,
Il movimento nazionale e il
1848,
pp.
259-343
(soprattutto
p.277).
6 LUIGI FEDER ICO MENA BREA,
Memorie,
a cura di
LETTERIO BRIGUG LIO e di LUIGI BULFERETTI, Firenze,
G iun ti- Barbera,
1971 ,
p.
74
e sgg.
420
7
Ibidem,
p.
79.
8 FRA CESCO MARM IROLl ,
Degli ostacoli che si vorreb–
bero frapporre al/'Unione italica,
in
«L'Italia Centrale»,
22
aprile
1848.
Sulla stampa modenese nel
'48
si veda LEO–
CADIA D ALZINI,
I giornali politici modenesi durante il
governo provvisorio del
1848,
in " Rassegna storica del
Risorgimento», XXVII
(1940 ),
fa sc. XI-XII , pp.
977 -
1012,
e
ibidem,
XXVIII (1941 ),
fase. I, pp.
21-44; A.
BER–
SELLI ,
Movimenti politici e sociali
cit., pp.
45 -57.
9
F.
MARM ll<OLl,
Degli ostacoli che si vorrebbero f rap–
porre
Clt.


















