
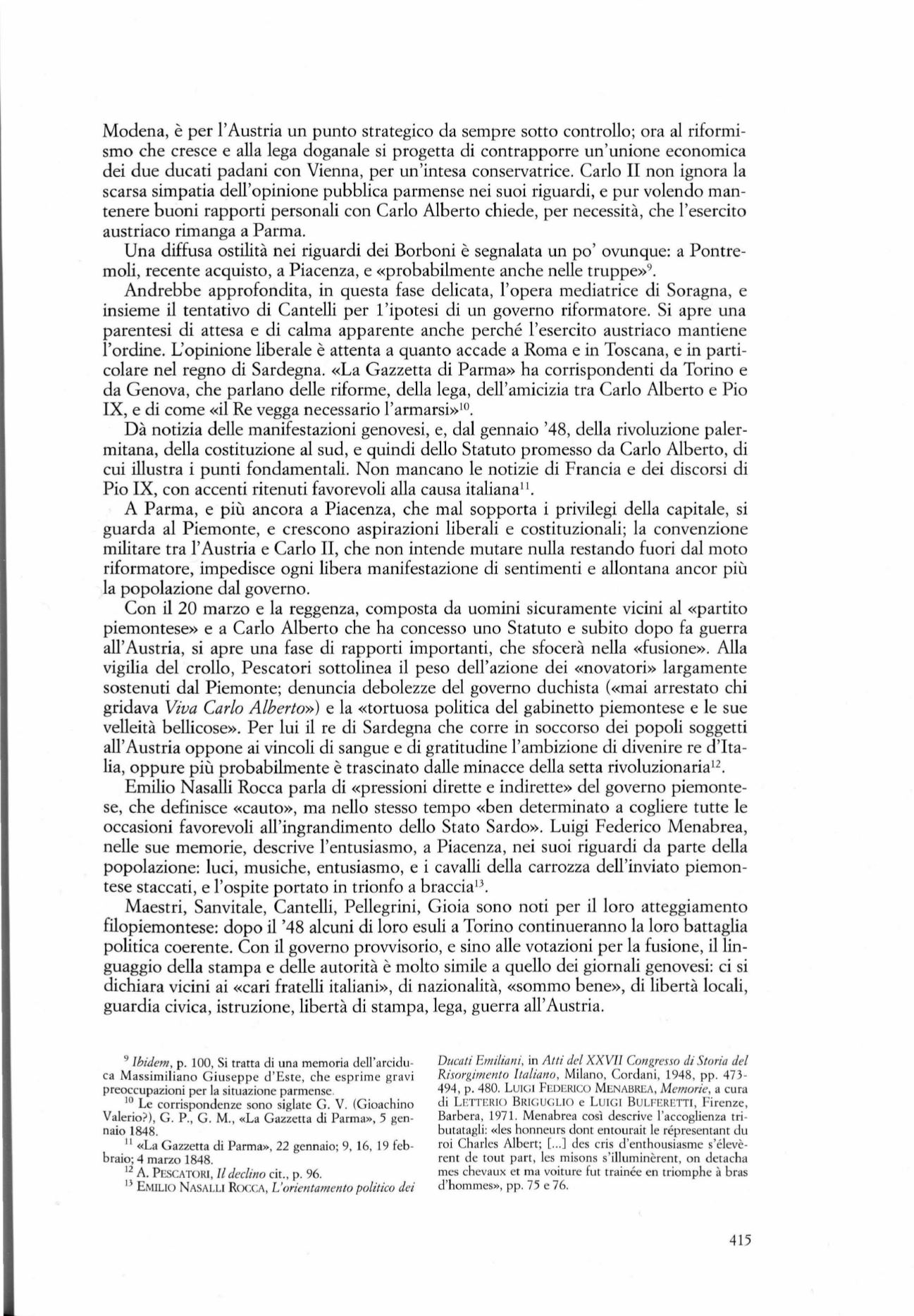
Modena, è per l'Austria un punto strategico da sempre sotto controllo; ora al riformi–
smo che cresce e alla lega doganale si progetta di contrapporre un 'unione economica
dei due ducati padani con Vienna, per un'intesa conservatrice. Carlo II non ignora la
scarsa simpatia dell'opinione pubblica parmense nei suoi riguardi, e pur volendo man–
tenere buoni rapporti personali con Carlo Alberto chiede, per necessità, che l'esercito
austriaco rimanga a Parma.
Una diffusa ostilità nei riguardi dei Borboni è segnalata un po' ovunque: a Pontre–
moli, recente acquisto, a Piacenza, e «probabilmente anche nelle truppe»9.
Andrebbe approfondita, in questa fase delicata, l'opera mediatrice di Soragna, e
insieme il tentativo di Cantelli per l 'ipotesi di un governo riformatore. Si apre una
parentesi di attesa e di calma apparente anche perché l'esercito austriaco mantiene
l'ordine. L'opinione liberale
è
attenta a quanto accade a Roma e in Toscana, e in parti–
colare nel regno di Sardegna. «La Gazzetta di Parma» ha corrispondenti da Torino e
da Genova, che parlano delle riforme, della lega, dell' amicizia tra Carlo Alberto e Pio
IX, e di come «il Re vegga necessario l'armarsi» lO.
Dà notizia delle manifestazioni genovesi, e, dal gennaio '48, della rivoluzione paler–
mitana, della costituzione al sud, e quindi dello Statuto promesso da Carlo Alberto, di
cui illustra i punti fondamentali. Non mancano le notizie di Francia e dei discorsi di
Pio IX, con accenti ritenuti favorevoli alla causa italiana
II .
A Parma, e più ancora a Piacenza, che mal sopporta i privilegi della capitale, si
guarda al Piemonte, e crescono aspirazioni liberali e costituzionali; la convenzione
militare tra l'Austria e Carlo II, che non intende mutare nulla restando fuori dal moto
riformatore, impedisce ogni libera manifestazione di sentimenti e allontana ancor più
la popolazione dal governo.
Con il 20 marzo e la reggenza, composta da uomini sicuramente vicini al «partito
piemontese» e a Carlo Alberto che ha concesso uno Statuto e subito dopo fa guerra
all'Austria, si apre una fase di rapporti importanti, che sfocerà nella «fusione». Alla
vigilia del crollo, Pescatori sottolinea il peso dell' azione dei «novatori» largamente
sostenuti dal Piemonte; denuncia debolezze del governo duchista (<<mai arrestato chi
gridava
Viva Carlo Alberto»)
e la «tortuosa politica del gabinetto piemontese e le sue
velleità bellicose». Per lui il re di Sardegna che corre in soccorso dei popoli soggetti
all'Austria oppone ai vincoli di sangue e di gratitudine l'ambizione di divenire re d'Ita–
lia, oppure più probabilmente
è
trascinato dalle minacce della setta rivoluzionaria
12 •
Emilio Nasalli Rocca parla di «pressioni dirette e indirette» del governo piemonte–
se, che definisce «cauto», ma nello stesso tempo «ben determinato a cogliere tutte le
occasioni favorevoli all'ingrandimento dello Stato Sardo». Luigi Federico Menabrea,
nelle sue memorie, descrive l'entusiasmo, a Piacenza, nei suoi riguardi da parte della
popolazione: luci, musiche, entusiasmo, e i cavalli della carrozza dell'inviato piemon–
tese staccati, e l'ospite portato in trionfo a braccia
l3 •
Maestri, Sanvitale, Cantelli, Pellegrini, Gioia sono noti per il loro atteggiamento
filopiemontese: dopo il '48 alcuni di loro esuli a Torino continueranno la loro battaglia
politica coerente. Con il governo provvisorio, e sino alle votazioni per la fusione, illin–
guaggio della stampa e delle autorità
è
molto simile a quello dei giornali genovesi: ci si
dichiara vicini ai «cari fratelli italiani», di nazionalità, «sommo bene», di libertà locali,
guardia civica, istruzione, libertà di stampa, lega, guerra all'Austria.
9
Ibidem,
p. 100, Si tratta di una memoria dell'arcidu–
ca Massimiliano G iuseppe d 'Este , ch e es prime gravi
preoccupazioni per la situazione parmense.
lO
Le corrispondenze sono siglate G. V. (Gioachino
Valerio?), G . P., G . M., «La Gazzetta di Parma», 5 gen–
naio 1848.
11
«La G azzetta di Parma», 22 gennaio; 9, 16,19 feb–
braio; 4 marzo 1848.
12
A. PESCATOR.l,
Il declino
ciL , p. 96.
13
EMILIO NASALLI ROCCA,
L'orientamento politico dei
Ducati Emiliani,
in
Atti del XXVII Congresso di Storia del
Risorgimento Italiano,
Milano, Cordani, 1948, pp. 473-
494, p. 480. LUIGI FEDERICO MENABREA,
Memorie,
a cura
di LETTER10 BRIGUGLIO e LUIGI BULFERETTI, F irenze,
Barbera, 1971. Menabrea cosÌ descrive l'accoglienza tri–
butatagli: «Ies honneurs dont entourait le répresentant du
coi
Charles Albert ; [.. .
l
des cris d 'enthousiasme s'élevè–
rent de tout p art, les misons s' illuminèrent, on detacha
mes chevaux et ma voiture fut trainée en triomphe
à
b ras
d 'hommes», pp. 75 e 76.
415


















