
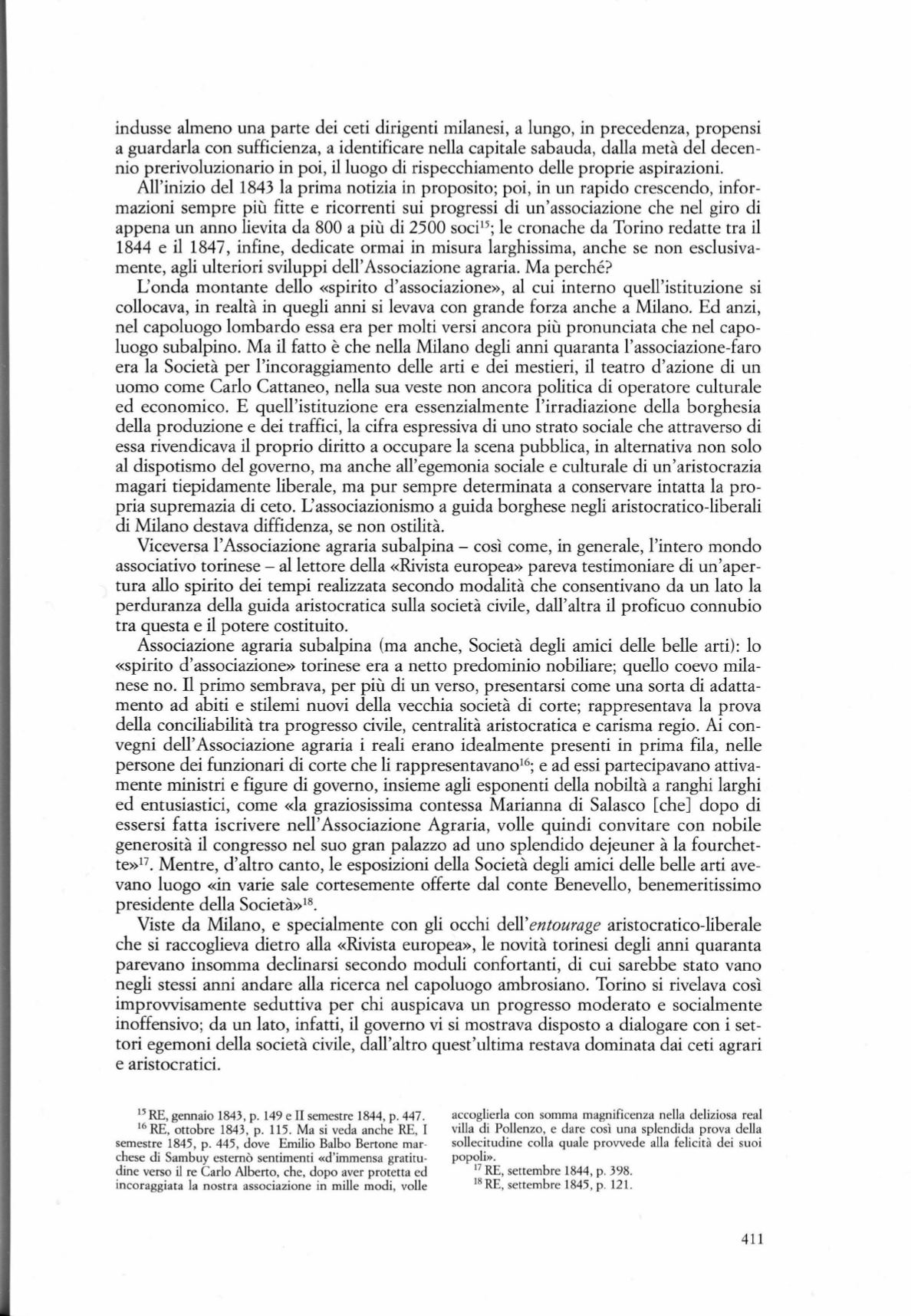
indusse almeno una parte dei ceti dirigenti milanesi, a lungo, in precedenza, propensi
a guardarla con sufficienza, a identificare nella capitale sabauda, dalla metà del decen–
nio prerivoluzionario in poi, il luogo di rispecchiamento delle proprie aspirazioni.
All'inizio del
1843
la prima notizia in proposito; poi, in un rapido crescendo, infor–
mazioni sempre più fitte e ricorrenti sui progressi di un' associazione che nel giro di
appena un anno lievita da 800 a più di 2500 soci 15 ; le cronache da Torino redatte tra il
1844
e il
1847,
infine, dedicate ormai in misura larghissima, anche se non esclusiva–
mente, agli ulteriori sviluppi dell'Associazione agraria. Ma perché?
L'onda montante dello «spirito d'associazione», al cui interno quell'istituzione si
collocava, in realtà in quegli anni si levava con grande forza anche a Milano. Ed anzi,
nel capoluogo lombardo essa era per molti versi ancora più pronunciata che nel capo–
luogo subalpino. Ma il fatto
è
che nella Milano degli anni quaranta l'associazione-faro
era la Società per l'incoraggiamento delle arti e dei mestieri, il teatro d'azione di un
uomo come Carlo Cattaneo, nella sua veste non ancora politica di operatore culturale
ed economico. E quell'istituzione era essenzialmente l'irradiazione della borghesia
della produzione e dei traffici, la cifra espressiva di uno strato sociale che attraverso di
essa rivendicava il proprio diritto a occupare la scena pubblica, in alternativa non solo
al dispotismo del governo, ma anche all' egemonia sociale e culturale di un' aristocrazia
magari tiepidamente liberale, ma pur sempre determinata a conservare intatta la pro–
pria supremazia di ceto. L'associazionismo a guida borghese negli aristocratico-liberali
di Milano destava diffidenza, se non ostilità.
Viceversa l'Associazione agraria subalpina - così come, in generale, l'intero mondo
associativo torinese - al lettore della «Rivista europea» pareva testimoniare di un' aper–
tura allo spirito dei tempi realizzata secondo modalità che consentivano da un lato la
perduranza della guida aristocratica sulla società civile, dall' altra il proficuo connubio
tra questa e il potere costituito.
Associazione agraria subalpina (ma anche, Società degli amici delle belle arti): lo
«spirito d'associazione» torinese era a netto predominio nobiliare; quello coevo mila–
nese no. Il primo sembrava, per più di un verso, presentarsi come una sorta di adatta–
mento ad abiti e stilemi nuovi della vecchia società di corte; rappresentava la prova
della conciliabilità tra progresso civile, centralità aristocratica e carisma regio. Ai con–
vegni dell'Associazione agraria i reali erano idealmente presenti in prima fila, nelle
persone dei funzionari di corte che li rappresentavano 16 ; e ad essi partecipavano attiva–
mente ministri e figure di governo, insieme agli esponenti della nobiltà a ranghi larghi
ed entusiastici, come «la graziosissima contessa Marianna di Salasco [che] dopo di
essersi fatta iscrivere nell'Associazione Agraria, volle quindi convitare con nobile
generosità il congresso nel suo gran palazzo ad uno splendido dejeuner à la fourchet–
te»17. Mentre, d'altro canto, le esposizioni della Società degli amici delle belle arti ave–
vano luogo «in varie sale cortesemente offerte dal conte Benevello, benemeritissimo
presidente della Società»18.
Viste da Milano, e specialmente con gli occhi dell'
entourage
aristocratico-liberale
che si raccoglieva dietro alla «Rivista europea», le novità torinesi degli anni quaranta
parevano insomma declinarsi secondo moduli confortanti, di cui sarebbe stato vano
negli stessi anni andare alla ricerca nel capoluogo ambrosiano. Torino si rivelava così
improvvisamente seduttiva per çhi auspicava un progresso moderato e socialmente
inoffensivo; da un lato, infatti, il governo vi si mostrava disposto a dialogare con i set–
tori egemoni della società civile, dall' altro quest'ultima restava dominata dai ceti agrari
e aristocratici.
15
RE, gennaio 1843, p. 149 e II semestre 1844, p. 447.
16
RE, ottobre 1843, p. 115. Ma si veda anche RE, I
semestre 1845, p. 445 , dove Emilio Balbo Bertone mar–
chese di Sambuy esternò sentimenti «d'immensa gratitu–
dine verso il re Carlo Alberto, che, dopo aver protetta ed
incoraggiata la nostra associazione in mille modi, volle
accoglierla con somma magnificenza nella deliziosa real
villa di Pollenzo, e dare così una splendida prova della
sollecitudine colla quale provvede alla felicità dei suoi
popoli».
17
RE, settembre 1844, p. 398.
18
RE, settembre 1845, p. 121.
411


















