
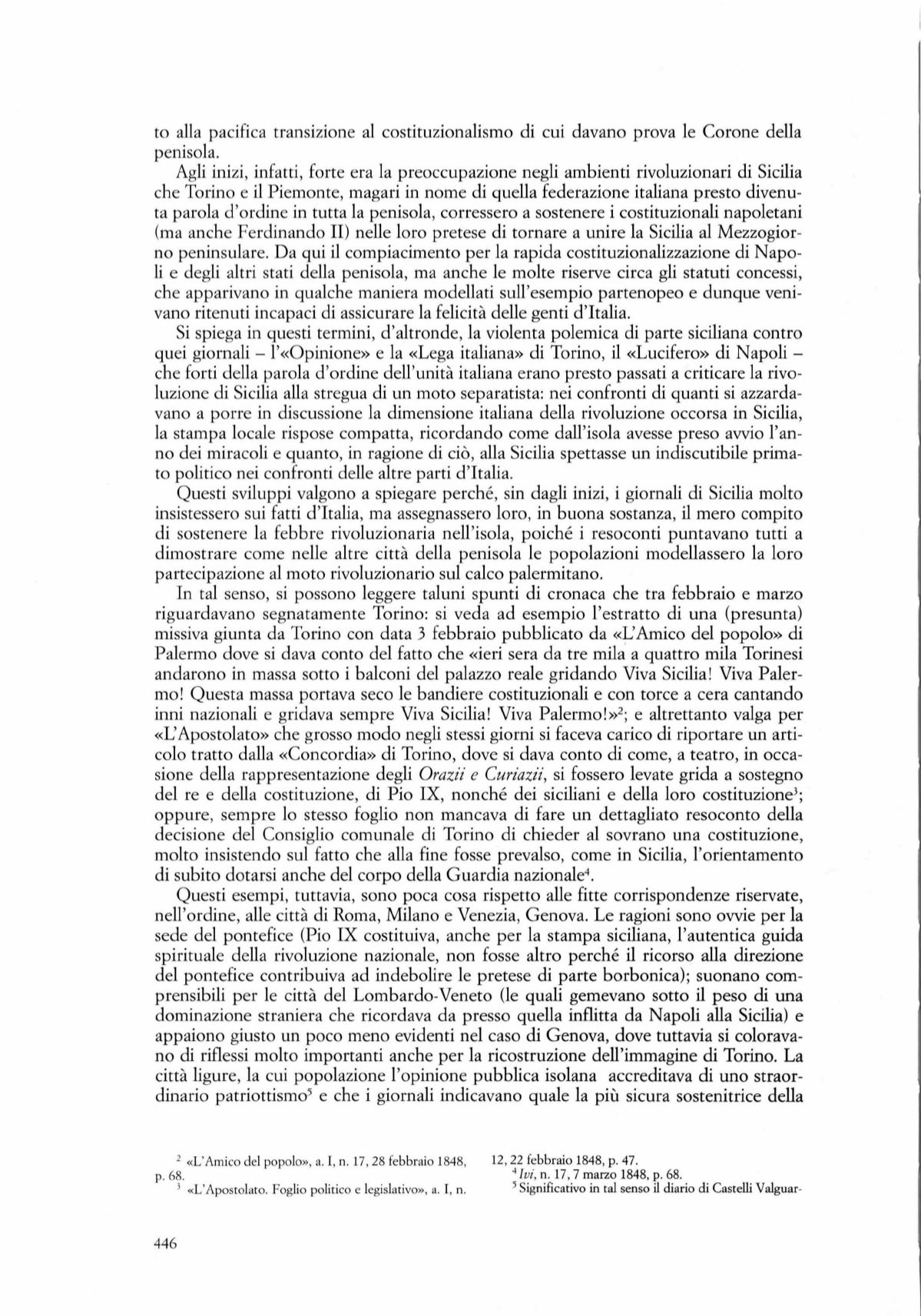
to alla pacifica transizione al costituzionalismo di cui davano prova le Corone della
penisola.
Agli inizi, infatti, forte era la preoccupazione negli ambienti rivoluzionari di Sicilia
che Torino e il Piemonte, magari in nome di quella federazione italiana presto divenu–
ta parola d'ordine in tutta la penisola, corressero a sostenere i costituzionali napoletani
(ma anche Ferdinando II) nelle loro pretese di tornare a unire la Sicilia al Mezzogior–
no peninsulare. Da qui
il
compiacimento per la rapida costituzionalizzazione di Napo–
li e degli altri stati della penisola, ma anche le molte riserve circa gli statuti concessi,
che apparivano in qualche maniera modellati sull'esempio partenopeo e dunque veni–
vano ritenuti incapaci di assicurare la felicità delle genti d'Italia.
Si spiega in questi termini, d'altronde, la violenta polemica di parte siciliana contro
quei giornali - l'«Opinione» e la «Lega italiana» di Torino,
il
«Lucifero» di Napoli -
che forti della parola d'ordine dell'unità italiana erano presto passati a criticare la rivo–
luzione di Sicilia alla stregua di un moto separatista: nei confronti di quanti si azzarda–
vano a porre in discussione la dimensione italiana della rivoluzione occorsa in Sicilia,
la stampa locale rispose compatta, ricordando come dall'isola avesse preso avvio l'an–
no dei miracoli e quanto, in ragione di ciò , alla Sicilia spettasse un indiscutibile prima–
to politico nei confronti delle altre parti d'Italia.
Questi sviluppi valgono a spiegare perché, sin dagli inizi, i giornali di Sicilia molto
insistessero sui fatti d'Italia, ma assegnassero loro, in buona sostanza, il mero compito
di sostenere la febbre rivoluzionaria nell'isola, poiché i resoconti puntavano tutti a
dimostrare come nelle altre città della penisola le popolazioni modellassero la loro
partecipazione al moto rivoluzionario sul calco palermitano.
In tal senso, si possono leggere taluni spunti di cronaca che tra febbraio e marzo
riguardavano segnatamente Torino: si veda ad esempio l'estratto di una (presunta)
missiva giunta da Torino con data 3 febbraio pubblicato da «L'Amico del popolo» di
Palermo dove si dava conto del fatto che «ieri sera da tre
mil~
a quattro mila Torinesi
andarono in massa sotto i balconi del palazzo reale gridando Viva Sicilia! Viva Paler–
mo! Questa massa portava seco le bandiere costituzionali e con torce a cera cantando
inni nazionali e gridava sempre Viva Sicilia! Viva Palermo!»2; e altrettanto valga per
«L'Apostolato» che grosso modo negli stessi giorni si faceva carico di riportare un arti–
colo tratto dalla «Concordia» di Torino, dove si dava conto di come, a teatro, in occa–
sione della rappresentazione degli
Orazii e Curiazii,
si fossero levate grida a sostegno
del re e della costituzione, di Pio IX, nonché dei siciliani e della loro costituzione);
oppure, sempre lo stesso foglio non mancava di fare un dettagliato resoconto della
decisione del Consiglio comunale di Torino di chieder al sovrano una costituzione,
molto insistendo sul fatto che alla fine fosse prevalso, come in Sicilia, l'orientamento
di subito dotarsi anche del corpo della Guardia nazionale
4 •
Questi esempi, tuttavia, sono poca cosa rispetto alle fitte corrispondenze riservate,
nell' ordine, alle città di Roma, Milano e Venezia, Genova. Le ragioni sono ovvie per la
sede del pontefice (Pio IX costituiva, anche per la stampa siciliana, l'autentica guida
spirituale della rivoluzione nazionale, non fosse altro perché il ricorso alla direzione
del pontefice contribuiva ad indebolire le pretese di parte borbonica); suonano com–
prensibili per le città del Lombardo-Veneto (le quali gemevano sotto il peso
di
una
dominazione straniera che ricordava da presso quella inflitta da Napoli alla Sicilia) e
appaiono giusto un poco meno evidenti nel caso di Genova, dove tuttavia si colorava–
no di riflessi molto importanti anche per la ricostruzione dell'immagine di Torino. La
città ligure, la cui popolazione l'opinione pubblica isolana accreditava di uno straor–
dinario patriottism0
5
e che i giornali indicavano quale la più sicura sostenitrice della
2
«L'Amico del popolo», a.
I,
n. 17, 28 febbraio 1848,
p. 68.
J
«L'Apostolato. Foglio politico e legislativo», a. I, n.
446
12, 22 febbraio 1848, p. 47.
4
Ivi,
n.
17, 7 marzo 1848, p. 68.
5
Significativo
in
ta! senso
il
diario
di
Castelli Va!guar-


















