
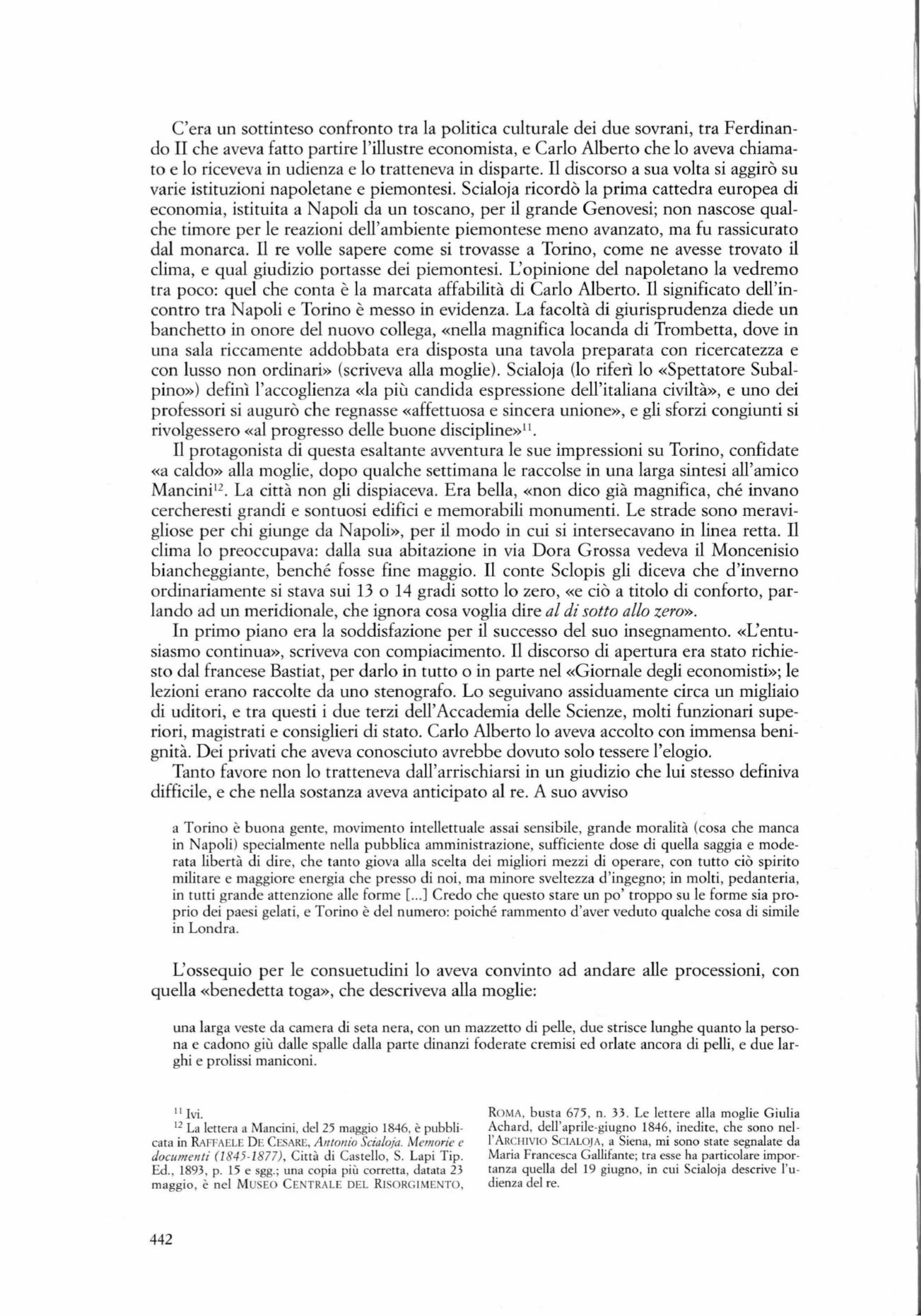
C'era un sottinteso confronto tra la politica culturale dei due sovrani, tra Ferdinan–
do II che aveva fatto partire l'illustre economista, e Carlo Alberto che lo aveva chiama–
to e lo riceveva in udienza e lo tratteneva in disparte. Il discorso a sua volta si aggirò su
varie istituzioni napoletane e piemontesi. Scialoja ricordò la prima cattedra europea di
economia, istituita a Napoli da un toscano, per il grande Genovesi; non nascose qual–
che timore per le reazioni dell'ambiente piemontese meno avanzato, ma fu rassicurato
dal monarca. Il re volle sapere come si trovasse a Torino, come ne avesse trovato il
clima, e qual giudizio portasse dei piemontesi. L'opinione del napoletano la vedremo
tra poco: quel che conta è la marcata affabilità di Carlo Alberto . Il significato dell'in–
contro tra Napoli e Torino
è
messo in evidenza. La facoltà di giurisprudenza diede un
banchetto in onore del nuovo collega, «nella magnifica locanda di Trombetta, dove in
una sala riccamente addobbata era disposta una tavola preparata con ricercatezza e
con lusso non ordinari» (scriveva alla moglie). Scialoja (lo riferì lo «Spettatore Subal–
pino») definì l'accoglienza «la più candida espressione dell'italiana civiltà», e uno dei
professori si augurò che regnasse «affettuosa e sincera unione», e gli sforzi congiunti si
rivolgessero «al progresso delle buone discipline»
I I .
Il protagonista di questa esaltante avventura le sue impressioni su Torino, confidate
«a caldo» alla moglie, dopo qualche settimana le raccolse in una larga sintesi all' amico
Mancini
l2 .
La città non gli dispiaceva. Era bella , «non dico già magnifica, ché invano
cercheresti grandi e sontuosi edifici e memorabili monumenti. Le strade sono meravi–
gliose per chi giunge da Napoli», per il modo in cui si intersecavano in linea retta. Il
clima lo preoccupava: dalla sua abitazione in via Dora Grossa vedeva il Moncenisio
biancheggiante, benché fosse fine maggio. Il conte Sclopis gli diceva che d 'inverno
ordinariamente si stava sui 13 o 14 gradi sotto lo zero, «e ciò a titolo di conforto, par–
lando ad un meridionale, che ignora cosa voglia dire
al di sotto allo zero» .
In primo piano era la soddisfazione per il successo del suo insegnamento. «L'entu–
siasmo continua», scriveva con compiacimento. Il discorso di apertura era stato richie–
sto dal francese Bastiat, per darlo in tutto o in parte nel «Giornale degli economisti»; le
lezioni erano raccolte da uno stenografo. Lo seguivano assiduamente circa un migliaio
di uditori, e tra questi i due terzi dell'Accademia delle Scienze, molti funzionari supe–
riori, magistrati e consiglieri di stato. Carlo Alberto lo aveva accolto con immensa beni–
gnità. Dei privati che aveva conosciuto avrebbe dovuto solo tessere l'elogio.
Tanto favore non lo tratteneva dall 'arrischiarsi in un giudizio che lui stesso definiva
difficile, e che nella sostanza aveva anticipato al re. A suo avviso
a Torino è buona gente, movimento intellettuale assai sensibile, grande moralità (cosa che manca
in Napoli ) specialmente nella pubblica amministrazione, sufficiente dose di quella saggia e mode–
rata libertà di dire, che tanto giova alla scelta dei migliori mezzi di operare, con tutto ciò spirito
militare e maggiore energia che presso di noi, ma minore sveltezza d'ingegno; in molti, pedanteria ,
in tutti grande attenzione alle fo rme [. ..] Credo che questo stare un po' troppo su le forme sia pro–
prio dei paesi gelati, e Torino
è
del numero: poiché rammento d'aver veduto qualche cosa di simile
in Lond ra.
L'ossequio per le consuetudini lo aveva convinto ad andare alle processioni, con
quella «benedetta toga», che descriveva alla moglie:
una larga veste da camera di seta nera, con un mazzetto di pelle, due strisce lunghe quanto la perso–
na e cadono giù dalle spalle dalla parte dinanzi foderate cremisi ed orlate ancora di pelli, e due lar–
ghi e prolissi maniconi.
I l
Ivi.
12
La lettera a Mancini, del 25 maggio 1846,
è
pubbli–
cata in RAFFAELE D ECESARE,
A ntonio Scia/afa. Memorie e
documenti
(1 845-1 877), Città d i Castello, S. Lapi T ip .
Ed., 1893, p. 15 e sgg.; una copia più corretta, datata 23
maggio ,
è
nel MUSEO C ENTRALE DEL RISORGIMENTO,
ROMA, b usta 675 , n. 33. Le lettere alla moglie G iulia
Achard , dell 'aprile-giugno 1846, inedite, che sono nel –
l'ARCHIVIO
SCIALO.lA,a Siena, mi sono state segnalate da
Maria Francesca G allifante; tra esse ha p articolare impor–
tanza quella del 19 giugno , in cui Scialoja descrive l'u–
dienza del re.
442


















