
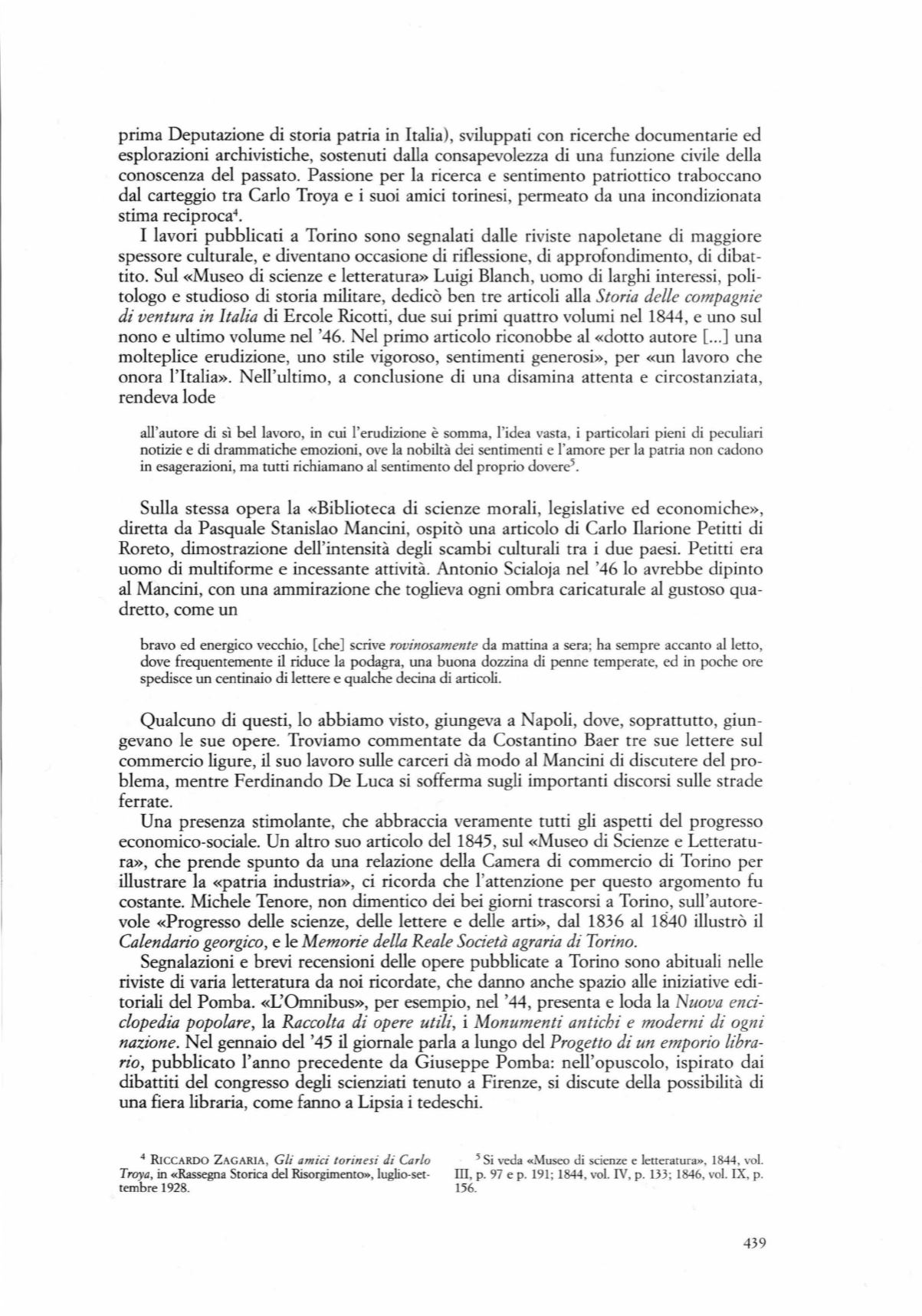
prima Deputazione di storia patria in Italia), sviluppati con ricerche documentarie ed
esplorazioni archivistiche, sostenuti dalla consapevolezza di una funzione civile della
conoscenza del passato. Passione per la ricerca e sentimento patriottico traboccano
dal carteggio tra Carlo Troya e i suoi amici torinesi, permeato da una incondizionata
stima reciproca
4 •
I lavori pubblicati a Torino sono segnalati dalle riviste napoletane di maggiore
spessore culturale, e diventano occasione di riflessione, di approfondimento, di dibat–
tito. Sul «Museo di scienze e letteratura» Luigi Blanch, uomo di larghi interessi, poli–
tologo e studioso di storia militare, dedicò ben tre articoli alla
Storia delle compagnie
di ventura in Italia
di Ercole Ricotti, due sui primi quattro volumi nel 1844, e uno sul
nono e ultimo volume nel '46. Nel primo articolo riconobbe al «dotto autore [... ] una
molteplice erudizione, uno stile vigoroso, sentimenti generosi», per «un lavoro che
onora l'Italia». Nell'ultimo, a conclusione di una disamina attenta e circostanziata,
rendeva lode
all'autore di sì bel lavoro, in cui l'erudizione è somma, l'idea vasta, i particolari pieni di peculiari
notizie e di drammatiche emozioni, ove la nobiltà dei sentimenti e l'amore per la patria non cadono
in esagerazioni, ma tutti richiamano al sentimento del proprio dovere
5 .
Sulla stessa opera la «Biblioteca di scienze morali, legislative ed economiche»,
diretta da Pasquale Stanislao Mancini, ospitò una articolo di Carlo Ilarione Petitti di
Roreto, dimostrazione dell'intensità degli scambi culturali tra i due paesi. Petitti era
uomo di multiforme e incessante attività. Antonio Scialoja nel '46 lo avrebbe dipinto
al Mancini, con una ammirazione che toglieva ogni ombra caricaturale al gustoso qua–
dretto, come un
bravo ed energico vecchio, [che] scrive
rovinosamente
da mattina a sera; ha sempre accanto alletto,
dove frequentemente il riduce la podagra, una buona dozzina di penne temperate, ed in poche ore
spedisce un centinaio di lettere e qualche decina di articoli.
Qualcuno di questi, lo abbiamo visto, giungeva a Napoli, dove, soprattutto, giun–
gevano le sue opere. Troviamo commentate da Costantino Baer tre sue lettere sul
commercio ligure, il suo lavoro sulle carceri dà modo al Mancini di discutere del pro–
blema, mentre Ferdinando De Luca si sofferma sugli importanti discorsi sulle strade
ferrate.
Una presenza stimolante, che abbraccia veramente tutti gli aspetti del progresso
economico-sociale. Un altro suo articolo del 1845, sul «Museo di Scienze e Letteratu–
ra», che prende spunto da una relazione della Camera di commercio di Torino per
illustrare la «patria industria», ci ricorda che l'attenzione per questo argomento fu
costante. Michele Tenore, non dimentico dei bei giorni trascorsi a Torino, sull' autore–
vole «Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti», dal 1836 al 1840 illustrò
il
Calendario georgico,
e le
Memorie della Reale Società agraria di Torino.
Segnalazioni e brevi recensioni delle opere pubblicate a Torino sono abituali nelle
riviste di varia letteratura da noi ricordate, che danno anche spazio alle iniziative edi–
toriali del Pomba. «L'Omnibus», per esempio, nel '44 , presenta e loda la
Nuova enci–
clopedia popolare,
la
Raccolta di opere utili,
i
Monumenti antichi e moderni di ogni
nazione.
Nel gennaio del '45 il giornale parla a lungo del
Progetto di un emporio libra–
rio,
pubblicato l'anno precedente da Giuseppe Pomba: nell' opuscolo, ispirato dai
dibattiti del congresso degli scienziati tenuto a Firenze, si discute della possibilità di
una fiera libraria, come fanno a Lipsia i tedeschi.
4 RICCARDO Z AGARIA,
Gli amici torinesi di Carlo
Troya,
in
«Rassegna Storica del Risorgimento», luglio-set–
tembre 1928.
5
Si veda «Museo di scienze e letteratura», 1844, voI.
III, p. 97 e p. 191; 1844, voI. IV, p. 133; 1846, voI. IX, p.
156.
439


















