
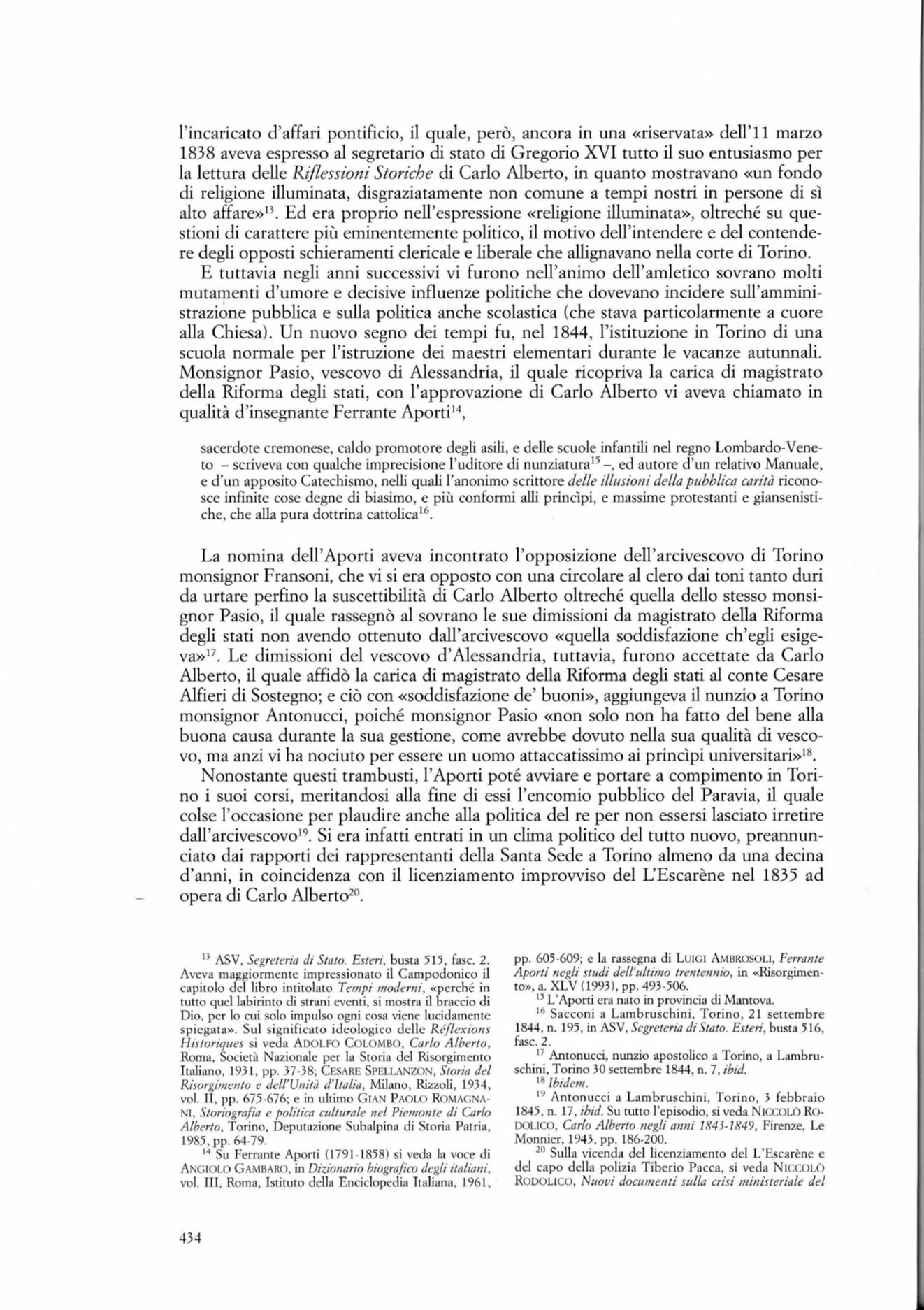
l'incaricato d'affari pontificio, il quale, però, ancora in una «riservata» dell'll marzo
1838 aveva espresso al segretario di stato di Gregorio XVI tutto il suo entusiasmo per
la lettura delle
Rzflessioni Storiche
di Carlo Alberto, in quanto mostravano «un fondo
di religione illuminata, disgraziatamente non comune a tempi nostri in persone di sÌ
alto affare»
13 •
Ed era proprio nell' espressione «religione illuminata», oltreché su que–
stioni di carattere più eminentemente politico, il motivo dell'intendere e del contende–
re degli opposti schieramenti clericale e liberale che allignavano nella corte di Torino.
E tuttavia negli anni successivi vi furono nell' animo dell' amletico sovrano molti
mutarpenti d'umore e decisive influenze politiche che dovevano incidere sull'ammini–
strazione pubblica e sulla politica anche scolastica (che stava particolarmente a cuore
alla Chiesa). Un nuovo segno dei tempi fu, nel 1844, l'istituzione in Torino di una
scuola normale per l'istruzione dei maestri elementari durante le vacanze autunnali.
Monsignor Pasio, vescovo di Alessandria, il quale ricopriva la carica di magistrato
della Riforma degli stati, con l'approvazione di Carlo Alberto vi aveva chiamato in
qualità d'insegnante Ferrante Aporti14,
sacerdote cremonese, caldo promotore degli asili, e delle scuole infantili nel regno Lombardo-Vene–
to - scriveva con qualche imprecisione l'uditore di nunziatura
15 -,
ed autore d'un relativo Manuale,
e d'un apposito Catechismo, nelli quali l'anonimo scrittore
delle illusioni della pubblica carità
ricono–
sce infinite cose degne di biasimo, e più conformi alli princìpi, e massime protestanti e giansenisti–
che, che alla pura dottrina cattolica
l6 .
La nomina dell'Aporti aveva incontrato l'opposizione dell' arcivescovo di Torino
monsignor Fransoni, che vi si era opposto con una circolare al clero dai toni tanto duri
da urtare perfino la suscettibilità di Carlo Alberto oltreché quella dello stesso monsi–
gnor Pasio, il quale rassegnò al sovrano le sue dimissioni da magistrato della Riforma
degli stati non avendo ottenuto dall' arcivescovo «quella soddisfazione ch'egli esige–
va»17. Le dimissioni del vescovo d'Alessandria, tuttavia, furono accettate da Carlo
Alberto, il quale affidò la carica di magistrato della Riforma degli stati al conte Cesare
Alfieri di Sostegno; e ciò con «soddisfazione de' buoni», aggiungeva il nunzio a Torino
monsignor Antonucci, poiché monsignor Pasio «non solo non ha fatto del bene alla
buona causa durante la sua gestione, come avrebbe dovuto nella sua qualità di vesco–
vo, ma anzi vi ha nociuto per essere un uomo attaccatissimo ai princìpi universitari»18.
Nonostante questi trambusti, l'Aporti poté avviare e portare a compimento in Tori–
no i suoi corsi, meritandosi alla fine di essi l'encomio pubblico del Paravia, il quale
colse l'occasione per pIaudire anche alla politica del re per non essersi lasciato irretire
dall'arcivescovo
I9 .
Si era infatti entrati in un clima politico del tutto nuovo, preannun–
ciato dai rapporti dei rappresentanti della Santa Sede a Torino almeno da una decina
d'anni, in coincidenza con il licenziamento improvviso del L'Escarène nel 1835 ad
opera di Carlo Albert0
20 •
13
ASV,
Segreteria di Stato. Esteri,
busta 515, fase. 2.
Aveva maggiormente impressionato il Campodonico
il
capitolo del libro intitolato
Tempi moderni,
«perché in
tutto quel labirinto di strani eventi, si mostra il braccio di
Dio, per lo cui solo impulso ogni cosa viene lucidamente
spiegata». Sul significato ideologico delle
Réflexions
Historiques
si veda ADOLFO COLOMBO,
Carlo Alberto ,
Roma, Società Nazionale per la Storia del Risorgimento
Italiano, 1931, pp. 37-38; CESARE SPELLANZON,
Storia del
Risorgimento e dell'Unità d'Italia,
Milano, Rizzoli, 1934,
voI. II, pp. 675-676; e in ultimo GIAN PAOLO ROMAGNA–
Nl,
Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo
Alberto,
Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria,
1985, pp. 64-79.
14
Su Ferrante Aporti (1791-1858) si veda la voce di
ANGIOLO GAMBARO, in
Dizionario biografico degli italiani,
voI. III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961 ,
434
pp. 605-609; e la rassegna di LUIGI AMBROSOLI,
Ferrante
Aporti negli studi dell'ultimo trentennio,
in «Risorgimen–
to», a. XLV (1993), pp. 493-506.
15
L'Aporti era nato in provincia di Mantova.
16
Sacconi a Lambruschini, Torino, 21 settembre
1844, n. 195, in ASV,
Segreteria di Stato. Esteri,
busta 516,
fase.
2.
17
Antonucci, nunzio apostolico a Torino, a Lambru–
schini, Torino 30 settembre 1844, n. 7,
ibid.
18
Ibidem.
19
Antonucci a Lambruschini, Torino, 3 febbraio
1845, n. 17,
ibid.
Su tutto l'episodio, si veda NICCOLÒ Ro–
DOLICO,
Carlo Alberto negli anni
1843-1849, Firenze, Le
Monnier, 1943 , pp. 186-200.
20
Sulla vicenda del licenziamento del L'Escarène e
del capo della polizia Tiberio Pacca, si veda NICCOLÒ
RODOLICO,
Nuovi documenti sulla crisi ministeriale del


















