
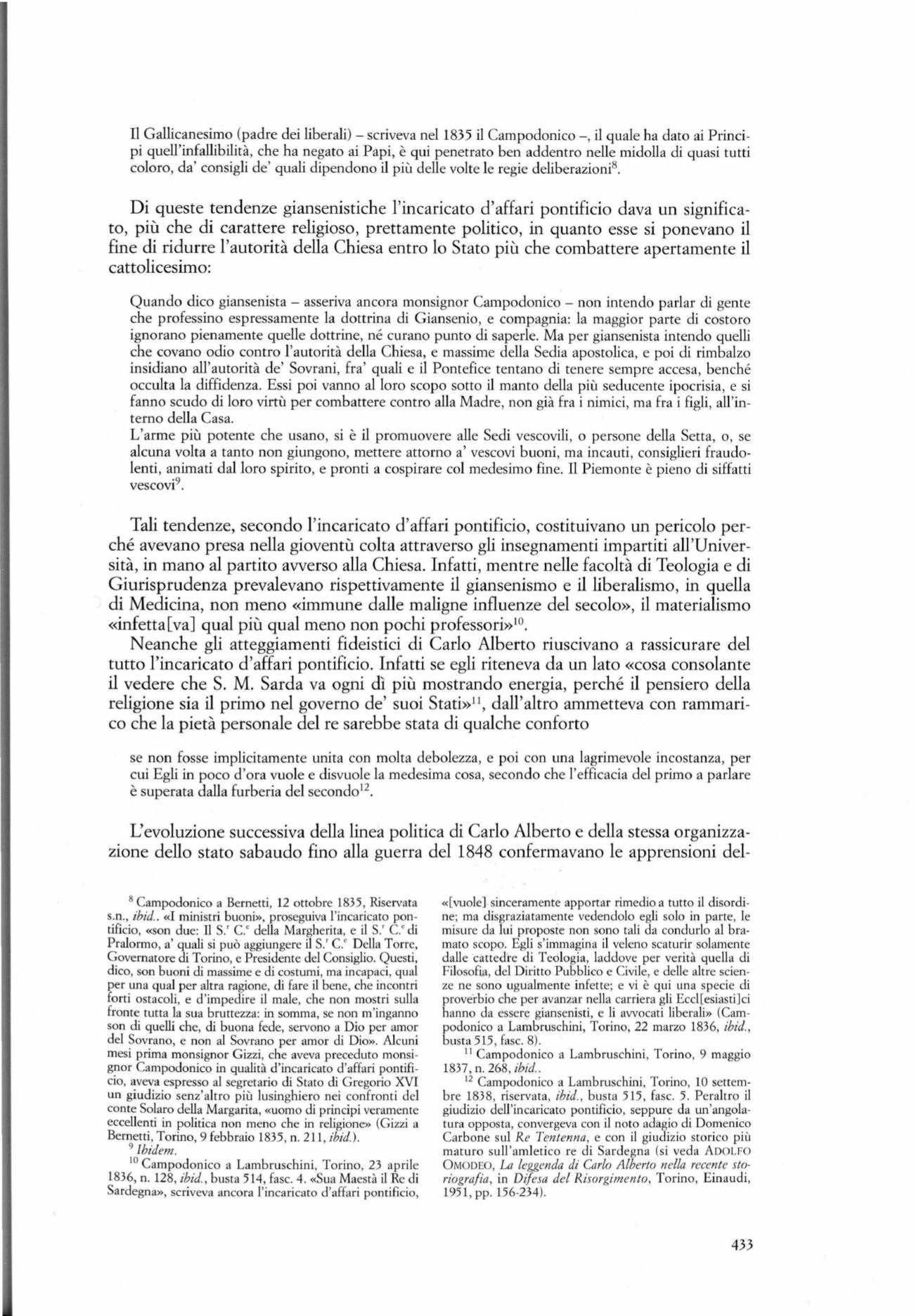
Il Gallicanesimo (padre dei liberali) - scriveva nel 1835 il Campodonico - , il quale ha dato ai Princi–
pi quell'infallibilità, che ha negato ai Papi,
è
qui penetrato ben addentro nelle midolla di quasi tutti
coloro, da' consigli de' quali dipendono
il
più delle volte le regie deliberazioni
8 .
Di queste tendenze giansenistiche l'incaricato d'affari pontificio dava un significa–
to, più che di carattere religioso, prettamente politico, in quanto esse si ponevano il
fine di ridurre 1'autorità della Chiesa entro lo Stato più che combattere apertamente il
cattolicesimo:
Quando dico giansenista - asseriva ancora monsignor Campodonico - non intendo parlar di gente
che professino espressamente la dottrina di Giansenio, e compagnia: la maggior parte di costoro
ignorano pienamente quelle dottrine, né curano punto di saperle. Ma per giansenista intendo quelli
che covano odio contro l'autorità della Chiesa, e massime della Sedia apostolica, e poi di rimbalzo
insidiano all'autorità de' Sovrani, fra' quali e il Pontefice tentano di tenere sempre accesa, benché
occulta la diffidenza. Essi poi vanno alloro scopo sotto
il
manto della più seducente ipocrisia, e si
fanno scudo di loro virtù per combattere contro alla Madre, non già fra i nimici, ma fra i figli, all'in–
terno della Casa.
L'arme più potente che usano, si è
il
promuovere alle Sedi vescovili, o persone della Setta, o, se
alcuna volta a tanto non giungono, mettere attorno a' vescovi buoni, ma incauti, consiglieri fraudo–
lenti, animati dal loro spirito, e pronti a cospirare col medesimo fine. Il Piemonte
è
pieno di siffatti
vescovi
9 .
Tali tendenze, secondo l'incaricato d'affari pontificio, costituivano un pericolo per–
ché avevano presa nella gioventù colta attraverso gli insegnamenti impartiti all'Univer–
sità, in mano al partito avverso alla Chiesa. Infatti, mentre nelle facoltà di Teologia e di
Giurisprudenza prevalevano rispettivamente il giansenismo e illiberalismo, in quella
di Medicina, non meno «immune dalle maligne influenze del secolo»,
il
materialismo
«infetta[va] qual più qual meno non pochi professori»lo.
Neanche gli atteggiamenti fideistici di Carlo Alberto riuscivano a rassicurare del
tutto l'incaricato d'affari pontificio. Infatti se egli riteneva da un lato «cosa consolante
il
vedere che S. M. Sarda va ogni dì più mostrando energia, perché il pensiero della
religione sia
il
primo nel governo de' suoi Stati»ll, dall' altro ammetteva con rammari–
co che la pietà personale del re sarebbe stata di qualche conforto
se non fosse implicitamente unita con molta debolezza, e poi con una lagrimevole incostanza, per
cui Egli in poco d'ora vuole e disvuole la medesima cosa, secondo che l'efficacia del primo a parlare
è superata dalla furberia del secondo
l2 .
L'evoluzione successiva della linea politica di
C~rlo
Alberto e della stessa organizza–
zione dello stato sabaudo fino alla guerra del 1848 confermavano le apprensioni del-
8
Campodonico a Bernetti,
12
ottobre
1835,
Riservata
s.n.,
ibid..
«I ministri buoni», proseguiva l'incaricato pon–
tificio, «son due:
li
S.'
c e
della Margherita, e il S.'
c e
di
Pralormo, a' quali si può aggiungere il S.'
c e
Della Torre,
Governatore di Torino, e Presidente del Consiglio. Questi,
dico, san buoni di massime e di costumi, ma incapaci, qual
per una qual per altra ragione, di fare il bene, che incontri
forti ostacoli, e d 'impedire il male, che non mostri sulla
fronte tutta la sua bruttezza: in somma, se non m'inganno
son di quelli che, di buona fede, servono a Dio per amor
del Sovrano, e non al Sovrano per amor di Dio». Alcuni
mesi prima monsignor G izzi, che aveva preceduto monsi–
gnor Campodonico in qualità d'incaricato d'affari pontifi·
cio, aveva espresso al segretario di Stato di Gregorio
XVI
un giudizio senz'altro più lusinghiero nei confronti del
conte Solaro della Margarita, «uomo di principi veramente
eccellenti in politica non meno che in religione» (Gizzi a
Bernetti, Torino,
9
febbraio
1835,
n.
211 ,
ibid.).
9
Ibidem.
lO
Campodonico a Lambruschini, Torino,
23
aprile
1836,
n.
128,
ibid.,
busta
514,
fase.
4.
«Sua Maestà il Re di
Sardegna», scriveva ancora l'incaricato d'affari pontificio,
«[vuole] sinceramente apportar rimedio a tutto il disordi–
ne; ma disgraziatamente vedendolo egli solo in parte, le
misure da lui proposte non sono tali da condurlo al bra–
mato scopo. Egli s'immagina il veleno scaturir solamente
dalle cattedre di Teologia, laddove per verità quella di
Filosofia, del Diritto Pubblico e Civile, e delle altre scien–
ze ne sono ugualmente infette; e vi
è
qui una specie di
provàbio che per avanzar nella carriera gli Eccl[esiasti]ci
hanno da essere giansenisti, e li avvocati liberali» (Cam–
podonico a Lambruschini, Torino,
22
marzo
1836,
ibid.,
busta
515,
fase.
8).
Il
Campodonico a Lambruschini, Torino, 9 maggio
1837,
n.
268,
ibid..
12
Campodonico a Lambruschini, Torino,
lO
settem–
bre
1838,
riservata,
ibid.,
busta
515 ,
fase.
5.
Peraltro il
giudizio dell 'incaricato pontificio, seppure da un'angola–
tura opposta, convergeva con il noto adagio di Domenico
Carbone sul
Re Tentenna,
e con il giudizio storico più
maturo sull 'amletico re di Sardegna (si veda
ADOLFO
OMODEO,
La leggenda di Carlo Alberto nella recente sto–
riogra/ia,
in
DIfesa del Risorgimento,
Torino, Einaudi,
1951 ,
pp.
156-234).
433


















