
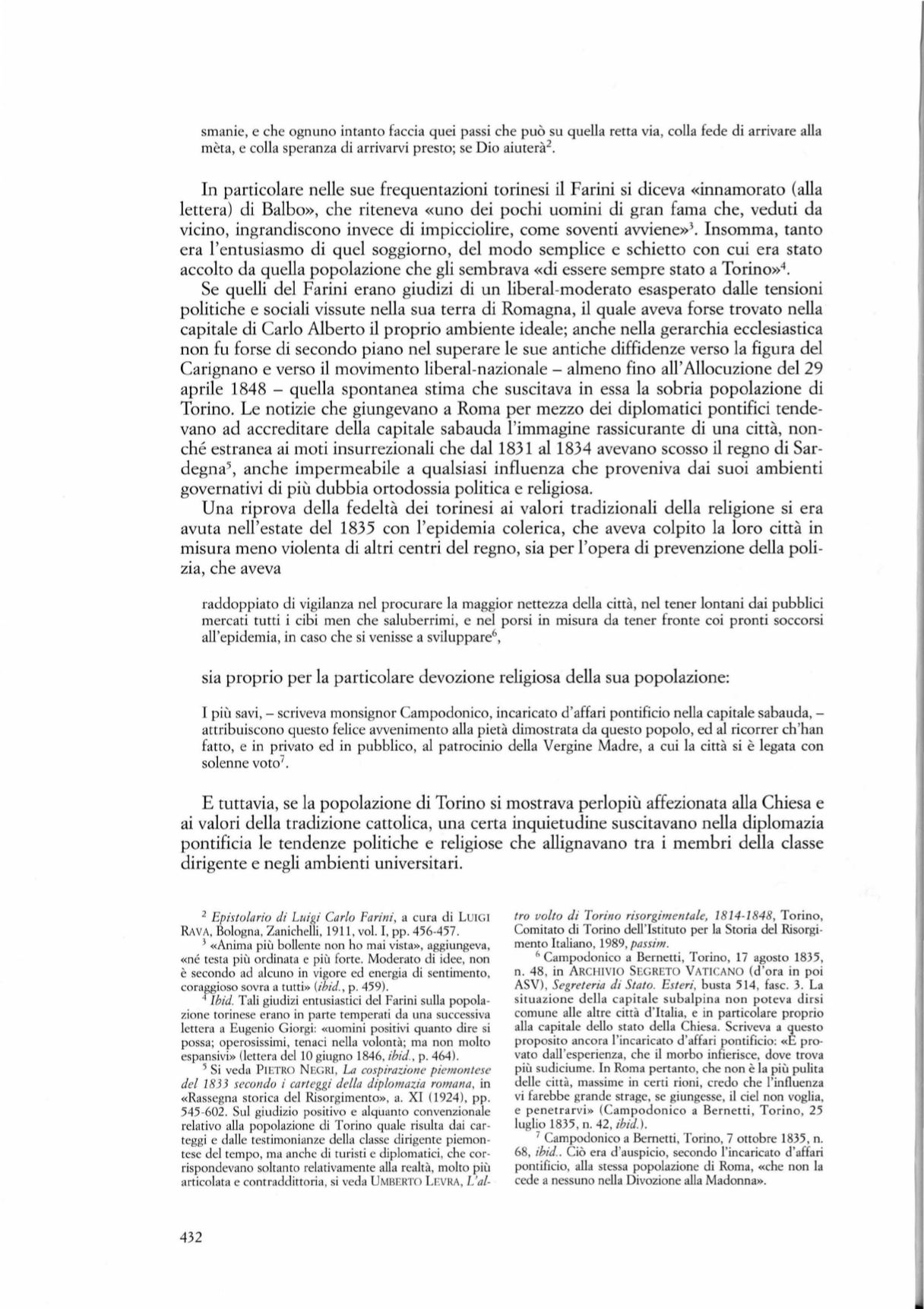
smanie, e che ognuno intanto faccia quei passi che può su quella retta via, colla fede di arrivare alla
mèta, e colla speranza di arrivarvi presto; se Dio aiuterà
2 .
In particolare nelle sue frequentazioni torinesi il Farini si diceva «innamorato (alla
lettera) di Balbo», che riteneva «uno dei pochi uomini di gran fama che, veduti da
vicino, ingrandiscono invece di impicciolire, come soventi avviene»3. Insomma, tanto
era l'entusiasmo di quel soggiorno, del modo semplice e schietto con cui era stato
accolto da quella popolazione che gli sembrava «di essere sempre stato a Torino»4.
Se quelli del Farini erano giudizi di un liberaI-moderato esasperato dalle tensioni
politiche e sociali vissute nella sua terra di Romagna,
il
quale aveva forse trovato nella
capitale di Carlo Alberto
il
proprio ambiente ideale; anche nella gerarchia ecclesiastica
non fu forse di secondo piano nel superare le sue antiche diffidenze verso la figura del
Carignano e verso
il
movimento liberaI-nazionale - almeno fino all'Allocuzione del 29
aprile
1848 -
quella spontanea stima che suscitava in essa la sobria popolazione di
Torino. Le notizie che giungevano a Roma per mezzo dei diplomatici pontifici tende–
vano ad accreditare della capitale sabauda !'immagine rassicurante di una città, non–
ché estranea ai moti insurrezionali che dal
1831
al
1834
avevano scosso il regno di Sar–
degna
5 ,
anche impermeabile a qualsiasi influenza che proveniva dai suoi ambienti
governativi di più dubbia ortodossia politica e religiosa.
Una riprova della fedeltà dei torinesi ai valori tradizionali della religione si era
avuta nell 'estate del
1835
con l'epidemia colerica, che aveva colpito la loro città in
misura meno violenta di altri centri del regno, sia per l'opera di prevenzione della poli–
zia, che aveva
raddoppiato di vigilanza nel procurare la maggior nettezza della città, nel tener lontani dai pubblici
mercati tutti i cibi men che saluberrimi, e nel porsi
in
misura da tener fronte coi pronti soccorsi
all'epidemia, in caso che si venisse a svilupparé,
sia proprio per la particolare devozione religiosa della sua popolazione:
I più savi, - scriveva monsignor Campodonico, incaricato d'affari pontificio nella capitale sabauda, –
attribuiscono questo felice avvenimento alla pietà dimostrata da questo popolo, ed al ricorrer ch'han
fatto , e in privato ed in pubblico, al patrocinio della Vergine Madre, a cui la città si è legata con
solenne voto
7 .
E tuttavia, se la popolazione di Torino si mostrava perlopiù affezionata alla Chiesa e
ai valori della tradizione cattolica, una certa inquietudine suscitavano nella diplomazia
pontificia le tendenze politiche e religiose che allignavano tra i membri della classe
dirigente e negli ambienti universitari.
2
Epistolario di Luigi Carlo Farini,
a cura di LUIGI
RAVA, Bologna, Zanichelli, 1911 , voI. I, pp. 456-457.
3
«Anima più bollente non ho mai vista», aggiungeva,
«né testa più ordinata e più forte. Moderato di idee, non
è
secondo ad alcuno in vigore ed energia di sentimento,
coraggioso sovra a tutti»
(ibid. ,
p. 459).
4
[bid.
Tali giudizi entusiastici del Farini sulla popola–
zione torinese erano in parte temperati da una successiva
lettera a Eugenio Giorgi: «uomini positivi quanto dire si
possa; operosissimi, tenaci nella volontà; ma non molto
espansivi» (lettera del lO giugno 1846,
ibid.,
p. 464).
5
Si veda P IETRO NEGRI,
La cospirazione piemontese
del
1833
secondo
i
carteggi della diplomazia romana,
in
«Rassegna storica del Risorgimento», a. XI (1924), pp.
545-602. Sul giudizio positivo e alquanto convenzionale
relativo alla popolazione di Torino quale risulta dai car–
teggi e dalle testimonianze della classe dirigente piemon–
tese del tempo, ma anche di turisti e diplomatici, che cor–
rispondevano soltanto relativamente alla realtà, molto più
articolata e contraddittoria, si veda UMBERTO
LEVI~,
L'al-
432
tra volto di Torino risorgimentale,
1814-1848, Torino,
Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgi–
mento Italiano, 1989,
passim.
6
Campodonico a Bernetti, Torino,
17
agosto 1835 ,
n. 48, in ARCHIVIO Sl"GRETO VATICANO (d 'ora in poi
ASV),
Segreteria di Stato. Esteri,
busta 514, fase. 3. La
situazione della capit ale sub alpina non poteva dirsi
comune alle altre città d'Italia, e in particolare proprio
alla capitale dello stato della Chiesa. Scriveva a questo
proposito ancora l'incaricato d'affari pontificio: «E pro–
vato dall'esperienza, che il morbo infierisce, dove trova
più sudiciume. In Roma pertanto, che non
è
la più pulita
delle città, massime in certi rioni, credo che l'influenza
vi farebbe grande strage, se giungesse,
il
ciel non voglia,
e penetrarvi» (Campod oni co a Bernetti , T orino, 25
luglio 1835 , n. 42,
ibid.) .
7
Campodonico a Bernetti, Torino, 7 ottobre 1835 , n.
68, ibid..
Ciò era d'auspicio, secondo l'incaricato d'affari
pontificio, alla stessa popolazione di Roma, «che non la
cede a nessuno nella Divozione alla Madonna».


















