
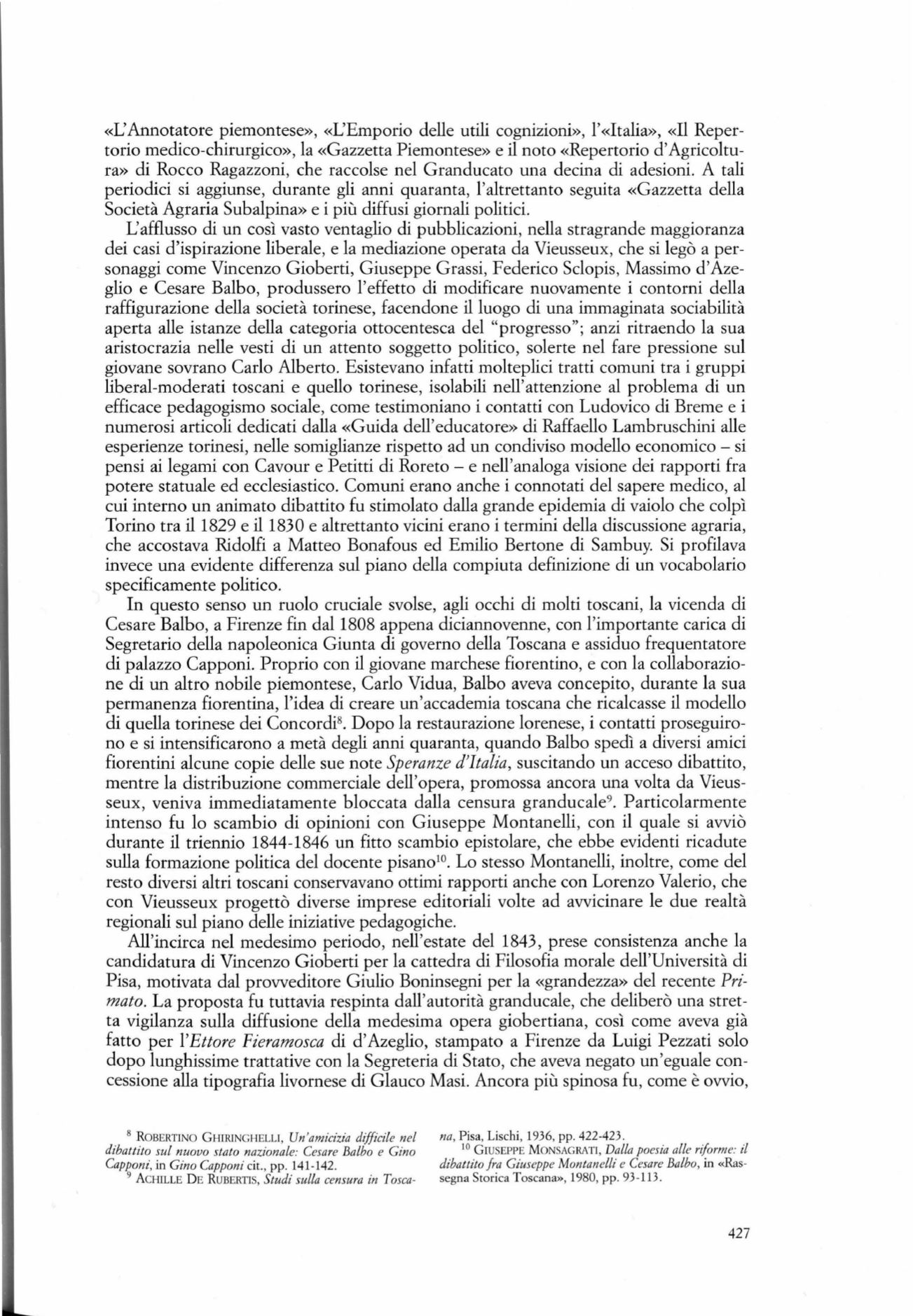
«L'Annotatore piemontese», «L'Emporio delle utili cognizioni», l' «Italia», «Il Reper–
torio medico-chirurgico», la «Gazzetta Piemontese» e
il
noto «Repertorio d'Agricoltu–
ra» di Rocco Ragazzoni, che raccolse nel Granducato una decina di adesioni. A tali
periodici si aggiunse, durante gli anni quaranta, l'altrettanto seguita «Gazzetta della
Società Agraria Subalpina» e i più diffusi giornali politici.
L'afflusso di un così vasto ventaglio di pubblicazioni, nella stragrande maggioranza
dei casi d'ispirazione liberale, e la mediazione operata da Vieusseux, che si legò a per–
sonaggi come Vincenzo Gioberti, Giuseppe Grassi, Federico Sclopis, Massimo d 'Aze–
glio e Cesare Balbo, produssero l'effetto di modificare nuovamente i contorni della
raffigurazione della società torinese, facendone il luogo di una immaginata sociabilità
aperta alle istanze della categoria ottocentesca del "progresso»; anzi ritraendo la sua
aristocrazia nelle vesti di un attento soggetto politico, solerte nel fare pressione sul
giovane sovrano Carlo Alberto. Esistevano infatti molteplici tratti comuni tra i gruppi
liberaI-moderati toscani e quello torinese, isolabili nell' attenzione al problema di un
efficace pedagogismo sociale, come testimoniano i contatti con Ludovico di Breme e i
numerosi articoli dedicati dalla «Guida dell'educatore» di Raffaello Lambruschini alle
esperienze torinesi, nelle somiglianze rispetto ad un condiviso modello economico - si
pensi ai legami con Cavour e Petitti di Roreto - e nell' analoga visione dei rapporti fra
potere statuale ed ecclesiastico. Comuni erano anche i connotati del sapere medico, al
cui interno un animato dibattito fu stimolato dalla grande epidemia di vaiolo che colpì
Torino tra il 1829 e il 1830 e altrettanto vicini erano i termini della discussione agraria,
che accostava Ridolfi a Matteo Bonafous ed Emilio Bertone di Sambuy. Si profilava
invece una evidente differenza sul piano della compiuta definizione di un vocabolario
specificamente politico.
In questo senso un ruolo cruciale svolse, agli occhi di molti toscani, la vicenda di
Cesare Balbo, a Firenze fin dal 1808 appena diciannovenne, con l'importante carica di
Segretario della napoleonica Giunta di governo della Toscana e assiduo frequentatore
di palazzo Capponi. Proprio con il giovane marchese fiorentino, e con la collaborazio–
ne di un altro nobile piemontese, Carlo Vidua, Balbo aveva concepito, durante la sua
permanenza fiorentina, l'idea di creare un 'accademia toscana che ricalcasse il modello
di quella torinese dei Concordi
8 .
Dopo la restaurazione lorenese, i contatti proseguiro–
no e si intensificarono a metà degli anni quaranta, quando Balbo spedì a diversi amici
fiorentini alcune copie delle sue note
Speranze d'Italia,
suscitando un acceso dibattito,
mentre la distribuzione commerciale dell'opera, promossa ancora una volta da Vieus–
seux, veniva immediatamente bloccata dalla censura granducale
9 •
Particolarmente
intenso fu lo scambio di opinioni con Giuseppe Montanelli, con il quale si avviò
durante il triennio 1844-1846 un fitto scambio epistolare, che ebbe evidenti ricadute
sulla formazione politica del docente pisano
10.
Lo stesso Montanelli, inoltre, come del
resto diversi altri toscani conservavano ottimi rapporti anche con Lorenzo Valerio, che
con Vieusseux progettò diverse imprese editoriali volte ad avvicinare le due realtà
regionali sul piano delle iniziative pedagogiche.
All'incirca nel medesimo periodo, nell'estate del 1843, prese consistenza anche la
candidatura di Vincenzo Gioberti per la cattedra di Filosofia morale dell'Università di
Pisa, motivata dal provveditore Giulio Boninsegni per la «grandezza» del recente
Pri–
mato.
La proposta fu tuttavia respinta dall'autorità granducale, che deliberò una stret–
ta vigilanza sulla diffusione della medesima opera giobertiana, così come aveva già
fatto per
l'Ettore Fieramosca
di d'Azeglio, stampato a Firenze da Luigi Pezzati solo
dopo lunghissime trattative con la Segreteria di Stato, che aveva negato un 'eguale con–
cessione alla tipografia livornese di Glauco Masi. Ancora più spinosa fu , come è ovvio,
8 ROBERTINO GHIRJNGHELLl,
Un'amicizia difficile nel
dibattito sul nuovo stato nazionale: Cesare Balbo e Gino
Capponi,
in
Gino Capponi
cit., pp. 141-142.
9 ACHILLE D E R UBERTIS,
Studi sulla censura in Tosca-
na,
Pisa, Lischi, 1936, pp. 422 -423.
lO
GIUSEPPE M ONSAGRATI ,
Dalla poesia alle riforme: il
dibattito fra Giuseppe Montanelli e Cesare Balbo,
in <<Ras–
segna Storica Toscana» , 1980, pp. 93- 113.
427


















