
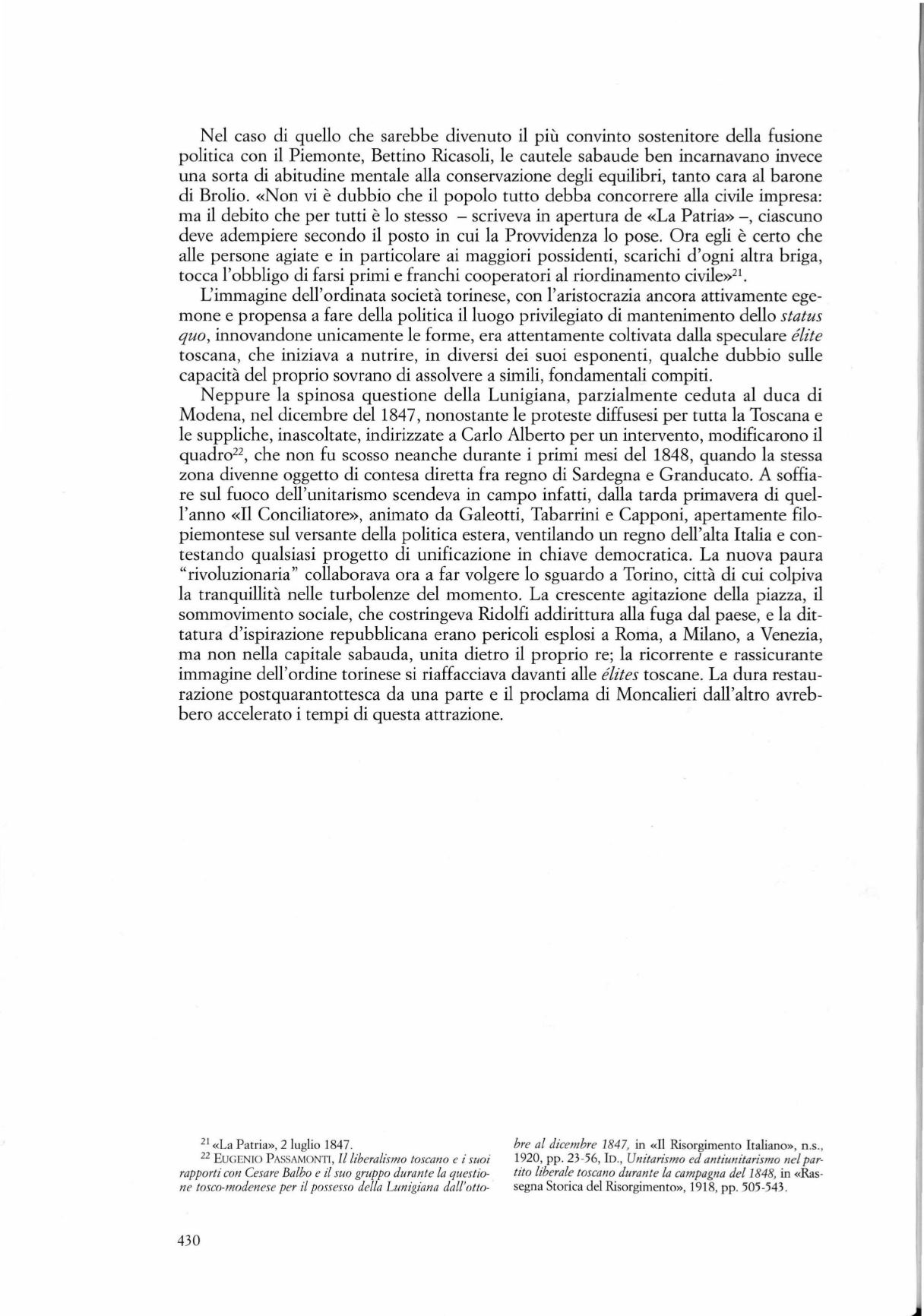
Nel caso di quello che sarebbe divenuto il più convinto sostenitore della fusione
politica con il Piemonte, Bettino Ricasoli, le cautele sabaude ben incarnavano invece
una sorta di abitudine mentale alla conservazione degli equilibri, tanto cara al barone
di Brolio. «Non vi è dubbio che il popolo tutto debba concorrere alla civile impresa:
ma il debito che per tutti è lo stesso - scriveva in apertura de «La Patria» -, ciascuno
deve adempiere secondo il posto in cui la Provvidenza lo pose. Ora egli è certo che
alle persone agiate e in particolare ai maggiori possidenti, scarichi d'ogni altra briga,
tocca l'obbligo di farsi primi e franchi cooperatori al riordinamento civile»21.
L'immagine dell'ordinata società torinese, con l'aristocrazia ancora attivamente ege–
mone e propensa a fare della politica il luogo privilegiato di mantenimento dello
status
quo,
innovandone unicamente le forme , era attentamente coltivata dalla speculare
élite
toscana, che iniziava a nutrire, in diversi dei suoi esponenti, qualche dubbio sulle
capacità del proprio sovrano di assolvere a simili, fondamentali compiti.
Neppure la spinosa questione della Lunigiana, parzialmente ceduta al duca di
Modena, nel dicembre del 1847, nonostante le proteste diffusesi per tutta la Toscana e
le suppliche, inascoltate, indirizzate a Carlo Alberto per un intervento, modificarono il
quadro
22
,
che non fu scosso neanche durante i primi mesi del 1848, quando la stessa
zona divenne oggetto di contesa diretta fra regno di Sardegna e Granducato. A soffia–
re sul fuoco dell'unitarismo scendeva in campo infatti, dalla tarda primavera di quel–
l'anno «Il Conciliatore», animato da Galeotti, Tabarrini e Capponi, apertamente filo–
piemontese sul versante della politica estera, ventilando un regno dell'alta Italia e con–
testando qualsiasi progetto di unificazione in chiave democratica. La nuova paura
"rivoluzionaria" collaborava ora a far volgere lo sguardo a Torino, città di cui colpiva
la tranquillità nelle turbolenze del momento. La crescente agitazione della piazza, il
sommovimento sociale, che costringeva Ridolfi addirittura alla fuga dal paese, e la dit–
tatura d'ispirazione repubblicana erano pericoli esplosi a Roma, a Milano, a Venezia,
ma non nella capitale sabauda, unita dietro il proprio re; la ricorrente e rassicurante
immagine dell' ordine torinese si riaffacciava davanti alle
élites
toscane. La dura restau–
razione postquarantottesca da una parte e il proclama di Moncalieri dall' altro avreb–
bero accelerato i tempi di questa attrazione.
21
«La Patria» , 2 luglio 1847.
22 EUGENIO P ASSAMONTl,
Il liberalismo toscano e
i
suoi
rapporti con Cesare Balbo e il suo gruppo durante la questio–
ne tosco-modenese per
il
possesso della Lunigiana dall'otto-
430
bre al dicembre
1847,
in
«Il
Risorgimento Italiano», n.s.,
1920,
pp.
23 -56, ID.,
Unitarismo ed antiunitarismo nel par–
tito liberale toscano durante la campagna del
1848,
in
«Ras–
segna Storica del Risorgimento», 1918,
pp.
505-543.


















