
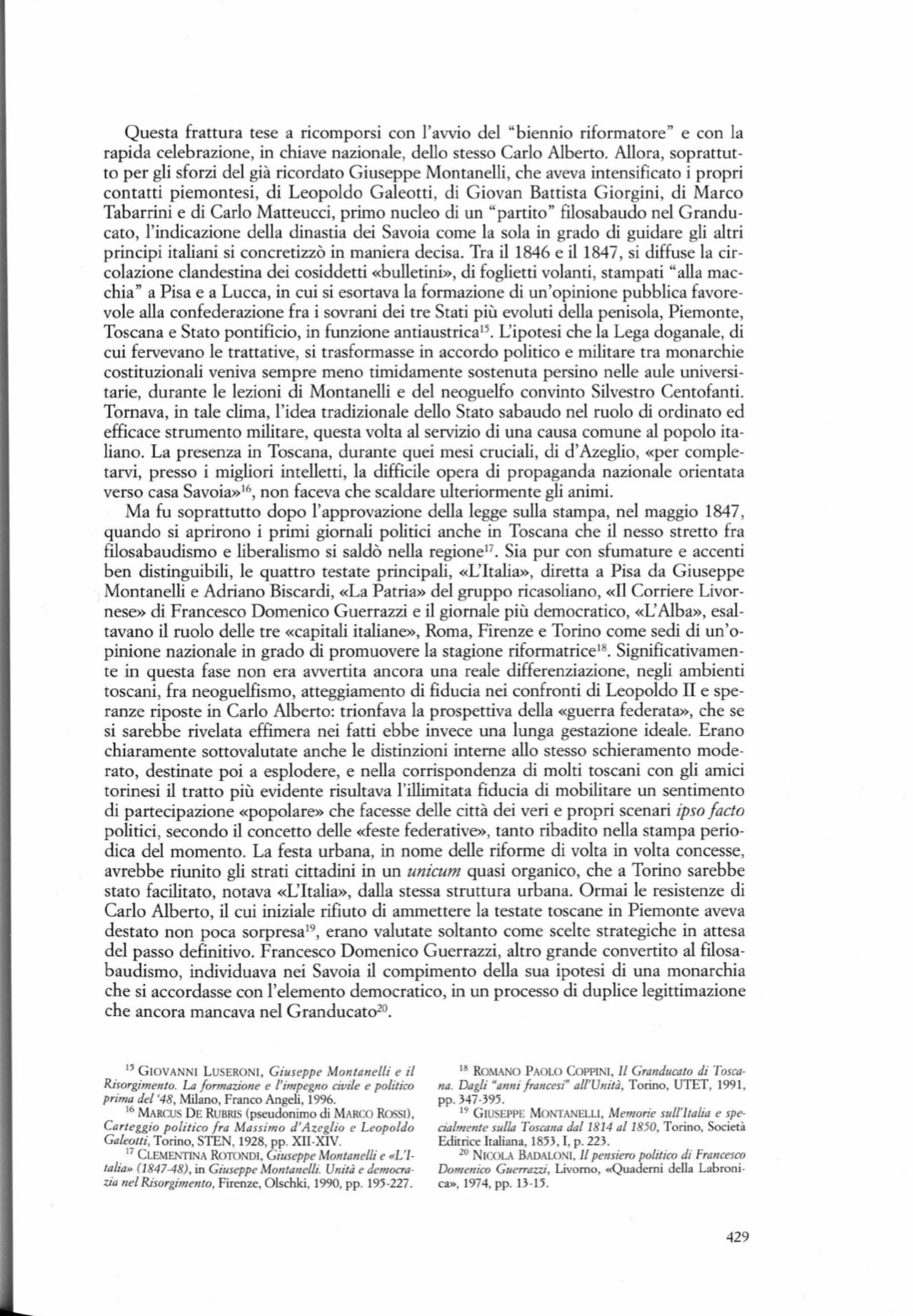
Questa frattura tese a ricomporsi con l'avvio del "biennio riformatore" e con la
rapida celebrazione, in chiave nazionale, dello stesso Carlo Alberto. Allora, soprattut–
to per gli sforzi del già ricordato Giuseppe Montanelli, che aveva intensificato i propri
contatti piemontesi, di Leopoldo Galeotti, di Giovan Battista Giorgini, di Marco
Tabarrini e di Carlo Matteucci, primo nucleo di un "partito" filosabaudo nel Grandu–
cato, l'indicazione della dinastia dei Savoia come la sola in grado di guidare gli altri
principi italiani si concretizzò in maniera decisa. Tra il
1846
e il
1847 ,
si diffuse la cir–
colazione clandestina dei cosiddetti «bulletini», di foglietti volanti, stampati "alla mac–
chia" a Pisa e a Lucca, in cui si esortava la formazione di un 'opinione pubblica favore–
vole alla confederazione fra i sovrani dei tre Stati più evoluti della penisola, Piemonte,
Toscana e Stato pontificio, in funzione antiaustrica 15. L'ipotesi che la Lega doganale, di
cui fervevano le trattative, si trasformasse in accordo politico e militare tra monarchie
costituzionali veniva sempre meno timidamente sostenuta persino nelle aule universi–
tarie, durante le lezioni di Montanelli e del neoguelfo convinto Silvestro Centofanti.
Tornava, in tale clima, l'idea tradizionale dello Stato sabaudo nel ruolo di ordinato ed
efficace strumento militare, questa volta al servizio di una causa comune al popolo ita–
liano. La presenza in Toscana, durante quei mesi cruciali, di d'Azeglio, «per comple–
tarvi, presso i migliori intelletti, la difficile opera di propaganda nazionale orientata
verso casa Savoia»16, non faceva che scaldare ulteriormente gli animi.
Ma fu soprattutto dopo l'approvazione della legge sulla stampa, nel maggio
1847,
quando si aprirono i primi giornali politici anche in Toscana che il nesso stretto fra
filosabaudismo e liberalismo si saldò nella regione
17 •
Sia pur con sfumature e accenti
ben distinguibili, le quattro testate principali, «L'Italia», diretta a Pisa da Giuseppe
Montanelli e Adriano Biscardi, «La Patria» del gruppo ricasoliano, «Il Corriere Livor–
nese» di Francesco Domenico Guerrazzi e
il
giornale più democratico, «L'Alba», esal–
tavano il ruolo delle tre «capitali italiane», Roma, Firenze e Torino come sedi di un' o–
pinione nazionale in grado di promuovere la stagione riformatrice 18. Significativamen–
te in questa fase non era avvertita ancora una reale differenziazione, negli ambienti
toscani, fra neoguelfismo, atteggiamento di fiducia nei confronti di Leopoldo II e spe–
ranze riposte in Carlo Alberto: trionfava la prospettiva della «guerra federata», che se
si sarebbe rivelata effimera nei fatti ebbe invece una lunga gestazione ideale. Erano
chiaramente sottovalutate anche le distinzioni interne allo stesso schieramento mode–
rato, destinate poi a esplodere, e nella corrispondenza di molti toscani con gli amici
torinesi
il
tratto più evidente risultava l'illimitata fiducia di mobilitare un sentimento
di partecipazione «popolare» che facesse delle città dei veri e propri scenari
ipso facto
politici, secondo il concetto delle «feste federative», tanto ribadito nella stampa perio–
dica del momento. La festa urbana, in nome delle riforme di volta in volta concesse,
avrebbe riunito gli strati cittadini in un
unicum
quasi organico, che a Torino sarebbe
stato facilitato, notava «L'Italia», dalla stessa struttura urbana. Ormai le resistenze di
Carlo Alberto, il cui iniziale rifiuto di ammettere la testate toscane in Piemonte aveva
destato non poca sorpresa 19, erano valutate soltanto come scelte strategiche in attesa
del passo definitivo. Francesco Domenico Guerrazzi, altro grande convertito al filosa–
baudismo, individuava nei Savoia
il
compimento della sua ipotesi di una monarchia
che si accordasse con l'elemento democratico, in un processo di duplice legittimazione
che ancora mancava nel Granducat0
2o •
15
G IOVANNI LUSERONI,
Giuseppe Montanelli e
il
Risorgimento. La f ormazione e l'impegno civile e politico
prima del
'48, Milano, Franco Angeli, 1996.
16
MARCUS DERUBRIS (pseudonimo di MARCO ROSSI),
Carteggio politico f ra Massimo d'A zeglio e L eopoldo
Galeotti,
Torino, STEN, 1928, pp. XII-XIV.
17
CLEMENTINA ROTONDI,
Giuseppe Montanelli e «L'I–
talia»
(1847-48), in
Giuseppe Montanelli. Unità e democra–
zia nel Risorgimento,
Firenze, Olschki, 1990, pp. 195-227.
18
ROMANO PAOLO COPPINI,
Il Granducato di Tosca–
na. Dagli "anni f rancesi" all'Unità,
Torino, UTET, 1991,
pp. 347-395.
19
G IUSEPPE MONTANELLI,
Memorie sull'Italia e spe–
cialmente sulla Toscana dal
1814
al 1850,
Torino, Società
Editrice Italiana, 1853 , I, p. 223.
20
NICOLA BADALONI,
Il pensiero politico di Francesco
Domenico Guerrazzi,
Livorno, «Quaderni della Labroni –
ca», 1974, pp. 13 -15.
429


















