
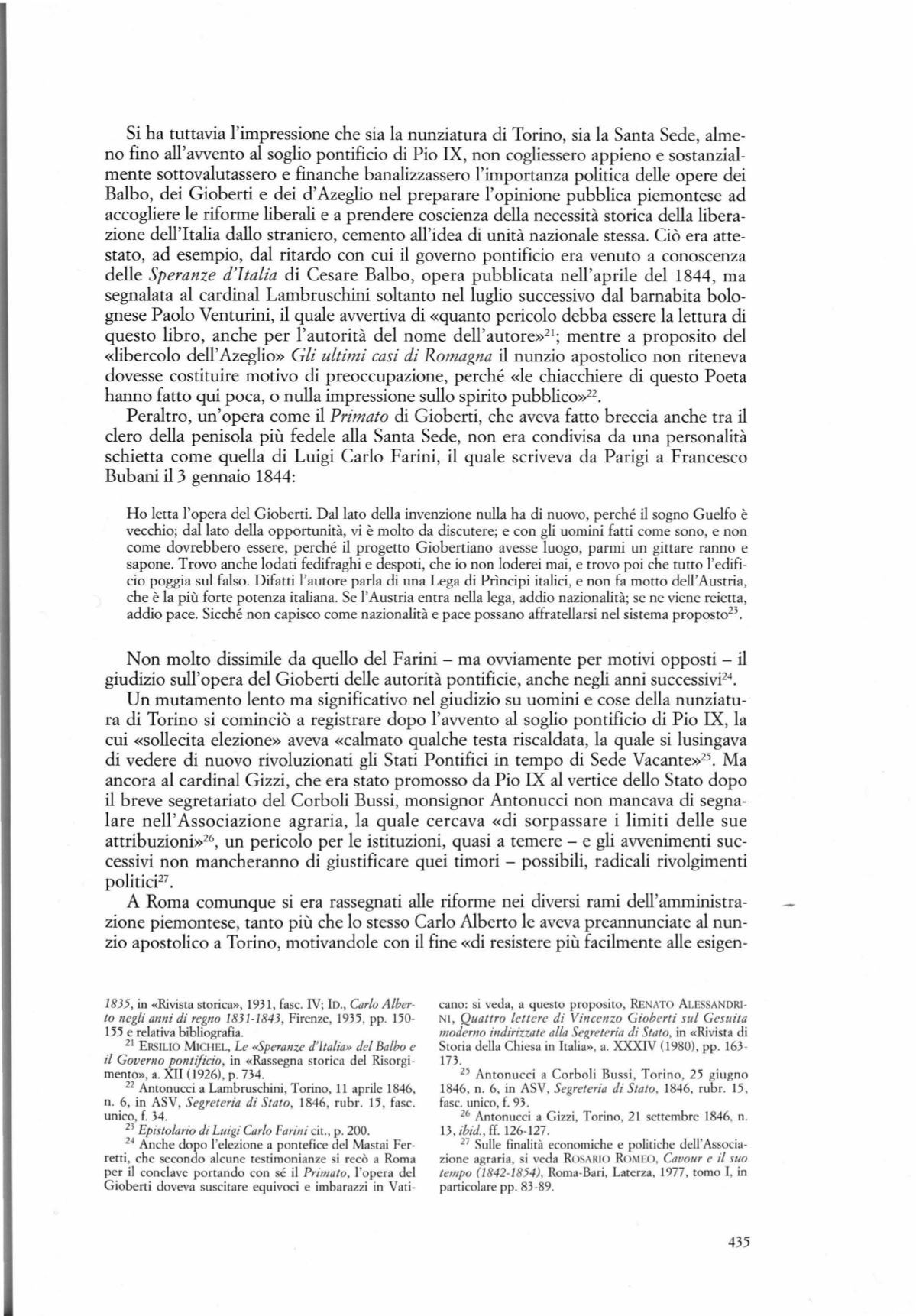
Si ha tuttavia l'impressione che sia la nunziatura di Torino, sia la Santa Sede, alme–
no fino all' avvento al soglio pontificio di Pio IX, non cogliessero appieno e sostanzial–
mente sottovalutassero e finanche banalizzassero l'importanza politica delle opere dei
Balbo, dei Gioberti e dei d'Azeglio nel preparare l'opinione pubblica piemontese ad
accogliere le riforme liberali e a prendere coscienza della necessità storica della libera–
zione dell'Italia dallo straniero, cemento all'idea di unità nazionale stessa. Ciò era atte–
stato, ad esempio, dal ritardo con cui il governo pontificio era venuto a conoscenza
delle
Speranze d'Italia
di Cesare Balbo, opera pubblicata nell 'ap rile del 1844 , ma
segnalata al cardinal Lambruschini soltanto nel luglio successivo dal barnabita bolo–
gnese Paolo Venturini, il quale avvertiva di «quanto pericolo debba essere la lettura di
questo libro, anche per l'autorità del nome dell' autore»21; mentre a proposito del
«libercolo dell'Azeglio»
Gli ultimi casi di Romagna
il nunzio apostolico non riteneva
dovesse costituire motivo di preoccupazione, perché «le chiacchiere di questo Poeta
hanno fatto qui poca, o nulla impressione sullo spirito pubblico»22 .
Peraltro, un' opera come il
Primato
di Gioberti, che aveva fatto breccia anche tra il
clero della penisola più fedele alla Santa Sede, non era condivisa da una personalità
schietta come quella di Luigi Carlo Farini, il quale scriveva da Parigi a Francesco
Bubani i13 gennaio 1844:
Ho letta l'opera del Gioberti. Dal lato della invenzione nulla ha di nuovo, perché
il
sogno Guelfo
è
vecchio; dal lato della opportunità, vi è molto da discutere; e con gli uomini fatti come sono, e non
come dovrebbero essere, perché il progetto Giobertiano avesse luogo, parmi un gittare ranno e
sapone. Trovo anche lodati fedifraghi e despoti, che io non loderei mai, e trovo poi che tutto l'edifi–
cio poggia sul falso. Difatti l'autore parla di una Lega di Prìncipi italici, e non fa motto dell'Austria,
che è la più forte potenza italiana. Se l'Austria entra nella lega, addio nazionalità; se ne viene reietta,
addio pace. Sicché non capisco come nazionalità e pace possano affratellarsi nel sistema propost0
23 .
Non molto dissimile da quello del Farini - ma ovviamente per motivi opposti - il
giudizio sull'opera del Gioberti delle autorità pontificie, anche negli anni successivi 24 .
Un mutamento lento ma significativo nel giudizio su uomini e cose della nunziatu–
ra di Torino si cominciò a registrare dopo l'avvento al soglio pontificio di Pio IX, la
cui «sollecita elezione» aveva «calmato qualche testa riscaldata, la quale si lusingava
di vedere di nuovo rivoluzionati gli Stati Pontifici in tempo di Sede Vacante»25 . Ma
ancora al cardinal Gizzi, che era stato promosso da Pio IX al vertice dello Stato dopo
il breve segretariato del Corboli Bussi, monsignor Antonucci non mancava di segna–
lare nell 'Associazione agraria, la quale cercava «di sorpassare i limiti delle sue
attribuzioni»26, un pericolo per le istituzioni, quasi a temere - e gli avvenimenti suc–
cessivi non mancheranno di giustificare quei timori - possibili, radicali rivolgimenti
politici
27 .
A Roma comunque si era rassegnati alle riforme nei diversi rami dell' amministra–
zione piemontese, tanto più che lo stesso Carlo Alberto le aveva preannunciate al nun–
zio apostolico a Torino, motivandole con il fine «di resistere più facilmente alle esigen-
1835,
in
«Rivista storica», 1931 , fase. IV; lo.,
Carlo Alber–
to negli anni di regno
1831-1843, Firenze, 1935, pp. 150-
155 e relativa bibliografia.
21
ERSILIO MICI-I EL,
Le «Speranze d'Italia» del Balbo e
il Governo pontIficio,
in «Rassegna storica del Risorgi–
mento» ,
a.
XII (1926) ,
p.
734.
22
Antonucci a Lambruschini, Torino,
11
aprile 1846,
n. 6, in ASV,
Segreteria di Stato ,
1846, rubr. 15 , fasc.
unico, f. 34.
23
Epistolario di Luigi Carlo Farini
cit., p. 200.
24
Anche dopo l'elezione a pontefice del Mastai Fer–
retti, che secondo alcune testimonianze si recò a Roma
per il conclave portando con sé il
Primato,
l'opera del
Gioberti doveva suscitare equivoci e imbarazzi in Vati-
cano: si veda, a questo proposito, RENATO ALESSANDRI–
NI,
Quattro lettere di Vincenzo Gioberti sul Gesuita
moderno indirizzate alla Segreteria di Stato,
in «Rivista di
Storia della Chiesa in Italia», a. XXXIV (1980), pp. 163·
173.
25
Antonucci
a
Corboli Bussi, To rino , 25 giugno
1846, n. 6, in ASV,
Segreteria di Stato,
1846, rubr. 15 ,
fasc. unico,
f.
93.
26
Antonucci a Gizzi, Torino, 21 settembre 1846, n.
13 , ibid.,
ff.
126-127.
27
Sulle finalità economiche e politiche dell 'Associa–
zione agraria, si veda ROSARIO ROMEO,
Cavour e il suo
tempo
(1842-1854), Roma-Bari, Laterza, 1977, tomo I, in
particolare pp. 83-89.
435


















