
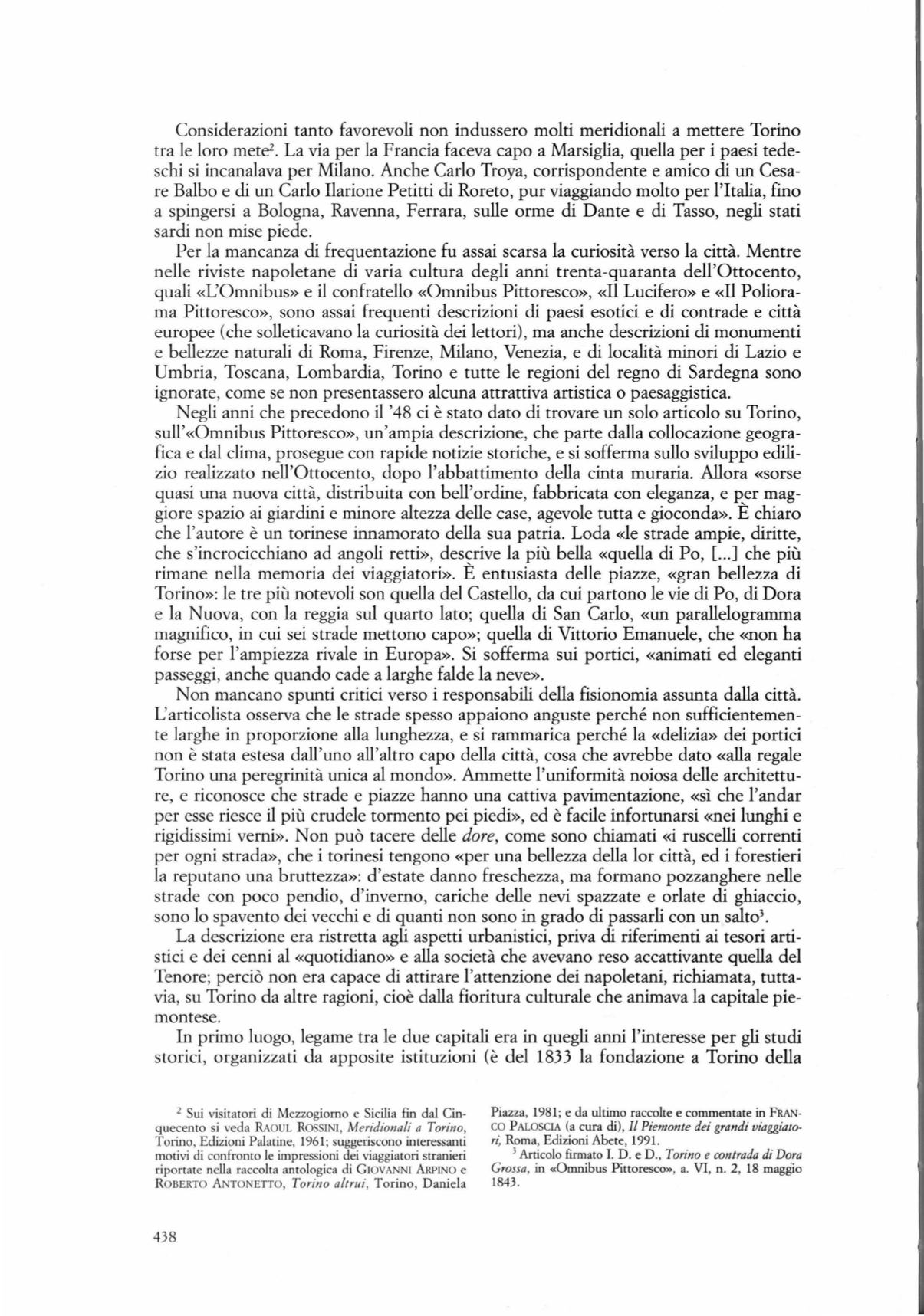
Considerazioni tanto favorevoli non indussero molti meridionali a mettere Torino
tra le loro mete2. La via per la Francia faceva capo a Marsiglia, quella per i paesi tede–
schi si incanalava per Milano. Anche Carlo Troya, corrispondente e amico di un Cesa–
re Balbo e di un Carlo Ilarione Petitti di Roreto, pur viaggiando molto per l'Italia, fino
a spingersi a Bologna, Ravenna, Ferrara, sulle orme di Dante e di Tasso, negli stati
sardi non mise piede.
Per la mancanza di frequentazione fu assai scarsa la curiosità verso la città. Mentre
nelle riviste napoletane di varia cultura degli anni trenta-quaranta dell 'Ottocento,
quali «L'Omnibus» e il confratello «Omnibus Pittoresco», «Il Lucifero» e «Il Poliora–
ma Pittoresco», sono assai frequenti descrizioni di paesi esotici e di contrade e città
europee (che solleticavano la curiosità dei lettori), ma anche descrizioni di monumenti
e bellezze naturali di Roma, Firenze, Milano, Venezia, e di località minori di Lazio e
Umbria, Toscana, Lombardia, Torino e tutte le regioni del regno di Sardegna sono
ignorate, come se non presentassero alcuna attrattiva artistica o paesaggistica.
Negli anni che precedono il '48 ci è stato dato di trovare un solo articolo su Torino,
sull'«Omnibus Pittoresco», un 'ampia descrizione, che parte dalla collocazione geogra–
fica e dal clima, prosegue con rapide notizie storiche, e si sofferma sullo sviluppo edili–
zio realizzato nell'Ottocento, dopo l'abbattimento della cinta muraria. Allora «sorse
quasi una nuova città, distribuita con bell'ordine, fabbricata con eleganza, e per mag–
giore spazio ai giardini e minore altezza delle case, agevole tutta e gioconda».
È
chiaro
che l'autore è un torinese innamorato della sua patria. Loda «le strade ampie, diritte,
che s'incrocicchiano ad angoli retti», descrive la più bella «quella di Po, [. ..] che più
rimane nella memoria dei viaggiatori».
È
entusiasta delle piazze, «gran bellezza di
Torino»: le tre più notevoli son quella del Castello, da cui partono le vie di Po, di Dora
e la Nuova, con la reggia sul quarto lato; quella di San Carlo, «un parallelogramma
magnifico, in cui sei strade mettono capo»; quella di Vittorio Emanuele, che «non ha
forse per l'ampiezza rivale in Europa» . Si sofferma sui portici, «animati ed eleganti
passeggi, anche quando cade a larghe falde la neve».
Non mancano spunti critici verso i responsabili della fisionomia assunta dalla città.
L'articolista osserva che le strade spesso appaiono anguste perché non sufficientemen–
te larghe in proporzione alla lunghezza, e si rammarica perché la «delizia» dei portici
non è stata estesa dall'uno all' altro capo della città, cosa che avrebbe dato «alla regale
Torino una peregrinità unica al mondo». Ammette l'uniformità noiosa delle architettu–
re, e riconosce che strade e piazze hanno una cattiva pavimentazione, «sÌ che l'andar
per esse riesce il più crudele tormento pei piedi», ed è facile infortunarsi «nei lunghi e
rigidissimi verni». Non può tacere delle
dare,
come sono chiamati «i ruscelli correnti
per ogni strada», che i torinesi tengono «per una bellezza della lor città, ed i forestieri
la reputano una bruttezza»: d 'estate danno freschezza, ma formano pozzanghere nelle
strade con poco pendio, d 'inverno, cariche delle nevi spazzate e orlate di ghiaccio,
sono lo spavento dei vecchi e di quanti non sono in grado di passarli con un salto
3 .
La descrizione era ristretta agli aspetti urbanistici, priva di riferimenti ai tesori arti–
stici e dei cenni al «quotidiano» e alla società che avevano reso accattivante quella del
Tenore; perciò non era capace di attirare l'attenzione dei napoletani, richiamata, tutta–
via, su Torino da altre ragioni, cioè dalla fioritura culturale che animava la capitale pie–
montese.
In primo luogo, legame tra le due capitali era in quegli anni l'interesse per gli studi
storici, organizzati da apposite istituzioni (è del 1833 la fondazione a Torino della
2
Sui visitatori di Mezzogiorno e Sicilia fin dal Cin–
q uecento si veda RAOUL ROSSINI,
Meridionali a Torino,
Torino, Edizioni Palatine, 1961; suggeriscono interessanti
motivi di confronto le impressioni dei viaggiatori stranieri
riportate nella raccolta antologica di GIOVANNI ARPINO e
ROBERTO ANTONETTO,
Torino altrui,
Torino, Daniela
438
Piazza, 1981; e da ultimo raccolte e commentate in FRAN–
co
PALOSCIA (a cura
di) ,
Il Piemonte dei grandi viaggiato–
rz;
Roma, Edizioni Abete, 1991.
J
Articolo firmato
1.
D. e D.,
Torino e contrada di Dora
Grossa ,
in «Omnibus Pittoresco», a. VI, n. 2, 18 maggio
1843.


















