
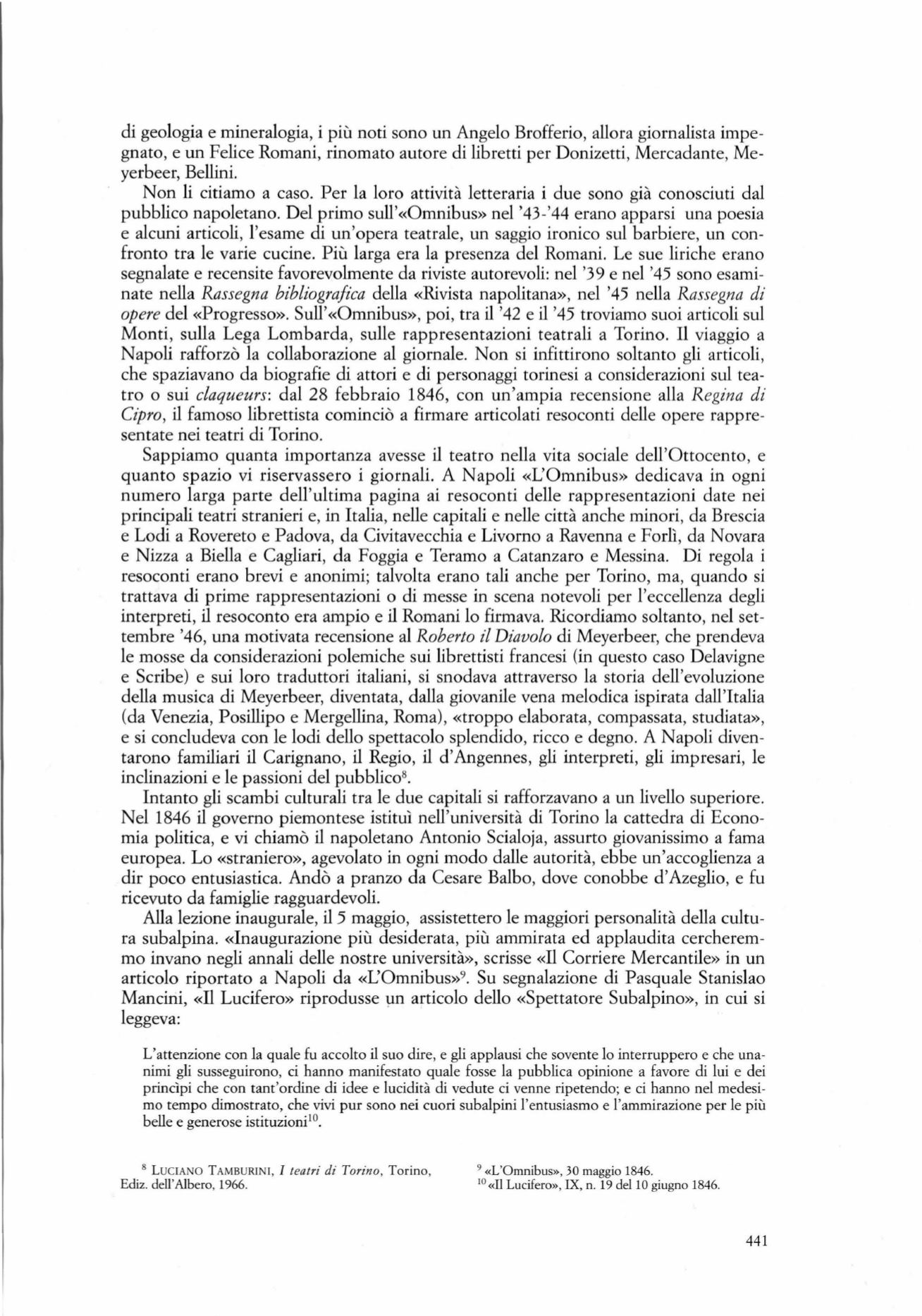
di geologia e mineralogia, i più noti sono un Angelo Brofferio, allora giornalista impe–
gnato, e un Felice Romani, rinomato autore di libretti per Donizetti, Mercadante, Me–
yerbeer, Bellini.
Non li citiamo a caso. Per la loro attività letteraria i due sono già conosciuti dal
pubblico napoletano. Del primo sull'«Omnibus» nel '43-'44 erano apparsi una poesia
e alcuni articoli, l'esame di un'opera teatrale, un saggio ironico sul barbiere, un con–
fronto tra le varie cucine. Più larga era la presenza del Romani. Le sue liriche erano
segnalate e recensite favorevolmente da riviste autorevoli: nel '39 e nel '45 sono esami–
nate nella
Rassegna bibliografica
della «Rivista napolitana», nel '45 nella
Rassegna di
opere
del «Progresso». Sull'«Omnibus», poi, tra il '42 e il '45 troviamo suoi articoli sul
Monti, sulla Lega Lombarda, sulle rappresentazioni teatrali a Torino. Il viaggio a
Napoli rafforzò la collaborazione al giornale. Non si infittirono soltanto gli articoli,
che spaziavano da biografie di attori e di personaggi torinesi a considerazioni sul tea–
tro o sui
claqueurs:
dal 28 febbraio 1846, con un'ampia recensione alla
Regina di
Cipro,
il famoso librettista cominciò a firmare articolati resoconti delle opere rappre–
sentate nei teatri di Torino.
Sappiamo quanta importanza avesse il teatro nella vita sociale dell'Ottocento, e
quanto spazio vi riservassero i giornali. A Napoli «L'Omnibus» dedicava in ogni
numero larga parte dell'ultima pagina ai resoconti delle rappresentazioni date nei
principali teatri stranieri e, in Italia, nelle capitali e nelle città anche minori, da Brescia
e Lodi a Rovereto e Padova, da Civitavecchia e Livorno a Ravenna e ForlÌ, da Novara
e Nizza a Biella e Cagliari, da Foggia e Teramo a Catanzaro e Messina. Di regola i
resoconti erano brevi e anonimi; talvolta erano tali anche per Torino, ma, quando si
trattava di prime rappresentazioni o di messe in scena notevoli per l'eccellenza degli
interpreti, il resoconto era ampio e il Romani lo firmava. Ricordiamo soltanto, nel set–
tembre '46, una motivata recensione al
Roberto il Diavolo
di Meyerbeer, che prendeva
le mosse da considerazioni polemiche sui librettisti francesi (in questo caso Delavigne
e Scribe) e sui loro traduttori italiani, si snodava attraverso la storia dell'evoluzione
della musica di Meyerbeer, diventata, dalla giovanile vena melodica ispirata dall'Italia
(da Venezia, Posillipo e Mergellina, Roma), «troppo elaborata, compassata, studiata»,
e si concludeva con le lodi dello spettacolo splendido, ricco e degno. A Napoli diven–
tarono familiari il Carignano, il Regio, il d'Angennes, gli interpreti, gli impresari, le
inclinazioni e le passioni del pubblic0
8 .
Intanto gli scambi culturali tra le due capitali si rafforzavano a un livello superiore.
Nel 1846 il governo piemontese istituÌ nell'università di Torino la cattedra di Econo–
mia politica, e vi chiamò il napoletano Antonio Scialoja, assurto giovanissimo a fama
europea. Lo «straniero», agevolato in ogni modo dalle autorità, ebbe un' accoglienza a
dir poco entusiastica. Andò a pranzo da Cesare Balbo, dove conobbe d'Azeglio, e fu
ricevuto da famiglie ragguardevoli.
Alla lezione inaugurale, il5 maggio, assistettero le maggiori personalità della cultu–
ra subalpina. «Inaugurazione più desiderata, più ammirata ed applaudita cercherem–
mo invano negli annali delle nostre università», scrisse «TI Corriere Mercantile» in un
articolo riportato a Napoli da «L'Omnibus»9. Su segnalazione di Pasquale Stanislao
Mancirii, «TI Lucifero» riprodusse lln articolo dello «Spettatore Subalpino», in cui si
leggeva:
L'attenzione con la quale fu accolto
il
suo dire, e gli applausi che sovente lo interruppero e che una–
nimi gli susseguirono, ci hanno manifestato quale fosse la pubblica opinione a favore di lui e dei
princìpi che con tant'ordine di idee e lucidità di vedute ci venne ripetendo; e ci hanno nel medesi–
mo tempo dimostrato, che vivi pur sono nei cuori subalpini l'entusiasmo e l'ammirazione per le più
belle e generose istituzioni
lO.
8
LUCIANO TAMBURI NI,
I teatri di Torino,
Torino,
Ediz. dell'Albero, 1966.
9
«L'Omnibus», 30 maggio 1846.
IO
"Il Lucifero», IX, n. 19 dellO giugno 1846.
441


















