
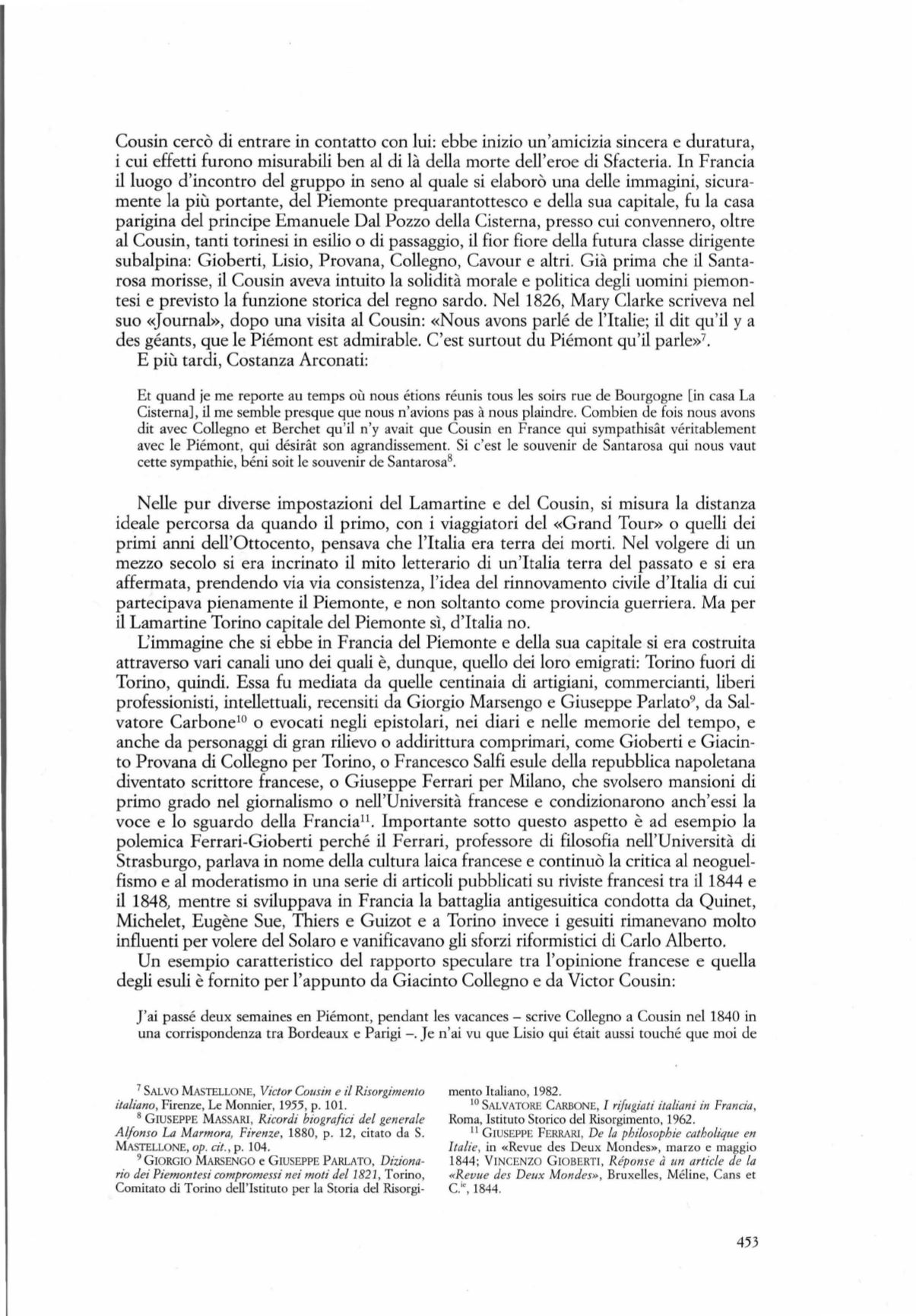
Cousin cercò di entrare in contatto con lui: ebbe inizio un 'amicizia sincera e duratura,
i cui effetti furono misurabili ben al di là della morte dell'eroe di Sfacteria. In Francia
il luogo d 'incontro del gruppo in seno al quale si elaborò una delle immagini, sicura–
mente la più portante, del Piemonte prequarantottesco e della sua capitale, fu la casa
parigina del principe Emanuele Dal Pozzo della Cisterna, presso cui convennero, oltre
al Cousin, tanti torinesi in esilio o di passaggio, il fior fiore della futura classe dirigente
subalpina: Gioberti, Lisio, Provana, Collegno, Cavour e altri. Già prima che il Santa–
rosa morisse, il Cousin aveva intuito la solidità morale e politica degli uomini piemon–
tesi e previsto la funzione storica del regno sardo. Nel 1826, Mary Clarke scriveva nel
suo «Journal», dopo una visita al Cousin: «Nous avons parlé de l'Italie; il dit qu'il y a
des géants, que le Piémont est admirable. C'est surtout du Piémont qu'il parle»7.
E più tardi, Costanza Arconati:
Et quand je me reporte au temps où nous étions réunis tous les soirs me de Bourgogne [in casa La
Cisterna] , il me semble presque que nous n'avions pas
à
nous plaindre. Combien de fois nous avons
dit avec Collegno et Berchet qu'il n'y avait que Cousin en France qui sympathisat véritablement
avec le Piémont, qui désirat son agrandissement. Si c'est le souvenir de Santarosa qui nous vaut
cette sympathie, héni soit le souvenir de Santarosa
8 .
Nelle pur diverse impostazioni del Lamartine e del Cousin, si misura la distanza
ideale percorsa da quando il primo, con i viaggiatori del «Grand Tour» o quelli dei
primi anni dell'Ottocento, pensava che l'Italia era terra dei morti. Nel volgere di un
mezzo secolo si era incrinato il mito letterario di un'Italia terra del passato e si era
affermata, prendendo via via consistenza, !'idea del rinnovamento civile d'Italia di cui
partecipava pienamente il Piemonte, e non soltanto come provincia guerriera. Ma per
il Lamartine Torino capitale del Piemonte sì, d 'Italia no.
L'immagine che si ebbe in Francia del Piemonte e della sua capitale si era costruita
attraverso vari canali uno dei quali è, dunque, quello dei loro emigrati: Torino fuori di
Torino, quindi. Essa fu mediata da quelle centinaia di artigiani, commercianti, liberi
professionisti, intellettuali, recensiti da Giorgio Marsengo e Giuseppe Parlat0
9 ,
da Sal–
vatore Carbone
lO
o evocati negli epistolari, nei diari e nelle memorie del tempo , e
anche da personaggi di gran rilievo o addirittura comprimari, come Gioberti e Giacin–
to Provana di Collegno per Torino, o Francesco Salfi esule della repubblica napoletana
diventato scrittore francese , o Giuseppe Ferrari per Milano, che svolsero mansioni di
primo grado nel giornalismo o nell'Università francese e condizionarono anch'essi la
voce e lo sguardo della Francia
ll
.
Importante sotto questo aspetto è ad esempio la
polemica Ferrari-Gioberti perché il Ferrari, professore di filosofia nell'Università di
Strasburgo, parlava in nome della cultura laica francese e continuò la critica al neoguel–
fismo e al moderatismo in una serie
di
articoli pubblicati su riviste francesi tra il 1844 e
il 1848) mentre si sviluppava in Francia la battaglia antigesuitica condotta da Quinet,
Michelet, Eugène Sue, Thiers e Guizot e a Torino invece i gesuiti rimanevano molto
influenti per volere del Solaro e vanificavano gli sforzi riformistici di Carlo Alberto.
Un esempio caratteristico del rapporto speculare tra
l'opinione
francese e quella
degli esuli è fornito per l'appunto da Giacinto Collegno e da Victor Cousin:
l'ai passé deux semaines en Piémont, pendant les vacances - scrive Collegno a Cousin nel 1840 in
una corrispondenza tra Bordeaux e Parigi - . Je n'ai vu que Lisio qui était aussi touché que moi de
7
SALVO MASTELLONE,
Vietar Cousin e il Risorgimento
italiano,
Firenze, Le Monnier, 1955, p. 1Ol.
8
GIUSEPPE MASSARI,
R icordi biografici del generale
A lfon so La Marmora, Firenze,
1880, p. 12, citato da S.
MASTELLONE,
op. cit.,
p. 104.
9
GIORGIO MARSENGO e GIUSEPPE PARLATO,
Diziona–
rio dei Piemontesi compromessi nei moti del
1821, Torino,
Comitato
di
Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgi-
mento Italiano, 1982.
lO
SALVATORE CARBONE,
I rifugiati italiani in Francia ,
Roma, Istituto Storico del Risorgimento, 1962.
11
GIUSEPPE FERRARI,
De la philosophie catholique en
Italie,
in «Revue des Deux Mondes», marzo e maggio
1844 ; VINCENZO GIOBERTI ,
Réponse
à
un artide de la
«Revue des Deux Mondes»,
Bruxelles, Méline, Cans et
Ci" 1844.
453


















