
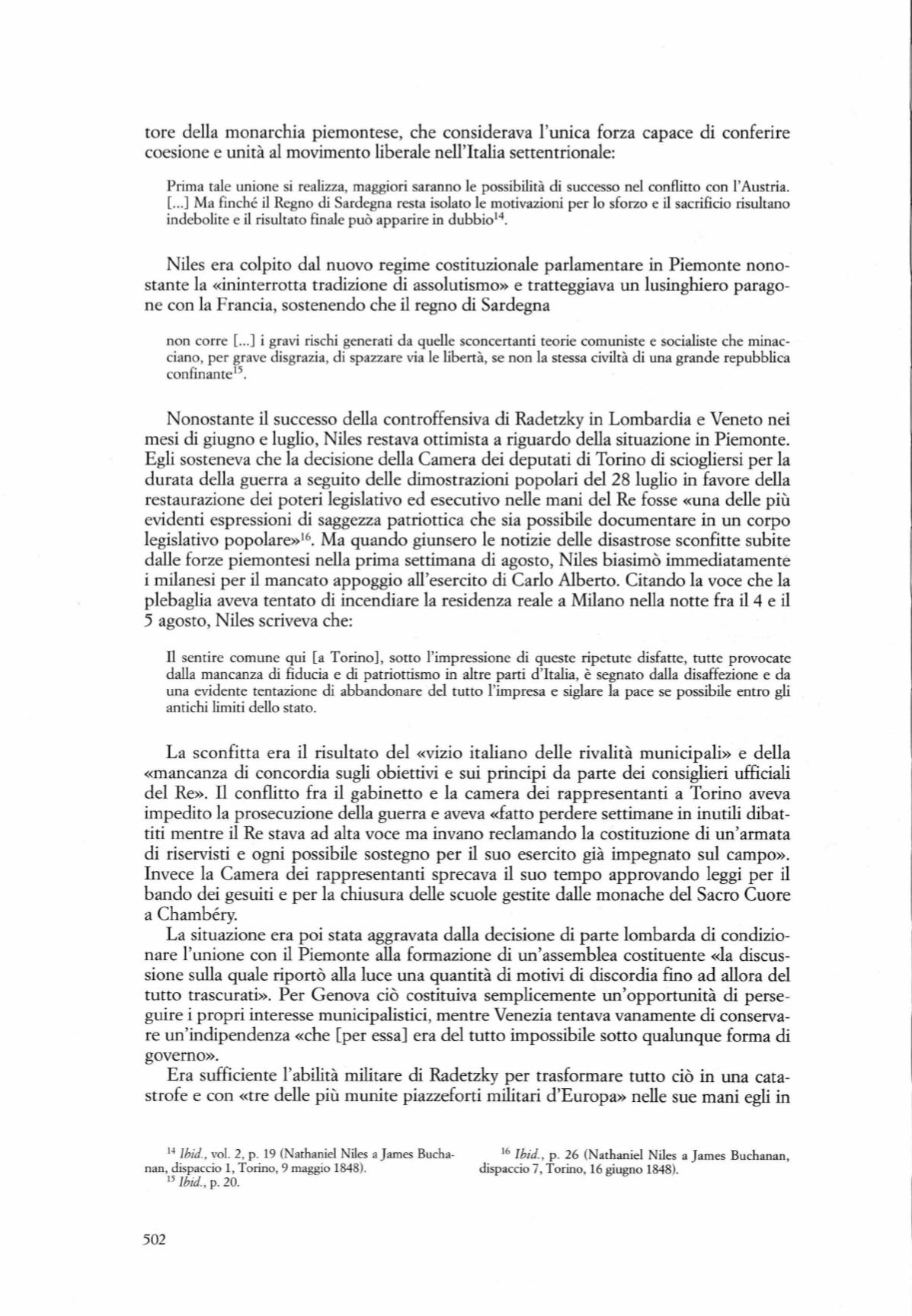
tore della monarchia piemontese, che considerava l'unica forza capace di conferire
coesione e unità al movimento liberale nell'Italia settentrionale:
Prima tale unione si realizza, maggiori saranno le possibilità di successo nel conflitto con l'Austria.
[. ..] Ma finché il Regno di Sardegna resta isolato le motivazioni per lo sforzo e il sacrificio risultano
indebolite e il risultato finale può apparire in dubbio
14 .
Niles era colpito dal nuovo regime costituzionale parlamentare in Piemonte nono–
stante la «ininterrotta tradizione di assolutismo» e tratteggiava un lusinghiero parago–
ne con la Francia, sostenendo che il regno di Sardegna
non corre [.. .] i gravi rischi generati da quelle sconcertanti teorie comuniste e socialiste che minac–
ciano, per grave disgrazia, di spazzare via le libertà, se non la stessa civiltà di una grande repubblica
confinante
15 .
Nonostante il successo della controffensiva di Radetzky in Lombardia e Veneto nei
mesi di giugno e luglio, Niles restava ottimista a riguardo della situazione in Piemonte.
Egli sosteneva che la decisione della Camera dei deputati di Torino di sciogliersi per la
durata della guerra a seguito delle dimostrazioni popolari del 28 luglio in favore della
restaurazione dei poteri legislativo ed esecutivo nelle mani del Re fosse «una delle più
evidenti espressioni di saggezza patriottica che sia possibile documentare in un corpo
legislativo popolare»16. Ma quando giunsero le notizie delle disastrose sconfitte subite
dalle forze piemontesi nella prima settimana di agosto, Niles biasimò immediatamentè
i milanesi per il mancato appoggio all'esercito di Carlo Alberto. Citando la voce che la
plebaglia aveva tentato di incendiare la residenza reale a Milano nella notte fra il 4 e il
5 agosto, Niles scriveva che:
Il sentire comune qui [a Torino], sotto l'impressione di queste ripetute disfatte, tutte provocate
dalla mancanza di fiducia e di patriottismo in altre parti d'Italia, è segnato dalla disaffezione e da
una evidente tentazione di abbandonare del tutto l'impresa e siglare la pace se possibile entro gli
antichi limiti dello stato.
La sconfitta era
il
risultato del «vizio italiano delle rivalità municipali» e della
«mancanza di concordia sugli obiettivi e sui principi da parte dei consiglieri ufficiali
del Re». Il conflitto fra il gabinetto e la camera dei rappresentanti a Torino aveva
impedito la prosecuzione della guerra e aveva «fatto perdere settimane in inutili dibat–
titi mentre il Re stava ad alta voce ma invano reclamando la costituzione di un' armata
di riservisti e ogni possibile sostegno per il suo esercito già impegnato sul campo».
Invece la Camera dei rappresentanti sprecava il suo tempo approvando leggi per il
bando dei gesuiti e per la chiusura delle scuole gestite dalle monache del Sacro Cuore
a Chambéry.
La situazione era poi stata aggravata dalla decisione di parte lombarda di condizio–
nare l'unione con il Piemonte alla formazione di un' assemblea costituente «la discus–
sione sulla quale riportò alla luce una quantità di motivi di discordia fino ad allora del
tutto trascurati». Per Genova ciò costituiva semplicemente un'opportunità di perse–
guire i propri interesse municipalistici, mentre Venezia tentava vanamente di conserva–
re un'indipendenza «che [per essa] era del tutto impossibile sotto qualunque forma di
governo».
Era sufficiente l'abilità militare di Radetzky per trasformare tutto ciò in una cata–
strofe e con «tre delle più munite piazzeforti militari d'Europa» nelle sue mani egli in
14
Ibid.,
val. 2, p. 19 (Nathaniel Niles a James Bucha–
nan, dispaccio 1, Torino, 9 maggio 1848).
15
Ibid.,
p. 20.
502
16
Ibid.,
p. 26 (Nathaniel Niles a James Buchanan,
dispaccio 7, Torino, 16 giugno 1848).


















