
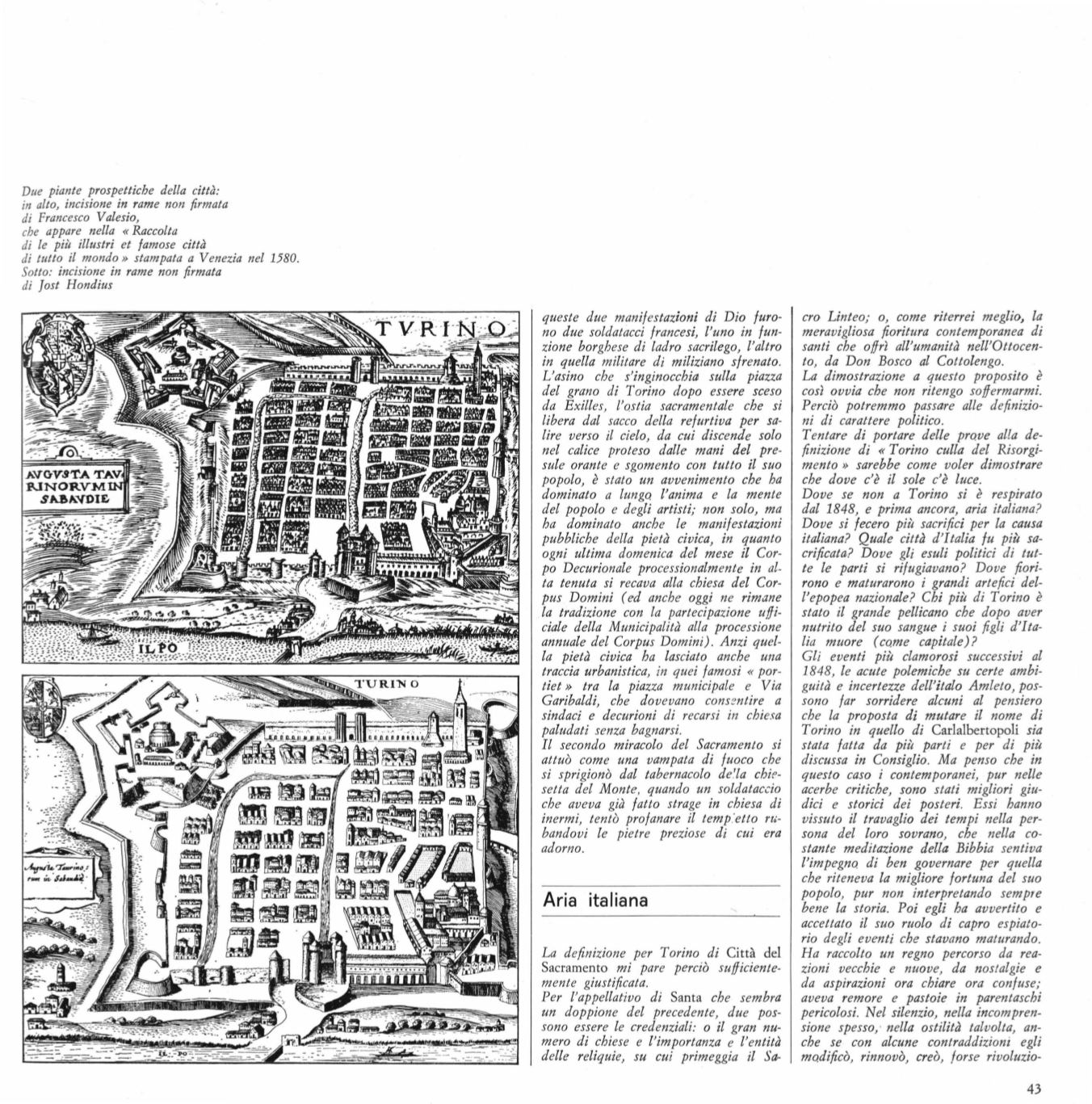
Due piante prospettiche della città:
in alto, incisione in rame non firmata
di Francesco Valesio,
che appare nella «Raccolta
di le più illustri et famose città
di tutto il mondo» stampata a Venezia nel
1580.
Sotto: incisione in rame non firmata
di ]ost Hondius
queste due manifestazioni di Dio furo–
no due soldatacci francesi, l'uno in fun–
zione borghese di ladro sacrilego, l'altro
in quella militare di miliziano sfrenato.
L'asino che s'inginocchia sulla piazza
del grano di Torino dopo essere sceso
da Exilles, l'ostia sacramentale che si
libera dal sacco della refurtiva per sa–
lire verso il cielo, da cui discende solo
nel calice proteso dalle mani del pre–
sule arante e sgomento con tutto il suo
popolo, è stato un avvenimento che ha
dominato a lungo l'anima e la mente
del popolo e degli artisti; non solo, ma
ha dominato anche le manifestazioni
pubbliche della pietà civica, in quanto
ogni ultima domenica del mese il Cor–
po Decurionale processionalmente in al–
ta tenuta si recava alla chiesa del Cor–
pus Domini (ed anche oggi ne rimane
la tradizione con la partecipazione uffi–
ciale della Municipalità alla processione
annuale del Corpus Domini) . Anzi quel–
la pietà civica ha lasciato anche una
traccia urbanistica, in quei famosi
«
por–
tiet» tra la piazza municipale e Via
Garibaldi, che dovevano cons?ntire a
sindaci e decurioni di recarsi in chiesa
paludati senza bagnarsi.
Il secondo miracolo del Sacramento si
attuò come una vampata di fuoco che
si sprigionò dal tabernacolo de'la chif–
setta del Monte, quando un soldataccio
che aveva già fatto strage in chiesa di
inermi, tentò profanare il temp.·etto ru–
bandovi le pietre preziose di cui era
adorno .
Aria italiana
La definizione per Torino di
Città del
Sacramento
mi pare perciò sufficiente–
mente giustificata.
Per l'appellativo di
Santa
che sembra
un doppione del precedente, due pos–
sono essere le credenziali: o il gran nu–
mero di chiese e l'importanza e l'entità
delle reliquie, su cui primeggia il Sa-
ero Linteo; o, come riterrei meglio, la
meravigliosa fioritura contemporanea di
santi che offrì all'umanità nell'Ottocen–
to, da Don Bosco al Cottolengo.
La dimostrazione a questo proposito è
così ovvia che non ritengo soffermarmi.
Perciò potremmo passare alle definizio–
ni di carattere politico.
Tentare di portare delle prove alla de–
finizione di
«T
orino culla del Risorgi–
mento» sarebbe come voler dimostrare
che dove c'è il sole c'è luce.
Dove se non a Torino si è respirato
dal
1848,
e prima ancora, aria italiana?
Dove si fecero più sacrifici per la causa
italiana? Quale città d'Italia fu più sa–
crificata? Dove gli esuli politici di tut–
te le parti si rifugiavano? Dove fiori–
rono e maturarono i grandi artefici del–
l'epopea nazionale? Chi più di Torino è
stato il grande pellicano che dopo aver
nutrito del suo sangue i suoi figli d'Ita–
lia muore (come capitale)?
Gli eventi più clamorosi successivi al
1848, le acute polemiche su certe ambi–
guità e incertezze dell'italo Amleto, pos–
sono far sorridere alcuni al pensiero
che la proposta di mutare il nome di
T
orino in quello di
Carlalbertopoli
sia
stata fatta da più parti e per di più
discussa in Consiglio. Ma penso che in
questo caso i contemporanei, pur nelle
acerbe critiche, sono stati migliori giu–
dici e storici dei posteri. Essi hanno
vissuto il travaglio dei tempi nella per–
sona del loro sovrano, che nella co–
stante meditazione della Bibbia sentiva
l'impegno di ben governare per quella
che riteneva la migliore fortuna del suo
popolo, pur non interpretando sempre
bene la storia. Poi egli ha avvertito e
accettato il suo ruolo di capro espiato–
rio degli eventi che stavano maturando.
Ha raccolto un regno percorso da rea–
zioni vecchie e nuove, da nostalgie e
da aspirazioni ora chiare ora confuse;
aveva remare e pastoie in parentaschi
pericolosi. Nel silenzio, nella incompren–
sione spesso, ' nella ostilità ta[.volta, an–
che se con alcune contraddizioni egli
modificò, rinnovò, creò, forse rivoluzio-
43


















