
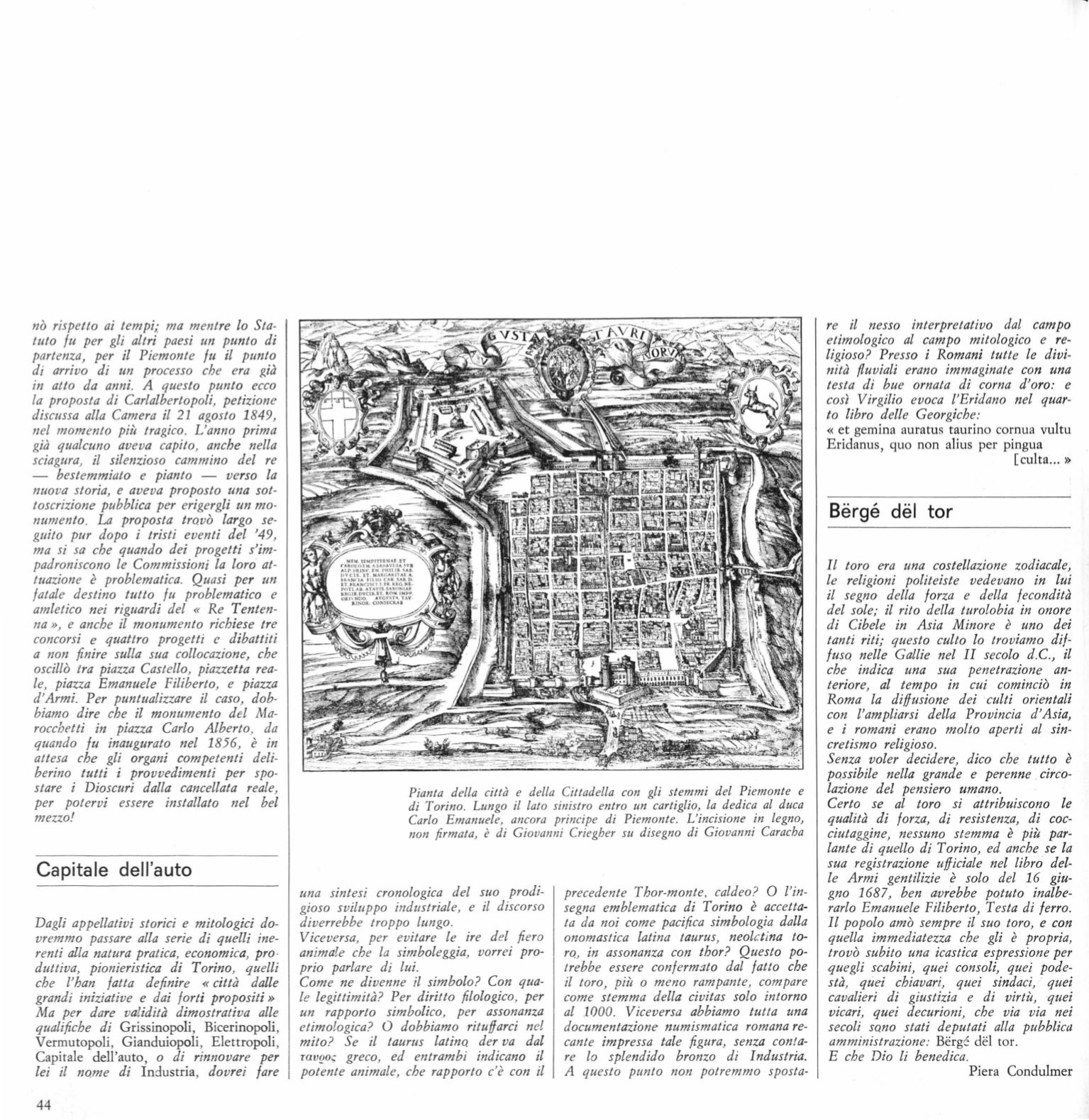
nòrispetto ai tempi,: ma mentre lo Sta–
tuto fu per gli altri paesi un punto di
partenza, per il Piemonte fu il punto
di arrivo di un processo che era già
in atto da anni. A questo punto ecco
la proposta di Carlalbertopoli, petizione
discussa alla Camera il
21
agosto 1849,
nel momento più tragico. L'anno prima
già qualcuno aveva capito, anche nella
sciagura, il silenzioso cammino del re
- bestemmiato e pianto
-
verso la
nuova storia, e aveva proposto una sot–
toscrizione pubblica per erigergli un mo–
numento. La proposta trQvò largo se–
guito pur dopo i tristi eventi del '49,
ma si sa che quando dei progetti s'im–
padroniscono le Commissioni la loro at–
tuazione è problematica. Quasi per un
fatale destino tutto fu problematico e
amletico nei riguardi del
«
Re T enten–
na
»,
e anche il monumento richiese tre
concorsi e .quattro progetti c dibattiti
a non finire sulla sua collocazione, che
oscillò tra piazza Castello, piazzetta rea–
le, piazza Emanuele Filiberto, e piazza
d'Armi. Per puntualizzare il caso, dob–
biamo dire che il monumento del Ma–
rocchetti in piazza Carlo Alberto, da
quando fu inaugurato nel
1856,
è in
attesa che gli organi competenti deli–
berino tutti i provvedimenti per spo–
stare i Dioscuri dalla cancellata reale,
per potervi essere installato nel bel
mezzo!
Capitale dell'auto
Dagli appellativi storici e mitologici do–
vremmo passare alla serie di quelli ine–
renti alla natura pratica, economica, pro –
duttiva' pionieristica di Torino, quelli
che l'han fatta definire «città dalle
grandi iniziative e dai forti propositi »
Ma per dare validità dimostrativa alle
qualifiche di
Grissinopoli, Bicerinopoli,
Vermutopoli, Gianduiopoli, Elettropoli,
Capitale dell'auto, o
di rinnovare per
lei il nQme di
Industria ,
dovrei fare
44
Pianta deLLa città e deLLa CittadeLLa con gli stemmi del Piemonte e
di Torino. Lungo il lato sinistro entro un cartiglio, la dedica al duca
Carlo Emanuele, ancora principe di Piemonte. L'incisione in legno,
non firmata,
è
di Giovanni Crieghe,. su disegno di Giovanni Caracha
una sintesi cronologica del suo prodi–
gioso sviluppo industriale, e il discorso
diverrebbe troppo lungo .
Viceversa, per evitare le ire del fi ero
animale che la simboleggia, vorrei pro–
prio parlare di lui.
Come ne divenne il simbolo? Con qua–
le legittimità? Per diritto filologico , per
un rapporto simbolico, per assonanza
etimologica?
O
dobbiamo rituffarci nel
mito? Se il taurus latinQ der va dal
ravQoç greco, ed entrambi indicano il
potente animale, che rapporto c'è con il
precedente Thor-monte, caldeo?
O
l'in–
segna emblematica di Torino è accetta–
ta da noi come pacifica simbologia dalla
onomastica latina taurus, neolctina to–
rQ, in assonanza con thor? Questo po–
trebbe essere confermato dal fatto che
il toro, più
o
meno rampante, compare
come stemma della civitas solo intorno
al .1000. Viceversa abbiamo tutta una
documentazione numismatica romana re–
cante impressa tale figura, senza conta–
re lo splendido bronzo di Industria.
A questo punto non potremmo sposta-
re il nesso interpretativo dal campo
etimologico
al
campo mitologico e re–
ligioso? Presso i Romani tutte le divi–
nità fluviali erano immaginate con una
testa di bue ornata di corna d'oro: e
così Virgilio evoca l'Eridano nel quar–
to libro delle Georgiche:
«
et gemina auratus taurino coroua vultu
Eridanus, quo non alius per pingua
[culta...
»
Bergé del tor
I!
toro era una costellazione zodiacale,
le religioni politeiste vedevano in lui
il segno della forza e della fecondità
del sole; il rito della turolobia in onore
di Cibele in Asia Minore è uno dei
tanti riti; questo culto lo troviamo dif–
fUSQ nelle Gallie nel II secolo d.C., il
che indica una sua penetrazione an–
teriore, al tempo in cui cominciò in
Roma la diffusione dei culti orientali
con l'ampliarsi della Provincia d'Asia,
e i romani erano molto aperti al sin–
cretismo religioso.
Senza voler decidere, dico che tutto è
pQssibile nella grande e perenne circo–
lazione del pensiero umano.
Certo se al toro si attribuiscono le
qualità di forza, di resistenza, di coc–
ciutaggine, nessuno stemma
è
più par–
lante di quello di Torino, ed anche se la
sua registrazione ufficiale nel libro del–
le Armi gentilizie
è
solo del
16
giu–
gno
1687,
ben avrebbe potuto inalbe–
rarlo Emanuele Filiberto, Testa di ferro .
I!
popolo amò sempre il suo toro, e con
quella immediatezza che gli
è
propria,
trovò subito una icastica espressione per
quegli scabini, quei consoli, quei pode–
stà, quei chiavari, quei sindaci, quei
cavalieri di giustizia e di virtù, quei
vicari, quei decurioni, che via via nei
secoli SQno stati deputati alla pubblica
amministrazione:
Bergé deI toro
E
che Dio li benedica.
Piera Condulmer


















