
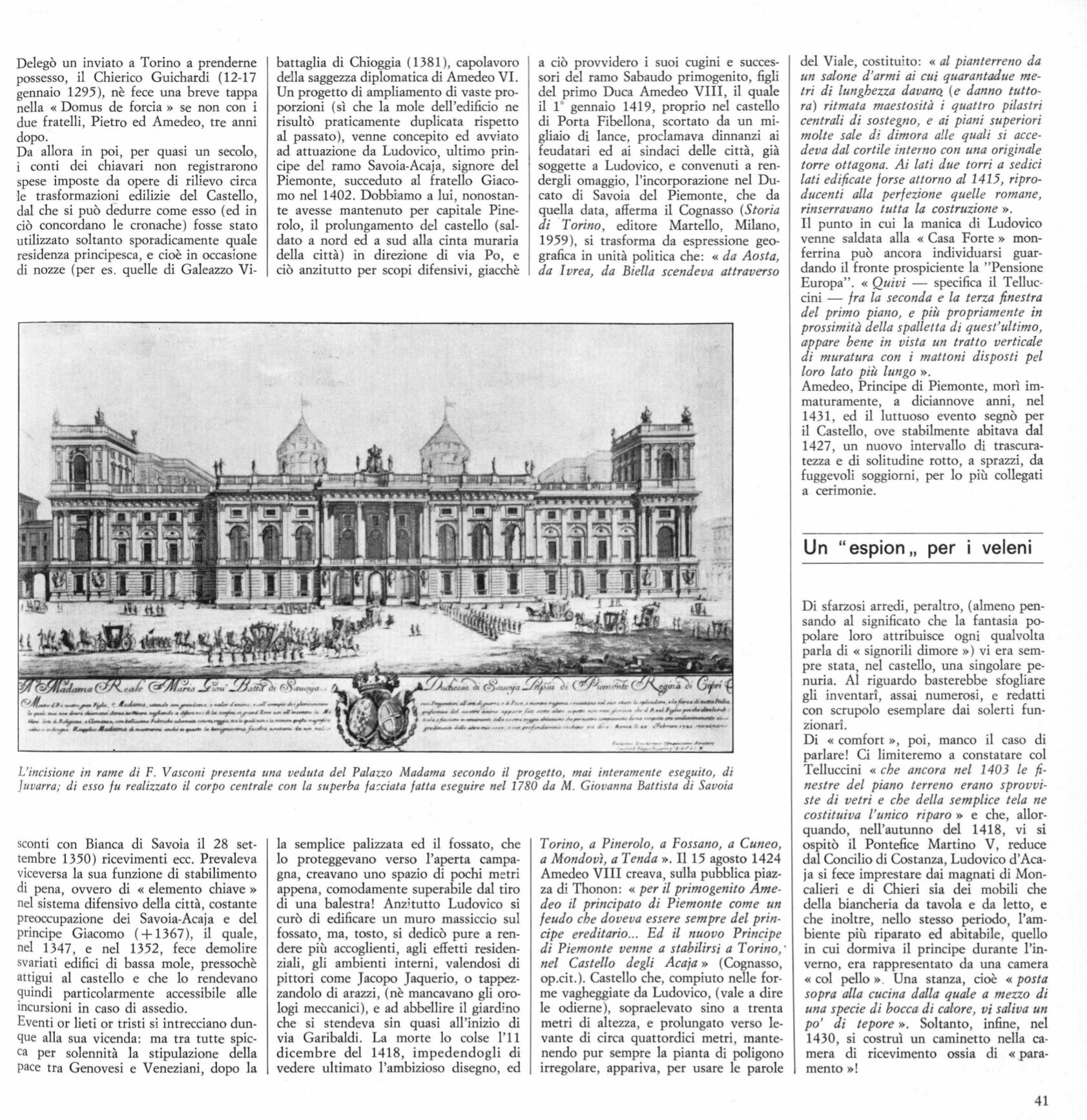
Delegò un inviato a Torino a prenderne
possesso,
il
Chierico Guichardi (12-17
gennaio 1295), nè fece una breve tappa
nella
«
Domus de forcia » se non con i
due fratelli, Pietro ed Amedeo, tre anni
dopo.
Da allora in poi, per quasi un secolo,
i conti dei chiavari non registrarono
spese imposte da opere di rilievo circa
le trasformazioni edilizie del Castello,
dal che si può dèdurre come esso (ed in
ciò concordano le cronache) fosse stato
utilizzato soltanto sporadicamente quale
residenza principesca, e cioè in occasione
di nozze (per es. quelle di Galeazzo Vi-
battaglia di Chioggia (1381), capolavoro
de'lla saggezza diplomatica di Amedeo VI.
Un progetto di ampliamento di vaste pro–
porzioni (sì che la mole dell'edificio ne
risultò praticamente duplicata rispetto
al passato), venne concepito ed avviato
ad attuazione da Ludovico, ultimo prin–
cipe del ramo Savoia-Acaja, signore del
Piemonte, succeduto al fratello Giaco–
mo nel 1402. Dobbiamo a lui, nonostan–
te avesse mantenuto per capitale Pine–
rolo, il prolungamento del castello (sal–
dato a nord ed a sud alla cinta muraria
della città) in direzione di via Po, e
ciò anzitutto per scopi difensivi, giacchè
a ciò provvidero i suoi cugIni e succes–
sori del ramo Sabaudo primogenito, figli
del primo Duca Amedeo VIII, il quale
il 10 gennaio 1419, proprio nel castello
di Porta Fibellona, scortato da un mi–
gliaio di lance, proclamava dinnanzi ai
feudatari ed ai sindaci delle città, già
soggette a Ludovico, e convenuti a ren–
dergli omaggio, l'incorporazione nel Du–
cato di Savoia del Piemonte, che da
quella data, afferma il Cognasso
(Storia
di Torino,
editore Martello, Milano,
1959), si trasforma da espressione geo–
grafica in unità politica che :
«da Aosta,
da Ivrea, da Biella scendeva attraverso
......,-",.. r: 1. .......
,-.t. _"........_...
..J",
,_o
-~~"""''''.r---
tr~
__"""'--"""-- ___
--.. ~.~~~.J.,-1'-
...
,-w"-_J-ltt
~.;,
.""""'~J
__
.I},..,...,.~,"'J,p;o.,
....,'_..
."..-.,~
................
.JIWII,._.",.t<''-''''HHI;"".....
t.~J.'..",.j
...
,..w-
.1,,1_......
a...,-
'*,.~_r.."
..
_.~w,...."",
..(,••
_.,t,.,.• ..-
,.A.. ..
~-.llw'-,...~~
..
.t",f~_
..
...-..J"II"._~~:Àf:!"",...-·.-
..
b_~"If'W~~
p~.IJ1,...,._,
..
,~"
,"_,,,4-.J_~,"""-
m'
,Iù.
h .....
~
••
f~/,"#~
.....
'~
....c..;.-.
fa--..._~~-...-
.............,..,.......,........
·IoII;_.,..,.,..-r"!'I"n
.."j....
...
~
..........
.lI.......
,,_~. ,...... ~~~~._
....
.t:~
L'incisione in rame di
F.
Vasconi presenta una veduta del Palazzo Madama secondo il progetto, mal mteramente eseguito, di
Juvarra; di esso fu realizzato il corpo centrale con la superba fa,:ciata fatta eseguire nel
1780
da M. Giovanna Battista di Savoia
sconti con Bianca di Savoia il 28 set–
tembre 1350) ricevimenti ecc. Prevaleva
viceversa la sua funzione di stabilimento
di pena, ovvero di «elemento chiave»
nel sistema difensivo della città, costante
preoccupazione dei Savoia-Acaja e del
principe Giacomo
(+
1367), il quale,
nel 1347 , e nel 1352, fece demolire
svariati edifici di bassa mole, pressochè
attigui al castello e che lo rendevano
quindi particolarmente accessibile alle
incursioni in caso di assedio.
Eventi or lieti or tristi si intrecciano dun–
que alla sua vicenda: ma tra tutte spic–
ca per solennità la stipulazione della
pace tra Genovesi e Veneziani, dopo la
la semplice palizzata ed il fossato, che
lo proteggevano verso l'aperta campa–
gna, creavano uno spazio di pochi metri
appena, comodamente superabile dal tiro
di una balestra! Anzitutto Ludovico si
curò di edificare un muro massiccio sul
fossato, ma, tosto, si dedicò pure a ren–
dere più accoglienti, agli effetti residen–
ziali, gli ambienti interni, valendosi di
pittori come Jacopo Jaquerio, o tappez–
zandolo di arazzi, (nè mancavano gli oro–
logi meccanici), e ad abbellire il giardino
che si stendeva sin quasi all'inizio di
via Garibaldi. La morte lo colse
1'11
dicembre del 1418, impedendogli di
vedere ultimato l'ambizioso disegno, ed
Torino, a Pinerolo, a Fossano, a Cuneo,
a Mondovì, a Tenda
».1115 agosto 1424
Amedeo VIII creava, suUa pubblica piaz–
za di Thonon:
«per il primogenito Ame–
deo il principato di Piemonte come un
feudo che doveva essere sempre del prin–
cipe ereditario... Ed il nuovo Prinçjpe
di Piemonte venne a stabilirsi a Torino, '
nel Castello degli Acaja»
(Cognasso,
op.cit.). Castello che, compiuto nelle for–
me vagheggiate 9a Ludovico, (vale a dire
le odierne), sopraelevato sino a trenta
metri di altezza, e prolungato verso le–
vante di circa quattordici metri, mante–
nendo pur sempre la pianta di poligono
irregolare, appariva, per usare le parole
del Viale, costituito:
«al pianterreno da
un salone d'armi ai cui quarantadue me–
tri di lunghezza davanQ (e danno tutto–
ra) ritmata maestosità i quattro pilastri
centrali di sostegno, e ai piani superiori
molte sale di dimora aile quali si acce–
deva dal cortile interno con una originale
torre ottagona. Ai lati due torri a sedici
lati edificate forse attorno al
1415,
ripro–
ducenti alla perfezione quelle romane,
rinserravano tutta la costruzione
».
n
punto in cui la manica di Ludovico
venne s'aldata alla
«
Casa Forte» mon–
ferrina può ancora individuarsi guar–
dando
il
fronte prospiciente la "Pensione
Europa". «
Quivi
-
specifica
il
Telluc–
cini -
fra la seconda e la terza finestra
del primo piano, e più propriamente in
prossimità della spalletta di quest'ultimo,
appare bene in vista un tratto verticale
di muratura con i mattoni disposti pel
loro lato più lungo
».
Amedeo, Principe di Piemonte, morì im–
maturamente, a diciannove anni, nel
1431 , ed il luttuoso evento segnò per
ii
Castello, ove stabilmente abitava dal
1427, un nuovo intervallo di trascura–
tezza e di solitudine rotto, a sprazzi, da
fuggevoli soggiorni, per lo più collegati
a cerimonie.
Un "espion" per veleni
Di sfarzosi arredi, peraltro, (almeno pen–
sando
al
significato che la fantasia po–
polare loro attribuisce ogni qualvolta
parla di « signorili dimore») vi era sem–
pre stata, nel castello, una singolare pe–
nuria. Al riguardo basterebbe sfogliare
gli inventarì, assai numerosi, e redatti
con scrupolo esemplare dai solerti fun-
zlOnarr.
Di «comfort» , poi, manco
il
caso di
parlare!
Ci
limiteremo a constatare col
Telluccini
«che ancora nel 1403 le fi–
nestre del piano terreno erano sprovvi–
ste di vetri e che della semplice tela ne
costituiva l'unico riparo»
e che, allor–
quando, nell'autunno del 1418, vi si
ospitò
il
Pontefice Martino V, reduce
dal Concilio di Costanza, Ludovico d'Aca–
ja si fece imprestare dai magnati di Mon–
calieri e di Chieri sia dei mobili che
della biancheria da tavola e da letto, e
che inoltre, nello stesso periodo, l'am–
biente più riparato ed abitabile, quello
in cui dormiva
il
principe durante l'in–
verno, era rappresentato da una camera
«col pello ». Una stanza, cioè
«posta
sopra alla cucina dalla quale a mezzo di
una specie di bocca di calore, vi saliva un
po' di tepore
». Soltanto, infine, nel
1430, si costruì un caminetto nella ca–
mera di ricevimento ossia di «para-
mento »!
41


















