
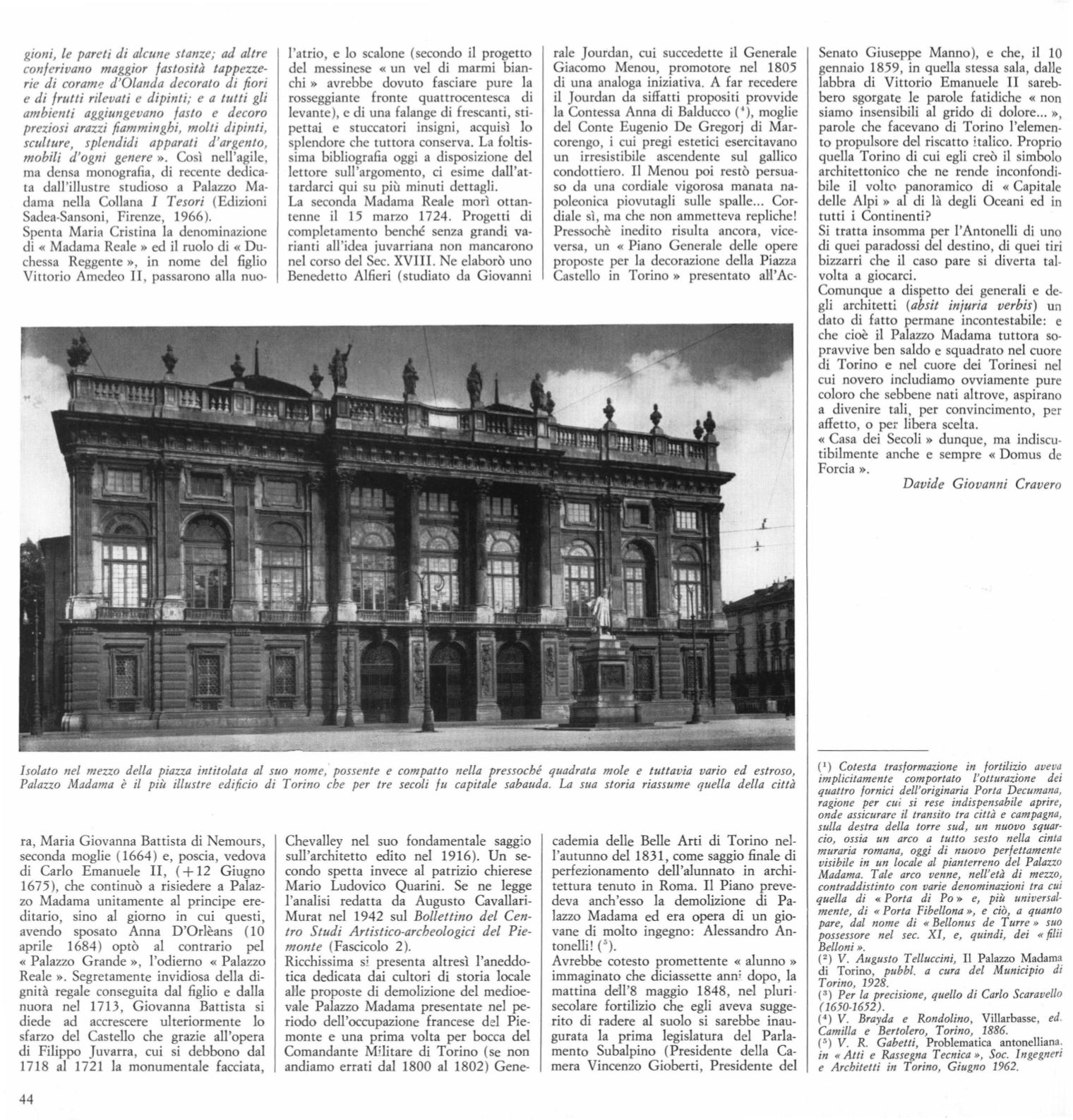
gioni, le pareti di alcune stanze; ad altre
conferivano maggior fastosità tappezze–
rie di corame d'Olanda decorato di fiori
e di frutti rilevati e dipinti; e a tutti gli
ambienti aggiungevano fasto e decoro
preziosi arazzi fiamminghi, molti dipinti,
sculture, splendidi apparati d'argento,
mobili d'ogni genere
». Così nell'agile,
ma densa monografia, di recente dedica–
ta dall'illustre studioso a Palazzo Ma–
dama nella Collana
I Tesori
(Edizioni
Sadea-Sansoni, Firenze, 1966).
Spenta Maria Cristina la denominazione
di « Madama Reale » ed
il
ruolo di « Du–
chessa Reggente », in nome del figlio
Vittorio Amedeo II , passarono alla nuo-
l'atrio, e lo sca,]one (secondo
il
progetto
del messinese «un vel di marmi bian–
chi» avrebbe dovuto fasciare pure la
rosseggiante fronte quattrocentesca di
levante), e di una falange di frescanti, sti–
pettai e stuccatori insigni, acquisì lo
splendore che tuttora conserva. La foltis–
sima bibliografia oggi a disposizione del
lettore sull'argomento, ci esime dall'at–
tardarci qui su più minuti dettagli.
La seconda Madama Reale morì ottan–
tenne
il
15 marzo 1724 . Progetti di
completamento benché senza grandi va–
rianti all'idea juvarriana non mancarono
nel corso del Sec. XVIII. Ne elaborò uno
Benedetto Alfieri (studiato da Giovanni
rale Jourdan, cui succedette
rl
Generale
Giacomo Menou, promotore nel 1805
di una analoga iniziativa. A far recedere
il
Jourdan da siffatti propositi provvide
la Contessa Anna di Balducco
(4),
moglie
del Conte Eugenio De Gregorj di Mar–
corengo, i cui pregi estetici esercitavano
un irresistibile ascendente sul gallico
condottiero. Il Menou poi restò persua–
so da una cordiale vigorosa manata na–
poleonica piovutagli sulle spalle... Cor–
diale sì, ma che non ammetteva repliche!
Pressochè inedito risulta ancora, vice–
versa, un «Piano Generale delle opere
proposte per la decorazione della Piazza
Castello in Torino» presentato aH'Ac-
Isolato nel mezzo della piazza intitolata al suo nome," possente e compatto nella pressoché quadrata mole e tuttavia vario ed estroso,
Palazzo Madama è il più illustre edificio di Torino che per tre secoli tu capitale sabauda. La sua storia riassume- quella della città
ra, Maria Giovanna Battista di Nemours ,
seconda moglie (1664) e, poscia, vedova
di Carlo Emanuele II,
(+
12 Giugno
1675), che continuò a risiedere a Palaz–
zo Madama unitamente al principe ere–
ditario, sino al giorno in cui questi,
avendo sposato Anna D'Orlèans (lO
aprile 1684) optò al contrario pel
«Palazzo Grande », l'odierno «Palazzo
Reale ». Segretamente invidiosa della di–
gnità regale conseguita dal figlio e dalla
nuora nel 1713 , Giovanna Battista si
diede ad accrescere ulteriormente lo
sfarzo del Castello che grazie all'opera
di Filippo Juvarra, cui si debbono dal
1718 al 1721 la monumentale facciata,
44
Chevalley nel suo fondamentale saggio
sull'architetto edito nel 1916). Un se–
condo spetta invece al patrizio chierese
Mario Ludovico Quarini. Se ne legge
l'analisi redatta da Augusto Cavallari–
Murat nel 1942 sul
Bollettino del Cen–
tro Studi Artistico-archeologici del Pie–
monte
(Fascicolo 2).
Ricchissima si presenta altresì l'aneddo–
tica dedicata dai cultori di storia locale
aJtle proposte di demolizione del medioe–
vale Palazzo Madama presentate nel pe–
riodo dell'occupazione francese del Pie–
monte e una prima volta per bocca del
Comandante Militare di Torino (se non
andiamo errati dal 1800 al 1802) Gene-
cademia delle Belle Arti di Torino nel–
l'autunno del 1831, come saggio finale di
perfezionamento dell'a.Junnato in archi–
tettura tenuto in Roma. Il Piano preve–
deva anch'esso la demolizione di Pa–
lazzo Madama ed era opera di un gio–
vane di molto ingegno: Alessandro An–
tonelli! (").
Avrebbe cotesto promettente « alunno»
immaginato che diciassette anni. dopo, la
mattina dell'8 maggio 1848, nel pluri .
secolare fortilizio che egli aveva sugge–
rito di radere al suolo si sarebbe inau–
gurata la prima legislatura del Parla–
mento Subalpino (Presidente della Ca–
mera Vincenzo Gioberti, Presidente del
Senato Giuseppe Manno), e che,
il
lO
gennaio 1859, in quella stessa sala, daBe
labbra di Vittorio Emanuele II sareb–
bero sgorgate le parole fatidiche « non
siamo insensibili al grido di dolore... »,
parole che facevano di Torino l'elemen–
to propulsore del riscatto italico. Proprio
quella Torino di cui egli creò il simbolo
architettonico che ne rende inconfondi–
bile
il
volto panoramico di «Capitale
delle Alpi» al di là degli Oceani ed in
tutti i Continenti?
Si tratta insomma per l'Antonelli di uno
di quei paradossi del destino, di quei tiri
bizzarri che
il
caso pare si diverta tal–
volta a giocarci.
Comunque a dispetto dei generali e de–
gli architetti
(absit injuria verbis)
un
dato di fatto permane incontestabile: e
che cioè
il
Palazzo Madama tuttora so–
pravvive ben saldo e squadrato nel cuore
di Torino e nel cuore dei Torinesi nel
cui novero includiamo ovviamente pure
coloro che sebbene nati altrove, aspirano
a divenire tali , per convincimento, per
affetto, o per libera scelta.
« Casa dei Secoli» dunque, ma indiscu–
tibilmente anche e sempre « Domus de
Forcia ».
Davide Giovanni Cravero
(')
Cotesta trasformazione in fortilizio aveva
implicitamente comportato l'otturazione dei
quattro fornici dell'originaria Porta Decumana,
ragione per cui si rese indispensabile aprire,
onde assicurare il transito tra città e campagna,
sulla destra della torre sud, un nuovo squar–
cio, ossia un arco a tutto sesto nella cinta
muraria romana, oggi di nuovo perfettamente
visibile in un locale al pianterreno del Palauo
Madama. Tale arco venne, nell'età di mezzo,
contraddistinto con varie denominazioni tra cui
quella di «Porta di Po» e, più universal–
mente, di «Porta Fibellona
»,
e ciò, a quanto
pare, dal nome di «Bellonus de Turre » suo
possessore nel sec. XI, e, quindi, dei « filii
Belloni
».
(2)
V. Augusto Telluccini,
Il Palazzo Madama
di Torino,
pubbl. a cura del Municipio di
Torino, 1928.
(3)
Per la precisione, quello di Carlo Scaravello
(1650-1652).
(4)
V. Brayda e Rondolino,
Villarbasse,
ed.
Camilla e BertoZero, Torino, 1886.
(5)
V.
R.
Gabetti,
Problematica antonelliana.
in « Atti e Rassegna T ecnica
»,
Soc. Ingegneri
e Architetti in Torino, Giugno 1962.


















