
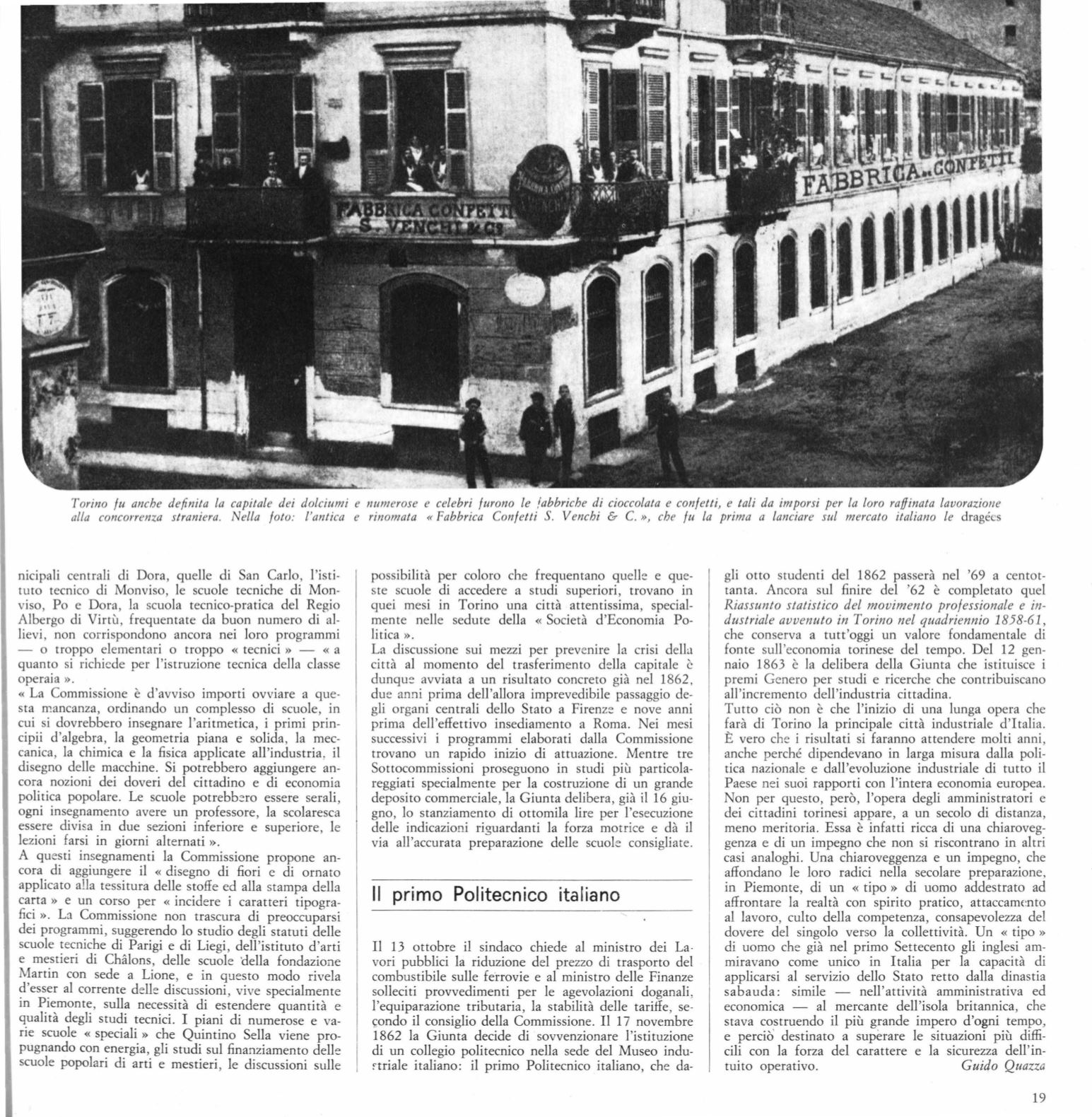
Torino fu anche definita la capitale dei dolciumi e numerose e celebri furono le iabbriche di cioccolata e confetti, e tali da imporsi per la loro raffinata lavorazione
alla concorrenza straniera. Nella foto: l'antica e rinomata « Fabbrica Confetti S. Venchi
&
C.
»,
che fu la prima a lanciare sul mercato italiano le
dragées
nicipali centrali di Dora, quelle di San Carlo, l'isti–
tuto tecnico di Monviso, le scuole tecniche di Mon–
viso, Po e Dora, la scuola tecnico-pratica del Regio
Albergo di Virtù , frequentate da buon numero di al–
lievi , non corrispondono ancora nei loro programmi
- o troppo elementari o troppo «tecnici» - «a
quanto si richiede per l'istruzione tecnica della classe
operaia ».
« La Commissione
è
d'avviso importi ovviare a que–
sta mancanza, ordinando un complesso di scuole, in
cui si dovrebbero insegnare l'aritmetica, i primi prin–
cipii d 'algebra, la geometria piana e solida, la mec–
canica, la chimica e la fisica applicate all'industria, il
disegno delle macchine. Si potrebbero aggiungere an–
cora nozioni dei doveri del cittadino e di economia
politica popolare. Le scuole
potrebb~ro
essere serali,
ogni insegnamento avere un professore, la scolaresca
essere divisa in due sezioni inferiore e superiore, le
lezioni farsi in giorni alternati ».
A questi insegnamenti la Commissione propone an–
cora di aggiungere il «disegno di fiori e di ornato
applicato alla tessitura delle stoffe ed alla stampa della
carta » e un corso per «incidere i caratteri tipogra–
fici ». La Commissione non trascura di preoccuparsi
dei programmi, suggerendo lo studio degli statuti delle
scuole tecniche di Parigi e di Liegi, dell'is tituto d'arti
e mestieri di Chiìlons, delle scuole 'della fondazione
Martin con sede a Lione, e in questo modo rivela
d'esser al corrente delle discussioni, vive specialmente
in Piemonte, sulla necessità di estendere quantità e
qualità degli studi tecnici. I piani di numerose e va–
rie scuole «speciali » che Quintino Sella viene pro–
pugnando con energia, gli studi sul finanziamento delle
scuole popolari di arti e mestieri , le discussioni sulle
possibilità per coloro che frequentano quelle e que–
ste scuole di accedere a studi superiori, trovano in
quei mesi in Torino una città attentissima, special–
mente nelle sedute della « Società d'Economia Po–
litica ».
La discussione sui mezzi per prevenire la crisi della
città al momento del trasferimento della capitale
è
dunque avviata a un risultato concreto già nel 1862,
due anni prima dell 'allora imprevedibile passaggio de–
gli organi centrali dello Stato a Firenze e nove anni
prima dell'effettivo insediamento a Roma. Nei mesi
successivi i programmi elaborati dalla Commissione
trovano un rapido inizio di attuazione. Mentre tre
Sottocommissioni proseguono in studi più particola–
reggiati specialmente per la costruzione di un grande
deposito commerciale, la Giunta delibera, già il 16 giu–
gno, lo stanziamento di ottomila lire per l'esecuzione
delle indicazioni riguardanti la forza motrice e dà il
via all'accurata preparazione delle scuole consigli ate.
Il pnmo Politecnico italiano
Il 13 ottobre il sindaco chiede al ministro dei La ·
vori pubblici la riduzione del prezzo di trasporto del
combustibile sulle ferrovie e al ministro delle Finanze
solleciti provvedimenti per le agevolazioni doganali,
l'equiparazione tributaria, la stabilità delle tariffe , se·
condo il consiglio della Commissione. Il 17 novembre
1862 la Giunta decide di sovvenzionare l'istituzione
di un collegio politecnico nella sede del Museo indu–
rtriale italiano : il primo Politecnico italiano, che da-
gli otto studenti del 1862 passerà nel '69 a centot–
tanta. Ancora sul finire del '62
è
completato quel
Riassunto statistico del movimento professionale e in–
dustriale avvenuto in Torino nel quadriennio
1858-61,
che conserva a tutt'oggi un valore fondamentale di
fonte sull'economia torinese del tempo. Del 12 gen–
naio 1863
è
la delibera della Giunta che istituisce i
premi Genero per studi e ricerche che contribuiscano
all'incremento dell'industria cittadina.
Tutto ciò non
è
che l'inizio di una lunga opera che
farà di Torino la principale città industriale d'Italia.
È
vero che i risultati si faranno attendere molti anni,
anche perché dipendevano in larga misura dalla poli–
tica nazionale e dall'evoluzione industriale di tutto il
Paese nei suoi rapporti con l'intera economia europea.
Non per questo, però, l'opera degli amministratori e
dei cittadini torinesi appare, a un secolo di distanza,
meno meritoria. Essa
è
infatti ricca di una chiaroveg–
genza e di un impegno che non si riscontrano in altri
casi analoghi. Una chiaroveggenza e un impegno, che
affondano le loro radici nella secolare preparazione,
in Piemonte, di un «tipo » di uomo addestrato ad
affrontare la realtà con spirito pratico, attaccamento
al lavoro, culto della competenza, consapevolezza del
dovere del singolo verso la collettività. Un «tipo»
di uomo che già nel primo Settecento gli inglesi am–
miravano come unico in Italia per la capacità di
applicarsi al servizio dello Stato retto dalla dinastia
sabauda : simile - nell'attività amministrativa ed
economica - al mercante dell 'isola britannica, che
stava costruendo
il
più grande impero d'ogni tempo,
e perciò' destinato a supèrare le situazioni più diffi–
cili con la forza del carattere e la sicurezza dell'in–
tuito operativo.
Guido Quazza
19


















