
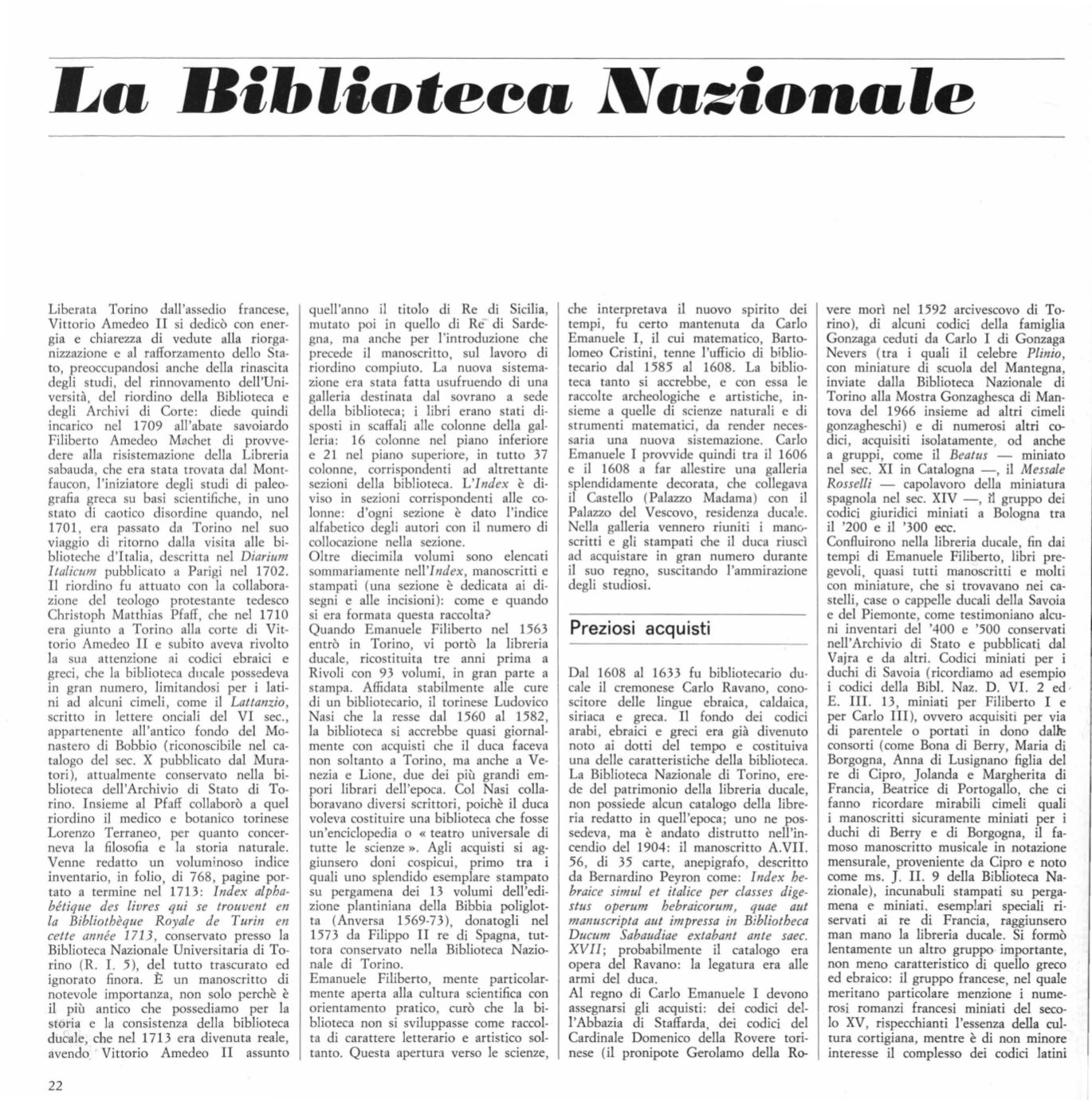
La Biblioteca Nazionale
Liberata Torino dall'assedio francese,
Vittorio Amedeo II si dedicò con ener–
gia e chiarezza di vedute alla riorga–
nizzazione e al rafforzamen to dello Sta–
to, preoccupandosi anche della rinascita
degli studi, del rinnovamento dell'Uni–
versità, del riordino della Biblioteca e
degli Archivi di Corte: diede quindi
incarico nel 1709 all'abate savoiardo
Filiberto Amedeo Machet di provve–
dere alla risistemazione della Libreria
sabauda, che era stata trovata dal Mont–
faucon, l'iniziatore degli studi di pale
0-
grafia greca su basi scientifiche, in uno
stato di caotico disordine quando, nel
1701, era passato da Torino nel suo
viaggio di ritorno dalla visita alle bi–
blioteche d'Italia, descritta nel
Diarium
Italicum
pubblicato a Parigi nel 1702.
Il riordino fu attuato con la collabora–
zione del teologo protestante tedesco
Christoph Matthias Pfaff, che nel 1710
era giunto a Torino alla corte di Vit–
torio Amedeo II e subito aveva rivolto
la sua attenzione ai codici ebraici e
greci, che la biblioteca ducale possedeva
in gran numero, limitandosi per i lati–
ni ad alcuni cimeli, come il
Lattanzio,
scritto in lettere onciali del VI sec.,
appartenente all'antico fondo del Mo–
nastero di Bobbio (riconoscibile nel ca–
talogo del sec. X pubblicato dal Mura–
tori), attualmente conservato nella bi–
blioteca dell'Archivio di Stato di To–
rino. Insieme al Pfaff collaborò a quel
riordino
il
medico e botanico torinese
Lorenzo Terraneo, per quanto concer–
neva la filosofia e la storia naturale.
Venne redatto un voluminoso indice
inventario, in folio, di 768, pagine por–
tato a termine nel 1713:
Index alpha–
bétique des livres qui se trouvent en
la Bibliothèque Royale de Turin en
cette année
1713, conservato presso la
Biblioteca Nazionale Universitaria di To–
rino (R. I. 5), del tutto trascurato ed
ignorato finora.
È
un manoscritto di
notevole importanza, non solo perchè è
il
più antico che possediamo per la
storia e la consistenza della biblioteca
dutnle, che nel 1713 era divenuta reale,
avendo: ' Vittorio Amedeo II assunto
22
quell'anno il titolo di Re di Sicilia,
mutato poi in quello di Re- di Sarde–
gna, ma anche per l'introduzione che
precede il manoscritto, sul lavoro di
riordino compiuto. La nuova sistema–
zione era stata fatta usufruendo di una
galleria destinata dal sovrano a sede
della biblioteca; i libri erano stati di–
sposti in scaffali alle colonne della gal–
leria: 16 colonne nel piano inferiore
e 21 nel piano superiore, in tutto 37
colonne, corrispondenti ad altrettante
sezioni della biblioteca.
L'Index
è di–
viso in sezioni corrispondenti alle co–
lonne: d'ogni sezione è dato l'indice
alfabetico degli autori con il numero di
collocazione nella sezione.
Oltre diecimila volumi sono elencati
sommariamente
nell'Index,
manoscritti e
stampati (una sezione è dedicata ai di–
segni e alle incisioni): come e quando
si era formata questa raccolta?
Quando Emanuele Filiberto nel 1563
entrò in Torino, vi portò la libreria
ducale, ricostituita tre anni prima a
Rivoli con 93 volumi, in gran parte a
stampa. Affidata stabilmente alle cure
di un bibliotecario, il torinese Ludovico
Nasi che la resse dal 1560 al 1582,
la biblioteca si accrebbe quasi giornal–
mente con acquisti che il duca faceva
non soltanto a Torino, ma anche a Ve–
nezia e Lione, due dei più grandi em–
pori librari dell'epoca. Col Nasi colla–
boravano diversi scrittori, poichè il duca
voleva costituire una biblioteca che fosse
un'enciclopedia o « teatro universale di
tutte le scienze
».
Agli acquisti si ag–
giunsero doni cospicui, primo tra i
quali uno splendido esemplare stampato
su pergamena dei 13 volumi dell'edi–
zione plantiniana della Bibbia poliglot–
ta (Anversa 1569-73), donatogli nel
1573 da Filippo II re di Spagna, tut–
tora conservato nella Biblioteca Nazio–
nale di Torino.
Emanuele Filiberto, mente particolar–
men te aperta alla cultura scientifica con
orientamento pratico, curò che la bi–
blioteca non si sviluppasse come raccol–
ta di carattere letterario e artistico sol–
tanto. Questa apertura verso le scienze,
che interpretava
il
nuovo spmto dei
tempi , fu certo mantenuta da Carlo
Emanuele I,
il
cui matematico, Barto–
lomeo Cristini, tenne l'ufficio di biblio–
tecario dal 1585 al 1608. La biblio–
teca tanto si accrebbe, e con essa le
raccolte archeologiche e artistiche, in–
sieme a quelle di scienze naturali e di
strumenti matematici, da render neces–
saria una nuova sistemazione. Carlo
Emanuele I provvide quindi tra il 1606
e il 1608 a far allestire una galleria
splendidamente decorata, che collegava
il Castello (Palazzo Madama) con il
Palazzo del Vescovo, residenza ducale.
Nella galleria vennero riuniti i manG–
scritti e gli stampati che il duca riuscì
ad acquistare in gran numero durante
il
suo regno, suscitando l'ammirazione
degli studiosi.
Preziosi acquisti
Dal 1608 al 1633 fu bibliotecario duo
cale il cremonese Carlo Ravano, cono–
scitore delle lingue ebraica, caldaica,
siriaca e greca. Il fondo dei codici
arabi, ebraici e greci era già divenuto
noto ai dotti del tempo e costituiva
una delle caratteristiche della biblioteca .
La Biblioteca Nazionale di Torino, ere–
de del patrimonio della libreria ducale,
non possiede alcun catalogo della libre–
ria redatto in quell'epoca; uno ne pos–
sedeva, ma è andato distrutto nell'in–
cendio del 1904: il manoscritto A.VII .
56, di 35 carte, anepigrafo, descritto
da Bernardino Peyron come:
Index he–
braice simul et italice per classes dige–
stus operum hebraicorum, quae aut
manuscripta aut impressa in Bibliotheca
Ducum Sabaudiae extabant ante saec.
XVII;
probabilmente il catalogo era
opera del Ravano: la legatura era alle
armi del duca.
Al regno di Carlo Emanuele I devono
assegnarsi gli acquisti: dei codici del–
l'Abbazia di Staffarda, dei codici del
Cardinale Domenico della Rovere tori–
nese (il pronipote Gerolamo della Ro-
vere morì nel 1592 arcivescovo di To–
rino), di alcuni codici della famiglia
Gonzaga ceduti da Carlo I di Gonzaga
Nevers (tra i quali
il
celebre
Plinio ,
con miniature di scuola del Mantegna,
inviate dalla Biblioteca Nazionale di
Torino alla Mostra Gonzaghesca di Man–
tova del 1966 insieme ad altri cimeli
gonzagheschi) e di numerosi altri co–
dici, acquisiti isolatamente, od anche
a gruppi, come il
Beatus
-
miniato
nel sec. XI in Catalogna -, il
Messale
Rosselli
-
capolavoro della miniatura
spagnola nel sec. XIV -,
tI
gruppo dei
codici giuridici miniati a Bologna tra
il '200 e il '300 ecc.
Confluirono nella libreria ducale, fin dai
tempi di Emanuele Filiberto, libri pre–
gevoli, quasi tutti manoscritti e molti
con miniature, che si trovavano nei ca–
stelli, case o cappelle ducali della Savoia
e del Piemonte, come testimoniano alcu–
ni inventari del '400 e '500 conservati
nell'Archivio di Stato e pubblicati dal
Vajra e da altri. Codici miniati per i
duchi di Savoia (ricordiamo ad esempio
i codici della Bibl. Naz. D . VI. 2 ed ·
E. III. 13, miniati per Filiberto I e
per Carlo III), ovvero acquisiti per via
di parentele o portati in dono dalle
consorti (come Bona di Berry, Maria di
Borgogna, Anna di Lusignano figlia del
re di Cipro, Jolanda e Margherita di
Francia, Beatrice di Portogallo, che ci
fanno ricordare mirabili cimeli quali
i manoscritti sicuramente miniati per i
duchi di Berry e di Borgogna,
il
fa–
moso manoscritto musicale in notazione
mensurale, proveniente da Cipro e noto
come ms. ]. II. 9 della Biblioteca Na–
zionale), incunabuli stampati su perga–
mena e miniati. esemplari speciali ri·
servati ai re di Francia, raggiunsero
man mano la libreria ducale. Si formò
lentamente un altro gruppo importante,
non meno caratteristico di quello greco
ed ebraico: il gruppo francese, nel quale
meritano particolare menzione i nume–
rosi romanzi francesi miniati del seco–
lo XV, rispecchianti l'essenza della cul–
tura cortigiana, mentre è di non minore
interesse il complesso dei codici latini


















