
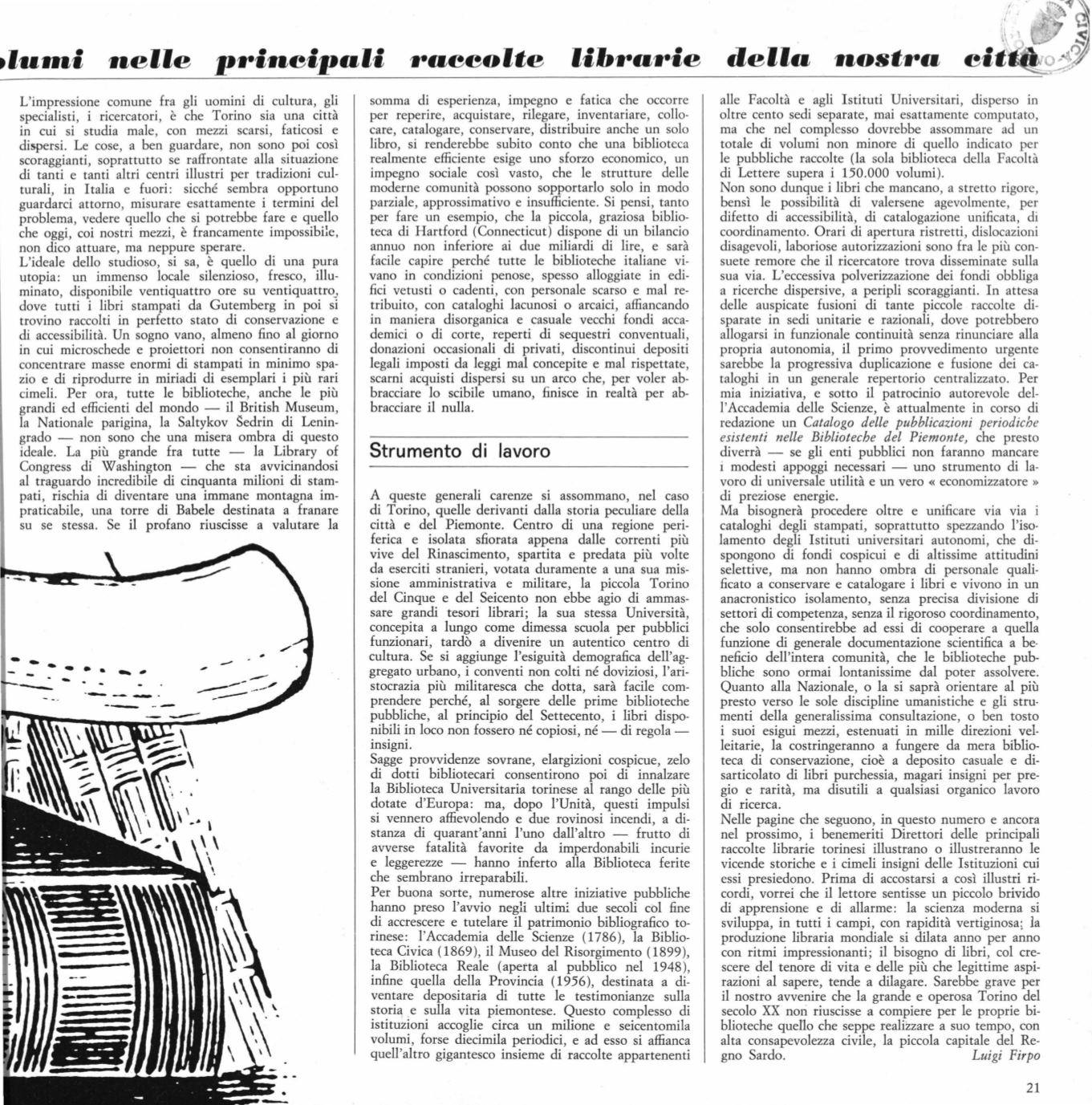
'unai
ne"e
principo'i
rocco'te
'ibrorie
L'impressione comune fra gli uomini di cultura, gli
specialisti, i ricercatori, è che Torino sia una città
in cui si studia male, con mezzi scarsi, faticosi e
dispersi. Le cose, a ben guardare, non sono poi cosÌ
scoraggianti, soprattutto se raffrontate alla situazione
di tanti e tanti altri centri illustri per tradizioni cul–
turali, in Italia e fuori: sicché sembra opportuno
guardarci attorno, misurare esattamente i termini del
problema, vedere quello che si potrebbe fare e quello
che oggi, coi nostri mezzi, è francamente impossibile,
non dico attuare, ma neppure sperare.
L'ideale dello studioso, si sa, è quello di una pura
utopia: un immenso locale silenzioso, fresco, illu–
minato, disponibile ventiquattro ore su ventiquattro-,
dove tutti i libri stampati da Gutemberg in poi si
trovino raccolti in perfetto stato di conservazione e
di accessibilità. Un sogno vano, almeno fino al giorno
in cui microschede e proiettori non consentiranno di
concentrare masse enormi di stampati in minimo spa–
zio e di riprodurre in miriadi di esemplari i più rari
cimeli. Per ora, tutte le biblioteche, anche le più
grandi ed efficienti del mondo - il British Museum,
la Nationale parigina, la Saltykov Sedrin di Lenin–
grado - non sono che una misera ombra di questo
ideale. La più grande fra tutte - la Library of
Congress di Washington - che sta avvicinandosi
al traguardo incredibile di cinquanta milioni di stam–
pati, rischia di diventare una immane montagna im–
praticabile, una torre di Babele destinata a franare
su se stessa. Se il profano riuscisse a valutare la
-
-
.
-
.
.
~-
-
-
somma di esperienza, impegno e fatica che occorre
per reperire, acquistare, rilegare, inventariare, collo–
care, catalogare, conservare, distribuire anche un solo
libro, si renderebbe subito conto che una biblioteca
realmente efficiente esige uno sforzo economico, un
impegno sociale cosÌ vasto, che le strutture delle
moderne comunità possono sopportarlo solo in modo
parziale, approssimativo e insufficiente. Si pensi, tanto
per fare un esempio, che la piccola, graziosa biblio–
teca di Hartford (Connecticut) dispone di un bilancio
annuo non inferiore ai due miliardi di lire, e sarà
facile capire perché tutte le biblioteche italiane vi–
vano in condizioni penose, spesso alloggiate in edi–
fici vetusti o cadenti, con personale scarso e mal re–
tribuito, con cataloghi lacunosi o arcaici, affiancando
in maniera disorganica e casuale vecchi fondi acca–
demici o di corte, reperti di sequestri conventuali,
donazioni occasionali di privati, discontinui depositi
legali imposti da leggi mal concepite e mal rispettate,
scarni acquisti dispersi su un arco che, per voler ab–
bracciare lo scibile umano, finisce in realtà per ab–
bracciare
il
nulla.
Strumento di lavoro
A queste generali carenze si assommano, nel caso
di Torino, quelle derivanti dalla storia peculiare della
città e del Piemonte. Centro
di
una regione peri–
ferica e isolata sfiorata appena dalle correnti più
vive del Rinascimento, spartita e predata più volte
da eserciti stranieri, votata duramente a una sua mis–
sione amministrativa e militare, la piccola Torino
del Cinque e del Seicento non ebbe agio di ammas–
sare grandi tesori librari; la sua stessa Università,
concepita a lungo come dimessa scuola per pubblici
funzionari, tardò a divenire un autentico centro di
cultura. Se si aggiunge l'esiguità demografica dell'ag–
gregato urbano, i conventi non colti né doviziosi, l'ari–
stocrazia più militaresca che dotta, sarà facile com–
prendere perché, al sorgere delle prime biblioteche
pubbliche, al principio del Settecento, i libri dispo–
nibili in loco non fossero né copiosi, né - di regola -
insigni.
Sagge provvidenze sovrane, elargizioni cospicue, zelo
di dotti bibliotecari consentirono poi di innalzare
la Biblioteca Universitaria torinese al rango delle più
dotate d'Europa: ma, dopo l'Unità, questi impulsi
si vennero affievolendo e due rovinosi incendi, a di–
stanza di quarant'anni l'uno dall'altro - frutto di
avverse fatalità favorite da imperdonabili incurie
e leggerezze - hanno inferto alla Biblioteca ferite
che sembrano irreparabili.
Per buona sorte, numerose altre iniziative pubbliche
hanno preso l'avvio negli ultimi due secoli cbl fine
di accrescere e tutelare il patrimonio bibliografico to–
rinese: l'Accademia delle Scienze (1786), la Biblio–
teca Civica (1869), il Museo del Risorgimento (1899),
la Biblioteca Reale (apetta al pubblico nel 1948),
infine quella della Provincia (1956), destinata a di–
ventare depositaria di tutte le testimonianze sulla
storia e sulla vita piemontese. Questo complesso di
istituzioni accoglie circa un milione e seicentomila
volumi, forse diecimila periodici, e ad esso si affianca
quell'altro gigantesco insieme di raccolte appartenenti
de"o nostro
alle Facoltà e agli Istituti Universitari, disperso in
oltre cento sedi separate, mai esattamente computato,
ma che nel complesso dovrebbe assommare ad un
totale di volumi non minore di quello indicato per
le pubbliche raccolte (la sola biblioteca della Facoltà
di Lettere supera i 150.000 volumi).
Non sono dunque i libri che mancano, a stretto rigore,
bensÌ le possibilità di valersene agevolmente, per
difetto di accessibilità, di catalogazione unificata, di
coordinamento. Orari di apertura ristretti, dislocazioni
disagevoli, laboriose autorizzazioni sono fra le più con–
suete remore che il ricercatore trova disseminate sulla
sua via. L'eccessiva polverizzazione dei fondi obbliga
a ricerche dispersive, a peripli scoraggianti. In attesa
delle auspicate fusioni di tante piccole raccolte di–
sparate in sedi unitarie e razionali, dove potrebbero
allogarsi in funzionale continuità senza rinunciare alla
propria autonomia,
il
primo provvedimento urgente
sarebbe la progressiva duplicazione e fusione dei ca–
taloghi in un generale repertorio centralizzato. Per
mia iniziativa, e sotto
il
patrocinio autorevole del–
l'Accademia delle Scienze, è attualmente in corso di
redazione un
Catalogo delle pubblicazioni periodiche
esistenti nelle Biblioteche del Piemonte,
che presto
diverrà - se gli enti pubblici non faranno mancare
i modesti appoggi necessari - uno strumento di la–
voro di universale utilità e un vero
«
economizzatore »
di preziose energie.
Ma bisognerà procedere oltre e unificare via via i
cataloghi degli stampati, soprattutto spezzando l'iso–
lamento degli Istituti universitari autonomi, che di–
spongono di fondi cospicui e di altissime attitudini
selettive, ma non hanno ombra di personale quali–
ficato a conservare e catalogare i libri e vivono in un
anacronistico isolamento, senza precisa divisione di
settori di competenza, senza
il
rigoroso coordinamento,
che solo consentirebbe ad essi di cooperare a quella
funzione di generale documentazione scientifica a be·
neficio dell'intera comunità, che le biblioteche pub–
bliche sono ormai lontanissime dal poter assolvere.
Quanto alla Nazionale, o la si saprà orientare al più
presto verso le sole discipline umanistiche e gli stru–
menti della generalissima consultazione, o ben tosto
i suoi esigui mezzi, estenuati in mille direzioni vel–
leitarie, la costringeranno a fungere da mera biblio–
teca di conservazione, cioè a deposito casuale e di–
sarticolato di libri purchessia, magari insigni per pre–
gio e rarità, ma disutili a qualsiasi organico lavoro
di ricerca.
Nelle pagine che seguono, in questo numero e ancora
nel prossimo, i benemeriti Direttori delle principali
raccolte librarie torinesi illustrano o illustreranno le
vicende storiche e i cimeli insigni delle Istituzioni cui
essi presiedono. Prima di accostarsi a cosÌ illustri ri–
cordi, vorrei che il lettore sentisse un piccolo brivido
di apprensione e di allarme : la scienza moderna si
sviluppa, in tutti i campi, con rapidità vertiginosa, la
produzione libraria mondiale si dilata anno per anno
con ritmi impressionanti; il bisogno di libri, col cre–
scere del tenore di vita e delle più che legittime aspi–
razioni al sapere, tende a dilagare. Sarebbe grave per
il nostro avvenire che la grande e operosa Torino del
secolo XX nori riuscisse a compiere per le proprie bi–
blioteche quello che seppe realizzare a suo tempo, con
alta consapevolezza civile, la piccola capitale del Re–
gno Sardo.
Luigi Firpo
21


















