
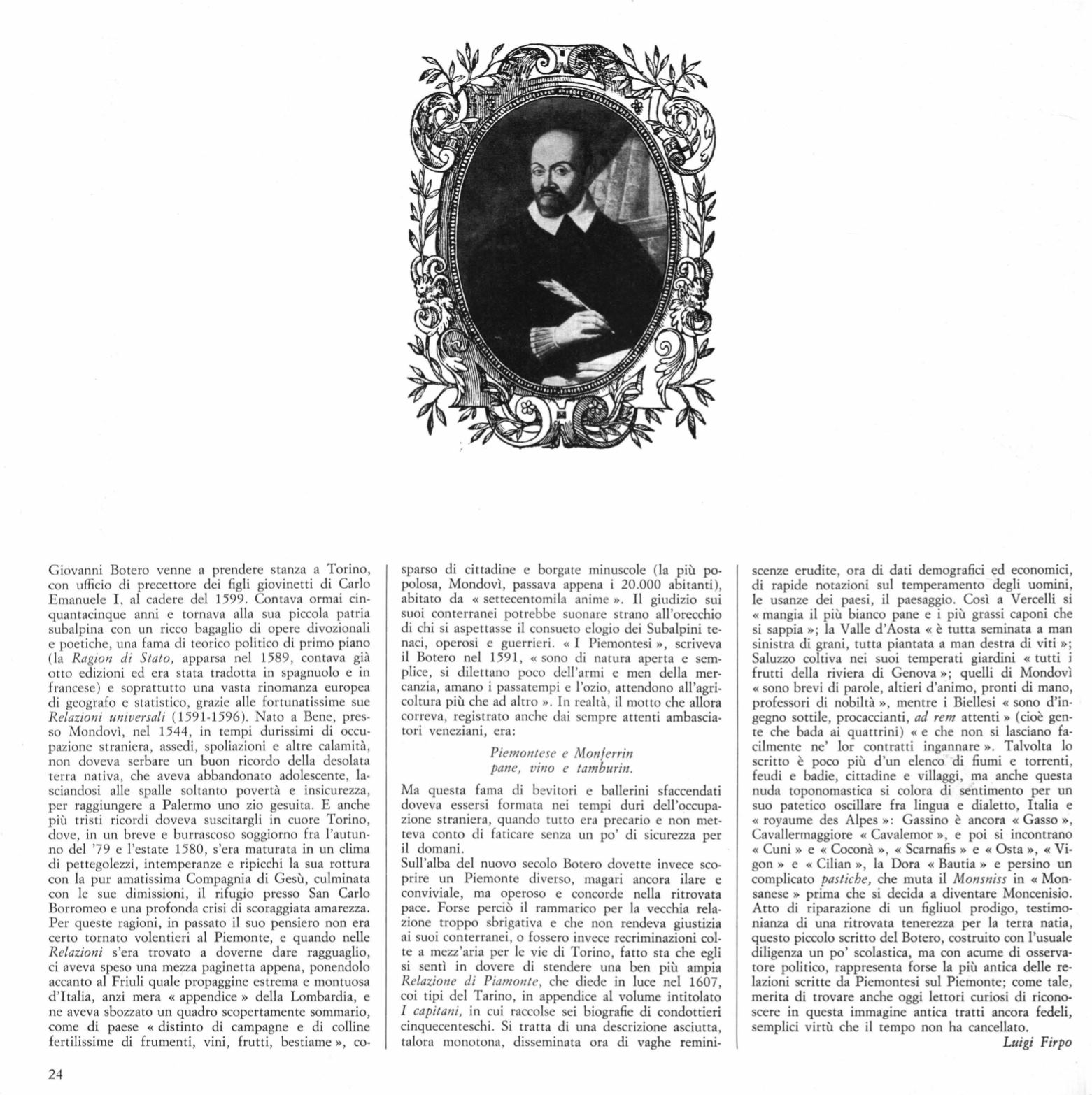
Giovanni Botero venne a prendere stanza a Torino,
con ufficio di precettore dei figli giovinetti di Carlo
Emanuele
1.
al cadere del 1599. Contava ormai cin–
quantacinque anni e tornava alla sua piccola patria
subalpina con un ricco bagaglio di opere divozionali
e poetiche, una fama di teorico politico di primo piano
(la
Ragion di Stato,
apparsa nel 1589, contava già
otto edizioni ed era stata tradotta in spagnuolo e in
francese) e soprattutto una vasta rinomanza europea
di geografo e statistico, grazie alle fortunatissime sue
Relazioni universali
(1591-1596). Nato a Bene, pres–
so Mondovì, nel 1544, in tempi durissimi di occu–
pazione straniera, assedi, spoliazioni e altre calamità,
non doveva serbare un buon ricordo della desolata
terra nativa, che aveva abbandonato adolescente, la–
sciandosi alle spalle soltanto povertà e insicurezza,
per raggiungere a Palermo uno zio gesuita. E anche
più tristi ricordi doveva suscitargli in cuore Torino,
dove, in un breve e burrascoso soggiorno fra l'autun–
no del '79 e l'es tate 1580, s'era maturata in un clima
di pettegolezzi, intemperanze e ripicchi la sua rottura
con la pur amatissima Compagnia di Gesù, culminata
con le sue dimissioni , il rifugio presso San Carlo
Borromeo e una profonda crisi di scoraggiata amarezza.
Per queste ragioni, in passato il suo pensiero non era
certo tornato volentieri al Piemonte, e quando nelle
Relazioni
s'era trovato a doverne dare ragguaglio,
ci aveva speso una mezza paginetta appena, ponendolo
accanto al Friuli quale propaggine estrema e montuosa
d 'Italia, anzi mera « appendice» della Lombardia, e
ne aveva sbozzato un quadro scopertamente sommario,
come di paese «distinto di campagne e di colline
fertilissime di frumenti , vini, frutti, bestiame », co-
24
sparso di cittadine e borgate minuscole (la pLU po–
polosa, Mondovì, passava appena i 20 .000 abitanti),
abitato da « settecentomila anime
».
Il giudizio sui
suoi conterranei potrebbe suonare strano all'orecchio
di chi si aspettasse il consueto elogio dei Subaipini te–
naci , operosi e guerrieri.
«
I Piemontesi », scriveva
il
Botero nel 1591 ,
«
sono di nat ura aperta e sem–
plice, si dilettano poco dell'armi e men della mer–
canzia, amano i passatempi e l'ozio, attendono all'agri–
coltura più che ad altro ». In realtà,
il
motto che allora
correva, registrato anche dai sempre attenti ambascia–
tori veneziani, era:
Piemontese e Monferrin
pane, vino e tamburino
Ma questa fama di bevitori e ballerini sfaccendati
doveva essersi formata nei tempi duri dell'occupa–
zione straniera, quando tutto era precario e non met–
teva conto di faticare senza un po' di sicurezza per
il
domani.
Sull'alba del nuovo secolo Botero dovette invece sco–
prire un Piemonte diverso, magari ancora ilare e
conviviale, ma operoso e concorde nella ritrovata
pace. Forse perciò il rammarico per la vecchia rela–
zione troppo sbrigativa e che non rendeva giustizia
ai suoi conterranei, o fossero invece recriminazioni col–
te a mezz'aria per le vie di Torino, fatto sta che egli
si sentì in dovere di stendere una ben più ampia
Relazione di Piamonte,
che diede in luce nel 1607,
coi tipi del Tarino, in appendice al volume intitolato
I capitani,
in cui raccolse sei biografie di condottieri
cinquecen teschi. Si tratta di una descrizione asciutta,
talora monotona, disseminata ora di vaghe remini-
scenze erudite, ora di dati demografici ed economiCi,
di rapide notazioni sul temperamento degli uomini ,
le usanze dei paesi, il paesaggio. Così a Vercelli si
«
mangia
il
più bianco pane e i più grassi caponi che
si sappia »; la Valle d 'Aosta « è tutta seminata a man
sinistra di grani, tutta piantata a man destra di viti »;
Saluzzo coltiva nei suoi temperati giardini «tutti
i
frutti della riviera di Genova»; quelli di Mondovì
« sono brevi di parole, altieri d'animo, pronti
di
mano,
professori di nobiltà », mentre i Biellesi « sono d'in–
gegno sottile, procaccianti,
ad rem
attenti» (cioè gen–
te che bada ai quattrini) « e che non si lasciano fa–
cilmente ne ' lor contratti ingannare ». Talvolta lo
scritto è poco più d 'un elenco di fiumi e torrenti ,
feudi e badie, cittadine e villaggi, ma anche questa
nuda toponomastica si colora di sentimento per un
suo patetico oscillare fra lingua e dialetto, Italia e
« royaume des Alpes
»:
Gassino è ancora « Gasso» ,
Cavallermaggiore «Cavalemor », e poi si incontrano
« Cuni » e « Coconà », « Scarnafis » e « Osta », «Vi–
gon» e
«
Cilian », la Dora «Bautia» e persino un
complicato
pastiche,
che muta il
Monsniss
in «Mon·
sanese
»
prima che si decida a diventare Moncenisio.
Atto di riparazione
di
un figliuol prodigo, testimo–
nianza di una ritrovata tenerezza per la terra natia,
questo piccolo scritto del Botero, costruito con l'usuale
diligenza un po' scolastica, ma con acume di osserva–
tore politico, rappresenta forse la più antica delle re–
lazioni scritte da Piemontesi sul Piemonte ; come tale,
merita di trovare anche oggi lettori curiosi di ricono–
scere in questa immagine antica tratti ancora fedeli,
semplici virtù che il tempo non ha cancellato.
Luigi Firpo


















