
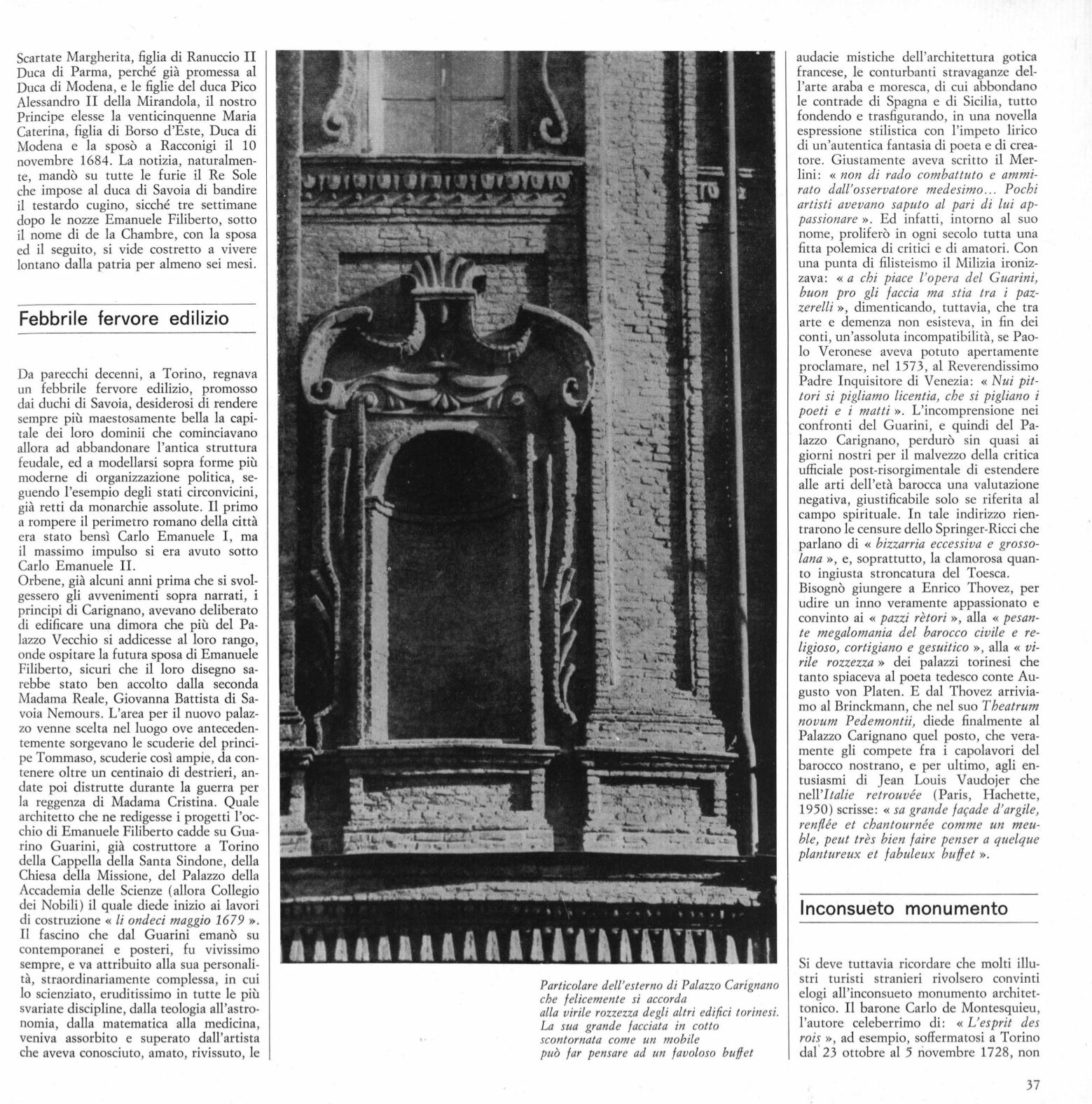
Scartate Margherita, figlia di Ranuccio
II
Duca di Parma, perché già promessa al
Duca di Modena, e le figlie del duca Pico
Alessandro
II
della Mirandola, il nostro
Principe elesse la venticinquenne Maria
Caterina, figlia di Borso d'Este, Duca di
Modena e la sposò a Racconigi il
lO
novembre 1684. La notizia, naturalmen–
te, mandò su tutte le furie il Re Sole
che impose al duca di Savoia di bandire
il
testardo cugino, sicché tre settimane
dopo le nozze Emanuele Filiberto, sotto
il
nome di de la Chambre, con la sposa
ed
il
seguito, si vide costretto a vivere
lontano dalla patria per almeno sei mesi.
Febbrile fervore edilizio
Da parecchi decenni, a Torino, regnava
un febbrile fervore edilizio, promosso
dai duchi di Savoia, desiderosi di rendere
sempre più maestosamente bella la capi–
tale dei loro dominii che cominciavano
allora ad abbandonare l'antica struttura
feudale, ed a modellarsi sopra forme più
moderne di organizzazione politica, se–
guendo l'esempio degli stati circonvicini,
già retti da monarchie assolute.
Il
primo
a rompere
il
perimetro romano della città
era stato bensi Carlo Emanuele I , ma
il massimo impulso si era avuto sotto
Carlo Emanuele
II.
Orbene, già alcuni anni prima che si svol–
gessero gli avvenimenti sopra narrati, i
principi di Carignano, avevano deliberato
di edificare una dimora che più del Pa–
lazzo Vecchio si addicesse alloro rango,
onde ospitare la futura sposa di Emanuele
Filiberto, sicuri che il loro disegno sa–
rebbe stato ben accolto dalla seconda
Madama Reale, Giovanna Battista di Sa–
voia Nemours. L'area per il nuovo palaz–
zo venne scelta nel luogo ove anteceden–
temente sorgevano le scuderie del princi–
pe Tommaso, scuderie così ampìe, da con–
tenere oltre un centinaio di destrieri, an–
date poi distrutte durante la guerra per
la reggenza di Madama Cristina. Quale
architetto che ne redigesse i progetti l'oc–
chio di Emanuele Filiberto cadde su Gua–
rino Guarini, già costruttore a Torino
della Cappella della Santa Sindone, della
Chiesa della Missione, del Palazzo della
Accademia delle Scienze (allora Collegio
dei Nobili) il quale diede inizio ai lavori
di costruzione
«
li ondeci maggio
1679
».
Il fascino che dal Guarini emanò su
contemporanei e posteri, fu vivissimo
sempre, e va attribuito alla sua personali–
tà, straordinariamente complessa, in cui
lo scienziato, eruditissimo in tutte le più
svariate discipline, dalla teologia all'astro–
nomia, dalla matematica alla medicina,
veniva assorbito e superato dall'artista
che aveva conosciuto, amato, rivissuto, le
Particolare dell'esterno di Palazzo Carignano
che felicemente si accorda
alla virile rozzezza degli altri edifici torinesi.
La sua grande facciata in cotto
scontornata come un mobile
può far pensare ad un favoloso buffet
audacie mistiche dell'architettura gotica
francese, le conturbanti stravaganze del–
l'arte araba e moresca, di cui abbondano
le contrade di Spagna e di Sicilia, tutto
fondendo e trasfigurando, in una novella
espressione stilistica con l'impeto lirico
di un'autentica fantasia di poeta e di crea–
tore . Giustamente aveva scritto il Mer–
lini :
«non di rado combattuto e ammi–
rato dall'osservatore medesimo ... Pochi
artisti avevano saputo al pari di lui ap–
passionare
».
Ed infatti, intorno al suo
nome, proliferò in ogni secolo tutta una
fitta polemica di critici e di amatori. Con
una punta di filisteismo
il
Milizia ironiz–
zava:
«a chi piace l'opera del Guarini,
buon pro gli faccia ma stia tra i paz–
zerelli
»,
dimenticando, tuttavia, che tra
arte e demenza non esisteva, in fin dei
conti, un'assoluta incompatibilità, se Pao–
lo Veronese aveva potuto apertamente
proclamare, nel 1573, al Reverendissimo
Padre Inquisitore di Venezia :
«Nui pit–
tori si pigliamo licentia, che si pigliano i
poeti e i matti
».
L'incomprensione nei
confronti del Guarini, e quindi del Pa–
lazzo Carignano, perdurò sin quasi ai
giorni nostri per il malvezzo della critica
ufficiale post-risorgimentale di estendere
alle arti dell'età barocca una valutazione
negativa, giustificabile solo se riferita al
campo spirituale . In tale indirizzo rien–
trarono le censure dello Springer-Ricci che
parlano di
«
bizzarria eccessiva e grosso–
lana
»,
e, soprattutto, la clamorosa quan–
to ingiusta stroncatura del Toesca.
Bisognò giungere a Enrico Thovez, per
udire un inno veramente appassionato e
convinto ai
«
pazzi rètori
»,
alla
«
pesan–
te megalomania del barocco civile e re–
ligioso, cortigiano e gesuitico
»,
alla
«
vi–
rile rozzezza»
dei palazzi torinesi che
tanto spiaceva al poeta tedesco conte Au–
gusto von Platen. E dal Thovez arrivia–
mo al Brinckmann, che nel suo T
heatrum
novum Pedemontii,
diede finalmente al
Palazzo Carignano quel posto, che vera–
mente gli compete fra i capolavori del
barocco nostrano, e per ultimo, agli en–
tusiasmi di Jean Louis Vaudojer che
nell'Italie retrouvée
(Paris, Bachette,
1950) scrisse:
«
sa grande façade d'argile,
renflée et chantournée camme un meu–
ble, peut très bien faire penser a quelque
plantureux et fabuleux buffet
».
Inconsueto monumento
Si deve tuttavia ricordare che molti illu–
stri turisti stranieri rivolsero convinti
elogi all'inconsueto monumento architet–
tonico.
Il
barone Carlo de Montesquieu,
l'autore celeberrimo di :
«L'esprit des
rois
»,
ad esempio, soffermatosi a Torino
dal' 23 ottobre al 5 novembre 1728, non
37


















