
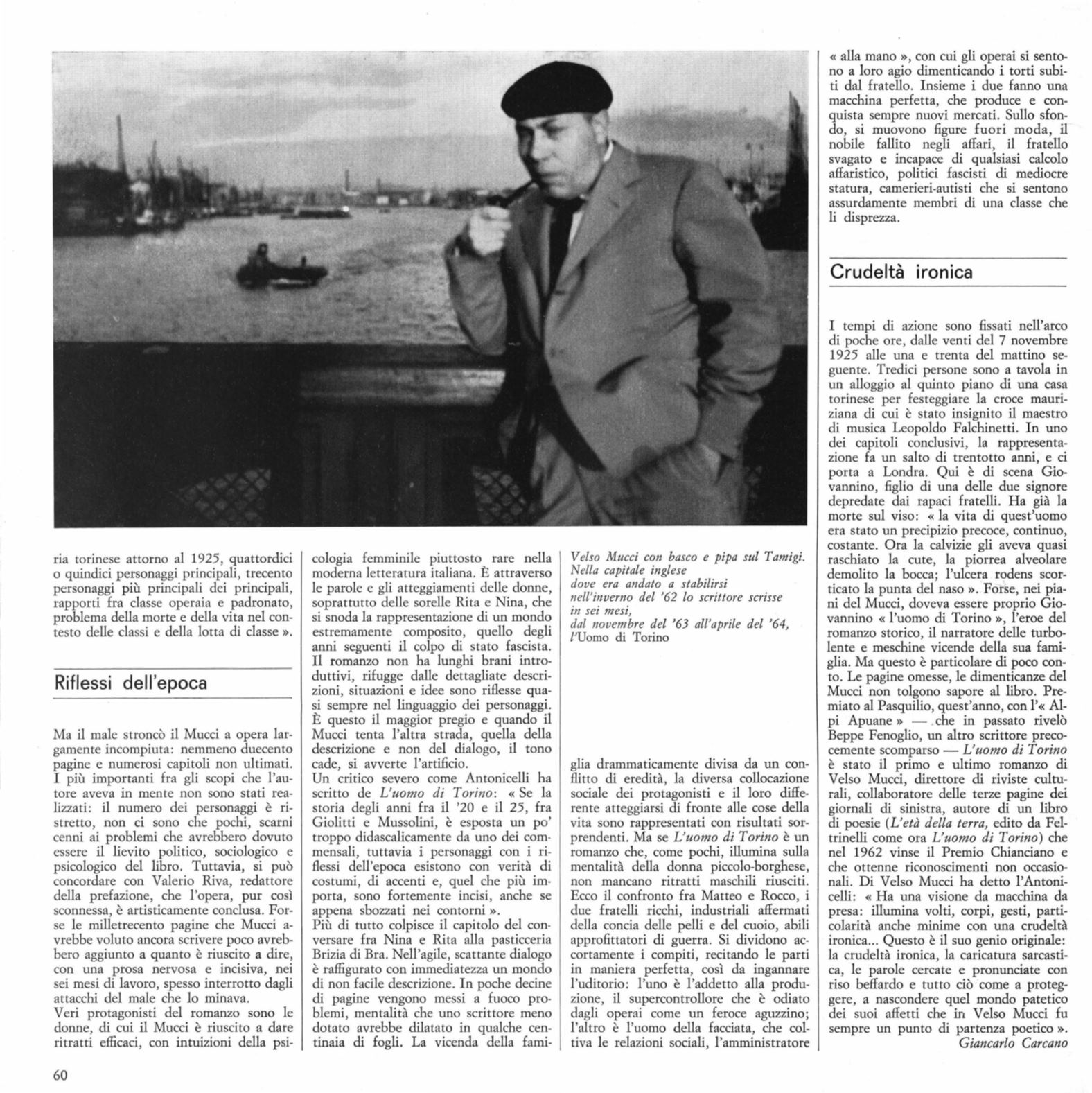
ria torinese attorno al 1925, quattordici
o quindici personaggi principali, trecento
personaggi più principali dei principali,
rapporti fra classe operaia e padronato,
problema della morte e della vita nel con–
testo delle classi e della lotta di classe ».
Riflessi dell'epoca
Ma il male stroncò il Mucci a opera lar–
gamente incompiuta: nemmeno duecento
pagine e numerosi capitoli non ultimati.
I più importanti fra gli scopi che l'au–
tore aveva in mente non sono stati rea–
lizzati:
il
numero dei personaggi è ri–
stretto, non ci sono che pochi, scarni
cenni ai problemi che avrebbero dovuto
essere
il
lievito politico, sociologico e
psicologico del libro. Tuttavia, si può
concordare con Valerio Riva, redattore
della prefazione, che l'opera, pur cosÌ
sconnessa, è artisticamente conclusa. For–
se le milletrecento pagine che Mucci a–
vrebbe voluto ancora scrivere poco avreb–
bero aggiunto a quanto è riuscito a dire,
con una prosa nervosa e incisiva, nei
sei mesi di lavoro, spesso interrotto dagli
attacchi del male che lo minava.
Veri protagonisti del romanzo sono le
donne, di cui il Mucci è riuscito a dare
ritratti efficaci, con intuizioni della psi-
60
cologia femminile piuttosto rare nella
moderna letteratura italiana.
È
attraverso
le parole e gli atteggiamenti delle donne,
soprattutto delle sorelle Rita e Nina, che
si snoda la rappresentazione di un mondo
estremamente composito, quello degli
anni seguenti il colpo di stato fascista.
Il romanzo non ha lunghi brani intro–
duttivi, rifugge dalle dettagliate descri–
zioni, situazioni e idee sono riflesse qua–
si sempre nel linguaggio dei personaggi.
È
questo
il
maggior pregio e quando
il
Mucci tenta l'altra strada, quella della
descrizione e non del dialogo, il tono
cade, si avverte l'artificio.
Un critico severo come Antonicelli ha
scritto de
L'uomo di Torino:
«Se la
storia degli anni fra
il
'20 e
il
25, fra
Giolitti e Mussolini, è esposta un po'
troppo didascalicamente da uno dei com·
mensali, tuttavia i personaggi con i ri–
flessi dell'epoca esistono con verità di
costumi, di accenti e, quel che più imo
porta, sono fortemente incisi, anche se
appena sbozzati nei contorni ».
Più di tutto colpisce il capitolo del con·
versare fra Nina e Rita alla pasticceria
Brizia di Bra. Nell'agile, scattante dialogo
è raffigurato con immediatezza un mondo
di non facile descrizione. In poche decine
di pagine vengono messi a fuoco pro·
blemi, mentalità che uno scrittore meno
dotato avrebbe dilatato in qualche cen–
tinaia di fogli. La vicenda della farni-
V elso Mucci con basco e pipa sul Tamigi.
Nella capitale inglese
dove era andato a stabilirsi
nell'inverno del
'62
lo scrittore scrisse
in sei mesi,
dal novembre del
'63
all'aprile del '64,
l'Uomo
di Torino
glia drammaticamente divisa da un con–
flitto di eredità, la diversa collocazione
sociale dei protagonisti e il loro diffe–
rente atteggiarsi di fronte alle cose della
vita sono rappresentati con risultati sor–
prendenti. Ma se
L'uomo di Torino
è un
romanzo che, come pochi, illumina sulla
mentalità della donna piccolo-borghese,
non mancano ritratti maschili riusciti.
Ecco il confronto fra Matteo e Rocco, i
due fratelli ricchi, industriali affermati
della concia delle pelli e del cuoio, abili
approfittatori di guerra. Si dividono ac·
cortamente i compiti, recitando le parti
in maniera perfetta, così da ingannare
l'uditorio: l'uno è l'addetto alla produ–
zione, il supercontrollore che è odiato
dagli operai come un feroce aguzzino;
l'altro è l'uomo della facciata, che col–
tiva le relazioni sociali, l'amministratore
« alla mano
»,
con cui gli operai si sento–
no a loro agio dimenticando i torti subi–
ti dal fratello. Insieme i due fanno una
macchina perfetta, che produce e con–
quista sempre nuovi mercati. Sullo sfon–
do, si muovono figure fuori moda, il
nobile fallito negli affari,
il
fratello
svagato e incapace di qualsiasi calcolo
affaristico, politici fascisti di mediocre
statura, camerieri-autisti che si sentono
assurdamente membri di una classe che
li disprezza.
Crudeltà IrOnica
I tempi di azione sono fissati nell'arco
di poche ore, dalle venti del 7 novembre
1925 alle una e trenta del mattino se–
guente. Tredici persone sono a tavola in
un alloggio al quinto piano di una casa
torinese per festeggiare la croce mauri–
ziana di cui è stato insignito il maestro
di musica Leopoldo Falchinetti. In uno
dei capitoli conclusivi, la rappresenta–
zione fa un salto di trentotto anni, e ci
porta a Londra. Qui è di scena Gio–
vannino, figlio di una delle due signore
depredate dai rapaci fratelli. Ha già la
morte sul viso: «la vita di quest'uomo
era stato un precipizio precoce, continuo,
costante. Ora la calvizie gli aveva quasi
raschiato la cute, la piorrea alveolare
demolito la bocca; l'ulcera rodens scor–
ticato la punta del naso
».
Forse, nei pia–
ni del Mucci, doveva essere proprio Gio–
vannino « l'uomo
di
Torino », l'eroe del
romanzo storico,
il
narratore delle turbo–
lente e meschine vicende della sua fami–
glia. Ma questo è particolare di poco con–
to. Le pagine omesse, le dimenticanze del
Mucci non tolgono sapore al libro. Pre–
miato al Pasquilio, quest'anno, con 1'« Al–
pi Apuane» - che in passato rivelò
Beppe Fenoglio, un altro scrittore preco–
cemente scomparso -
L'uomo di Torino
è stato
il
primo e ultimo romanzo di
Velso Mucci, direttore di riviste cultu–
rali, collaboratore delle terze pagine dei
giornali di sinistra, autore di un libro
di poesie
(L'età della terra,
edito da Fel–
trineHi come ora
L'uomo di
T
orino)
che
nel 1962 vinse il Premio Chianciano e
che ottenne riconoscimenti non occasio–
nali. Di Velso Mucci ha detto l'Antoni–
ceHi: «Ha una visione da macchina da
presa: illumina volti, corpi, gesti, parti–
colarità anche minime con una crudeltà
ironica... Questo è il suo genio originale:
la crudeltà ironica, la caricatura sarcasti–
ca, le parole cercate e pronunciate con
riso beffardo e tutto ciò come a proteg–
gere, a nascondere quel mondo patetico
dei suoi affetti che in Velso Mucci fu
sempre un punto di partenza poetico
».
Giancarlo Carcano


















