
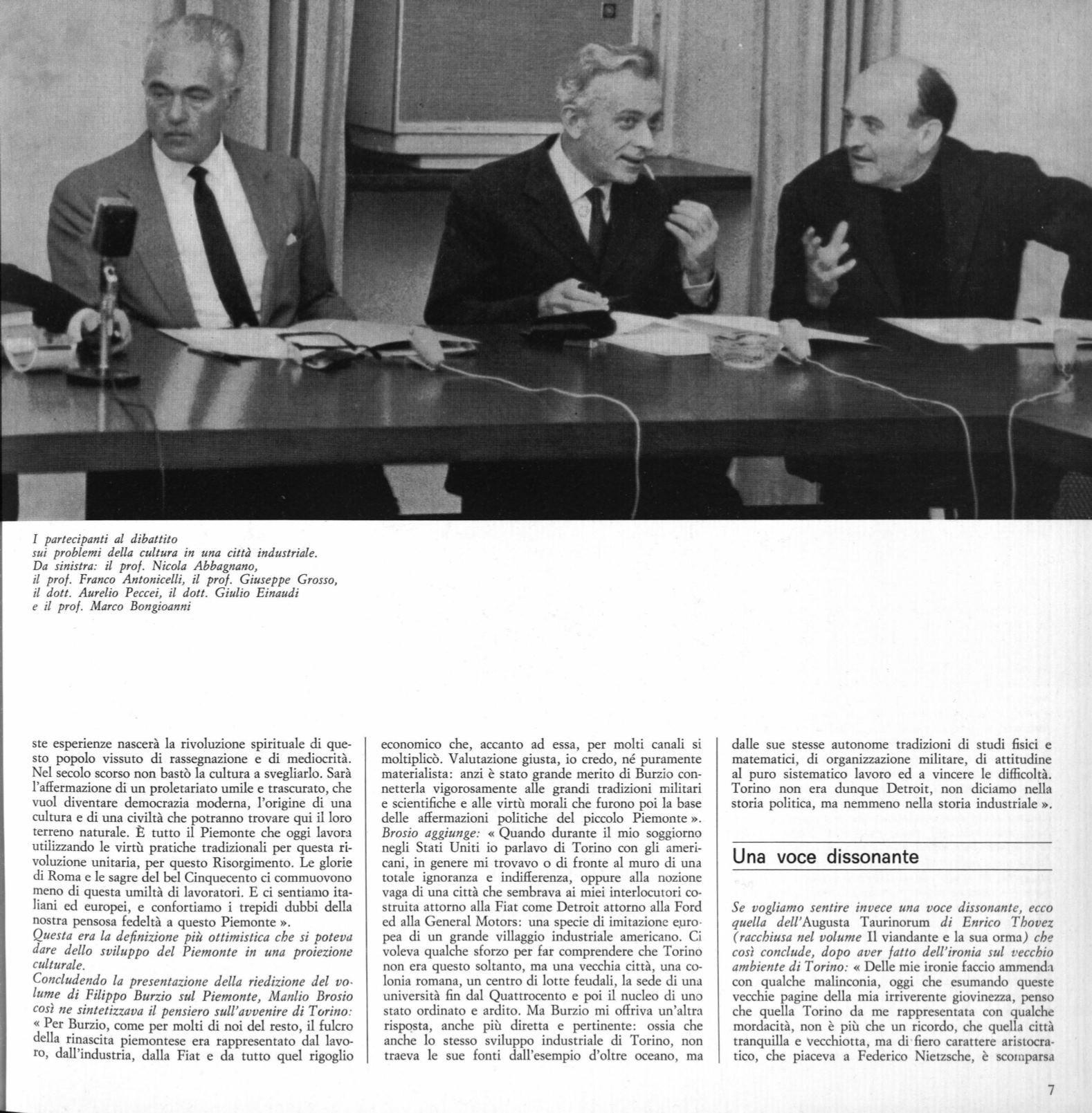
I partecipanti al dibattito
sui problemi della cultura in una città industriale.
Da sinistra: il pro/. Nicola Abbagnano,
il pro!. Franco Antonicelli, il pro!. Giuseppe Grosso,
il dotto Aurelio Peccei, il dotto Giulio Einaudi
e il pro/. Marco Bongioanni
ste esperienze nascerà la rivoluzione spirituale di que–
sto popolo vissuto di rassegnazione e di mediocrità.
Nel secolo scorso non bastò la cultura a svegliarlo. Sarà
l'affermazione di un proletariato umile e trascurato, che
vuoI diventare democrazia moderna, l'origine di una
cultura e di una civiltà che potranno trovare qui
il
loro
terreno naturale.
È
tutto
il
Piemonte che oggi lavora
utilizzando le virtù pratiche tradizionali per questa ri–
voluzione unitaria, per questo Risorgimento. Le glorie
di Roma e le sagre del bel Cinquecento ci commuovono
meno di questa umiltà di lavoratori. E ci sentiamo ita–
liani ed europei, e confortiamo i trepidi dubbi della
nostra pensosa fedeltà a questo Piemonte
».
Questa era la definizione più ottimistica che si poteva
dare dello sviluppo del Piemonte in una proiezione
culturale.
Concludendo la presentazione della riedizione del vo·
lume di Filippo Burzio sul Piemonte, Manlio Brosio
così ne sintetizzava il pensiero sull'avvenire di Torino:
«
Per Burzio, come per molti di noi del resto, il fulcro
della rinascita piemontese era rappresentato dal lavo–
ro, dall'industria, dalla Fiat e da tutto quel rigoglio
economico che, accanto ad essa, per molti canali si
moltiplicò. Valutazione giusta, io credo, né puramente
materialista: anzi è stato grande merito di Burzio con–
netterla vigorosamente alle grandi tradizioni militari
e scientifiche e alle virtù morali che furono poi la base
delle affermazioni politiche del piccolo Piemonte
».
Brosio aggiunge:
«Quando durante
il
mio soggiorno
negli Stati Uniti io parlavo di Torino con gli amerl–
cani, in genere mi trovavo o di fronte al muro di una
totale ignoranza e indifferenza, oppure alla nozione
vaga di una città che sembrava ai miei interlocutori co–
struita attorno alla Fiat come Detroit attorno alla Ford
ed alla GeneraI Motors: una specie di imitazione e.uro ·
pea di un grande villaggio industriale americano. Ci
voleva qualche sforzo per far comprendere che Torino
non era questo soltanto, ma una vecchia città, una co–
lonia romana, un centro di lotte feudali, la sede di una
università fin dal Quattrocento e poi il nucleo di uno
stato ordinato e ardito. Ma Burzio mi offriva un'altra
rispQsta, anche più diretta e pertinente: ossia che
anche lo stesso sviluppo industriale di Torino, non
traeva le sue fonti dall'esempio d'oltre oceano, ma
dalle sue stesse autonome tradizioni di studi fisici e
matematici, di organizzazione militare, di attitudine
al puro sistematico lavoro ed a vincere le difficoltà.
Torino non era dunque Detroit, non diciamo nella
storia politica, ma nemmeno nella storia industriale
».
Una voce dissonante
Se vogliamo sentire invece una voce dissonante, ecco
quella dell'Augusta
Taurinorum
di Enrico Tbovez
(racchiusa nel volume
Il viandante e la sua orma)
che
così conclude, dopo aver fatto dell'ironia sul vecchio
ambiente di Torino:
« Delle mie ironie faccio ammend:l
con qualche malinconia, oggi che esumando queste
vecchie pagine della mia irriverente giovinezza, penso
che quella Torino da me rappresentata con qualche
mordacità, non
è
più che un ricordo, che quella città
tranquilla e vecchiotta, ma di ,fiero carattere aristocra–
tico, che piaceva a Federico Nietzsche, è scomparsa
7


















