
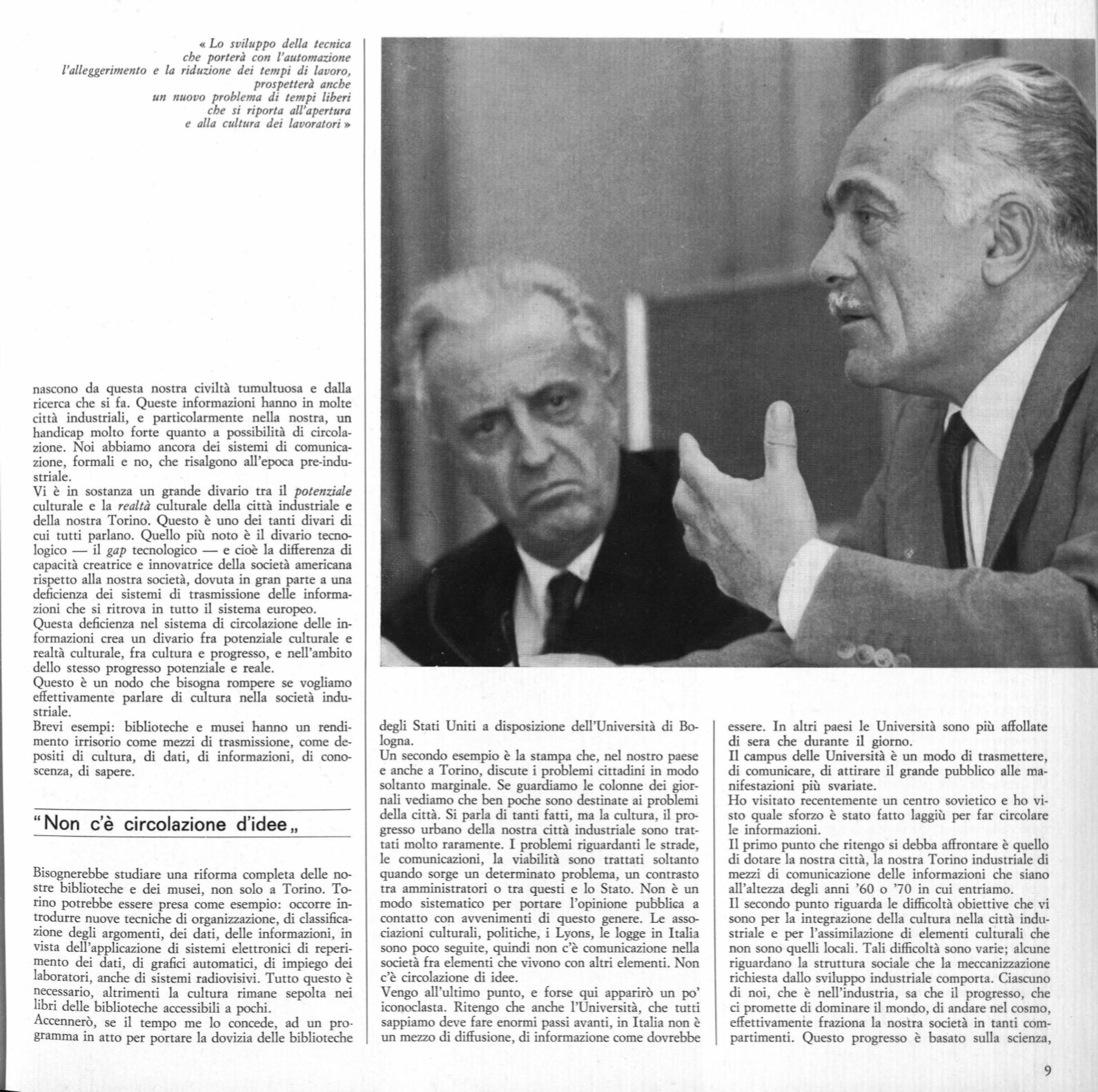
«Lo sviluppo della tecnica
che porterà con l'automazione
l'alleggerimento e la riduzione dei tempi di lavoro,
prospetterà anche
un nuovo problema di tempi liberi
che si riporta all'apertura
e alla cultura dei lavoratori»
nascono da questa nostra civiltà tumultuosa e dalla
ricerca che si fa. Queste informazioni hanno in molte
città industriali, e particolarmente nella nostra, un
handicap molto forte quanto a possibilità di circola–
zione. Noi abbiamo ancora dei sistemi di comunica–
zione, formali e no, che risalgono all'epoca pre-indu–
striale.
Vi è in sostanza un grande divario tra il
potenziale
culturale e la
realtà
culturale della città industriale e
della nostra Torino. Questo è uno dei tanti divari di
cui tutti parlano. Quello più noto è il divario tecno–
logico - il
gap
tecnologico - e cioè la differenza di
capacità creatrice e innovatrice della società americana
rispetto alla nostra società, dovuta in gran parte a una
deficienza dei sistemi di trasmissione delle informa–
zioni che si ritrova in tutto il sistema europeo.
Questa deficienza nel sistema di circolazione delle in–
formazioni crea un divario fra potenziale culturale e
realtà culturale, fra cultura e progresso, e nell'ambito
dello stesso progresso potenziale e reale.
Questo è un nodo che bisogna rompere se vogliamo
effettivamente parlare di cultura nella società indu–
striale.
Brevi esempi: biblioteche e musei hanno un rendi–
mento irrisorio come mezzi di trasmissione, come de–
positi di cultura, di dati, di informazioni, di cono–
scenza, di sapere.
"Non c'è circolazione d'idee"
Bisognerebbe studiare una riforma completa delle no–
stre biblioteche e dei musei, non solo a Torino. To–
rino potrebbe essere presa come esempio: occorre in–
trodurre nuove tecniche di organizzazione, di classifica–
zione degli argomenti, dei dati, delle informazioni, in
vista dell'applicazione di sistemi elettronici di reperi–
mento dei dati, di grafici automatici, di impiego dei
laboratori, anche di sistemi radiovisivi. Tutto questo è
necessario, altrimenti la cultura rimane sepolta nei
libri delle biblioteche accessibili a pochi.
Accennerò, se il tempo me lo concede, ad un pro·
gramma in atto per portare la dovizia delle biblioteche
degli Stati Uniti a disposizione dell'Università di Bo–
logna.
Un secondo esempio è la stampa che, nel nostro paese
e anche a Torino, discute i problemi cittadini in modo
soltanto marginale. Se guardiamo le colonne dei gior–
nali vediamo che ben poche sono destinate ai problemi
della città. Si parla di tanti fatti, ma la cultura, il pro–
gresso urbano della nostra città industriale sono trat–
tati molto raramente. I problemi riguardanti le strade,
le comunicazioni, la viabilità sono trattati soltanto
quando sorge un determinato problema, un contrasto
tra amministratori o tra questi e lo Stato. Non è un
modo sistematico per portare l'opinione pu1JbliGa a
contatto con avvenimenti di questo genere. Le asso–
ciazioni culturali, politiche, i Lyons, le logge in Italia
sono poco seguite, quindi non c'è comunicazione nella
società fra elementi che vivono con altri elementi. Non
c'è circolazione di idee.
Vengo all'ultimo punto, e forse qui apparirò un po'
iconoclasta. Ritengo che anche l'Università, che tutti
sappiamo deve fare enormi passi avanti, in Italia non è
un mezzo di diffusione, di informazione come dovrebbe
essere. In altri paesi le Università sono più affollate
di sera che durante il giorno.
Il campus delle Università è un modo di trasmettere,
di comunicare, di attirare il grande pubblico alle ma–
nifestazioni più svariate.
Ho visitato recentemente un centro sovietico e ho vi–
sto quale sforzo è stato fatto laggiù per far circolare
le informazioni.
Il primo punto che ritengo si debba affrontare è quello
di dotare la nostra città, la nostra Torino industriale di
mezzi di comunicazione delle informazioni che siano
all'altezza degli anni '60 o '70 in cui entriamo.
Il secondo punto riguarda le difficoltà obiettive che vi
sono per la integrazione della cultura nella città indu–
striale e per l'assimilazione di elementi culturali che
non sono quelli locali. Tali difficoltà sono varie; alcune
riguardano la struttura sociale che la meccanizzazione
richiesta dallo sviluppo industriale comporta. Ciascuno
di noi, che è nell'industria, sa che il progresso, che
ci promette di dominare il mondo, di andare nel cosmo,
effettivamente fraziona la nostra società in tanti com–
partimenti. Questo progresso è basato sulla scienza,
9


















