
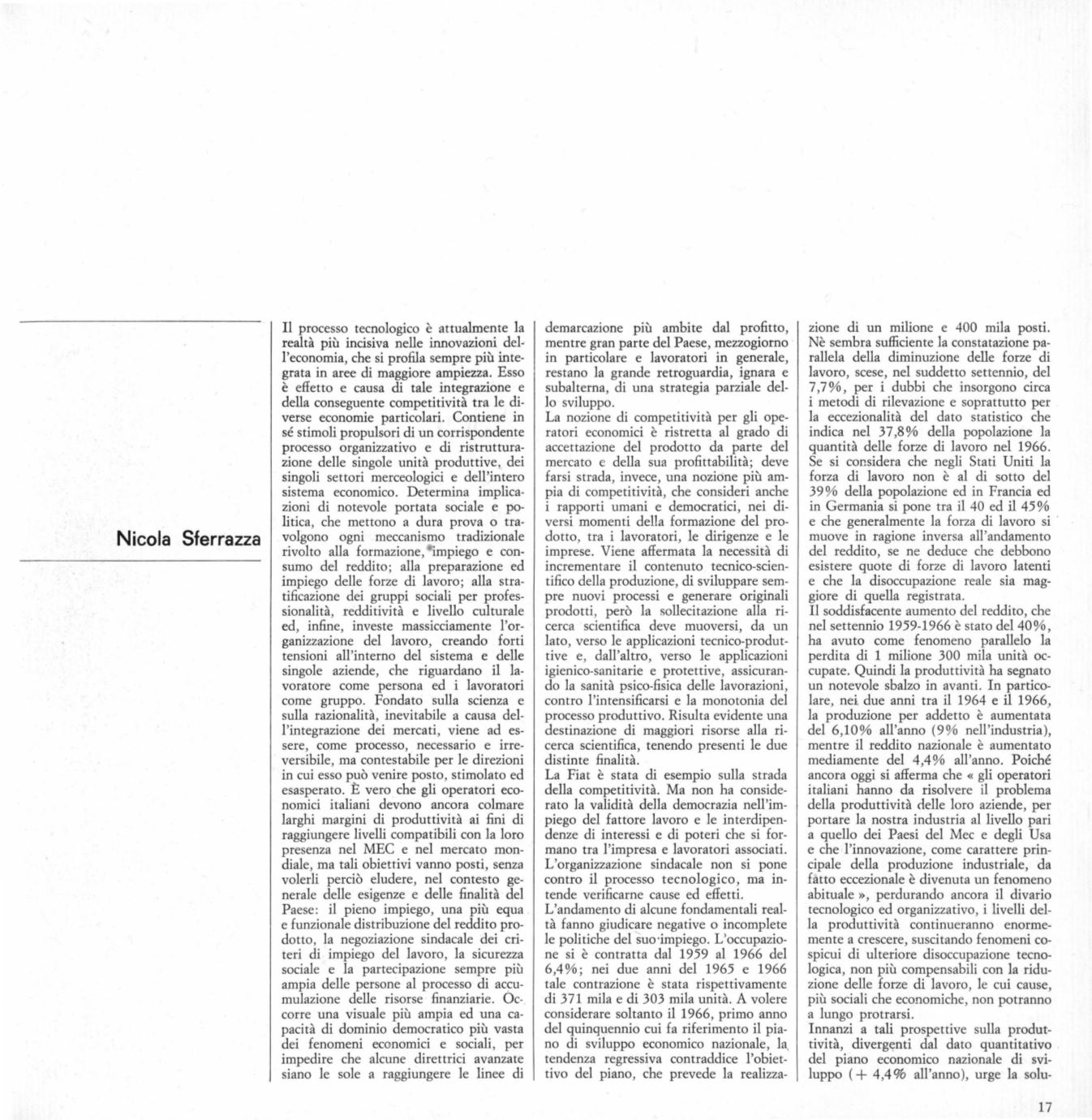
Nicola Sferrazza
Il processo tecnologico è attualmente la
realtà più incisiva nelle innovazioni del–
l'economia, che si profila sempre più inte–
grata in aree di maggiore ampiezza. Esso
è effetto e causa di tale integrazione e
della conseguente competitività tra le
di–
verse economie particolari. Contiene in
sé stimoli propulsori di un corrispondente
processo organizzativo e
di
ristruttura–
zione delle singole unità produttive, dei
singoli settori merceologici e dell'intero
sistema economico. Determina implica–
zioni di notevole portata sociale e po–
litica, che mettono a dura prova o tra–
volgono ogni meccanismo tradizionale
rivolto alla formazione, impiego e con–
sumo del reddito; alla preparazione ed
impiego delle forze di lavoro; alla stra–
tificazione dei gruppi sociali per profes–
sionalità, redditività e livello culturale
ed, infine, investe massicciamente l'or–
ganizzazione del lavoro, creando forti
tensioni all'interno del sistema e delle
singole aziende, che riguardano
il
la–
voratore come persona ed i lavoratori
come gruppo . Fondato sulla scienza e
sulla razionalità, inevitabile a causa del–
l'integrazione dei mercati, viene ad es–
sere, come processo, necessario e irre-
. versibile, ma contestabile per le direzioni
in cui esso può venire posto, stimolato ed
esasperato.
È
vero che gli operatori eco–
nomici italiani devono ancora colmare
larghi margini di produttività ai fini di
raggiungere livelli compatibili con la loro
presenza nel MEC e nel mercato mon–
diale, ma tali obiettivi vanno posti, senza
volerli perciò eludere, nel contesto ge–
nerale delle esigenze e delle finalità del
Paese: il pieno impiego, una più equa
e funzionale distribuzione del reddito pro–
dotto , la negoziazione sindacale dei cri–
teri di impiego del lavoro, la sicurezza
sociale e la partecipazione sempre più
ampia delle persone al processo di accu–
mulazione delle risorse finanziarie. Oc–
corre una visuale più ampia ed una ca–
pacità di dominio democratico più vasta
dei fenomeni emnomici e sociali, per
impedire che alcune direttrici avanzate
siano le sole a raggiungere le linee di
demarcazione più ambite dal profitto,
mentre gran parte del Paese, mezzogiorno
in particolare e lavoratori in generale,
restano la grande retroguardia, ignara e
subalterna, di una strategia parziale del–
lo sviluppo.
La nozione di competitività per gli ope–
ratori economici è ristretta al grado di
accettazione del prodotto da parte del
mercato e della sua profittabilità; deve
farsi strada, invece, una nozione più am–
pia di competitività, che consideri anche
i rapporti umani e democratici, nei di–
versi momenti della formazione del pro–
dotto, tra i lavoratori, le dirigenze e le
imprese. Viene affermata la necessità di
incrementare il contenuto tecnico-scien–
tifico della produzione, di sviluppare sem–
pre nuovi processi e generare originali
prodotti, però la sollecitazione alla ri–
cerca scientifica deve muoversi, da un
lato, verso le applicazioni tecnico-produt–
tive e, dall'altro, verso le applicazioni
igienico-sanitarie e protettive, assicuran–
do la sanità psico-fisica delle lavorazioni,
contro l'intensificarsi e la monotonia del
processo produttivo. Risulta evidente una
destinazione di maggiori risorse alla ri–
cerca scientifica, tenendo presenti le due
distinte finalità .
La Fiat è stata di esempio sulla strada
della competitività. Ma non ha conside–
rato la validità della democrazia nell'im–
piego del fattore lavoro e le interdipen–
denze di interessi e di poteri che si for–
mano tra l'impresa e lavoratori associati.
L'organizzazione sindacale non si pone
contro il processo tecnologico, ma in–
tende verificarne cause ed effetti.
L'andamento
di
alcune fondamentali real–
tà fanno giudicare negative o incomplete
le politiche del s uo ·impiego. L'occupazio–
ne si è contratta dal 1959 al 1966 del
6,4%; nei due anni del 1965 e 1966
tale contrazione è stata rispettivamente
di 371 mila e di 303 mila unità. A volere
considerare soltanto il 1966, primo anno
del quinquennio cui fa riferimento il pia–
no di sviluppo economico nazionale, la,
tendenza regressiva contraddice l'obiet–
tivo del piano, che prevede la realizza-
zione di un milione e 400 mila posti.
Nè sembra sufficiente la constatazione pa–
rallela della diminuzione delle forze di
lavoro, scese, nel suddetto settennio, del
7,7%, per i dubbi che insorgono circa
i metodi di rilevazione e soprattutto per
la eccezionalità del dato statistico che
indica nel 37,8
%
della popolazione la
quantità delle forze di lavoro nel 1966.
Se si considera che negli Stati Uniti la
forza di lavoro non è al di sotto del
39% della popolazione ed in Francia ed
in Germania si pone tra il 40 ed il 45%
e che generalmente la forza di lavoro si .
muove in ragione inversa all'andamento
del reddito, se ne deduce che debbono
esistere quote di forze di lavoro latenti
e che la disoccupazione reale sia mag–
giore di quella registrata.
Il soddisfacente aumento del reddito, che
nel settennio 1959-1966 è stato del 40%,
ha avuto come fenomeno parallelo la
perdita di 1 milione 300 mila unità oc–
cupate. Quindi la produttività ha segnato
un notevole sbalzo in avanti. In partico–
lare, nei due anni tra il 1964 e
il
1966)
la produzione per addetto è aumentata
del 6,10% all'anno (9% nell'industria),
mentre
il
reddito nazionale è aumentato
mediamente del 4,4% all'anno. Poiché
ancora oggi si afferma che
«
gli operatori
italiani hanno da risolvere
il
problema
della produttività delle loro aziende, per
portare la nostra industria al livello pari
a quello dei Paesi del Mec e degli Usa
e che l'innovazione, come carattere prin–
cipale della produzione industriale, da
fatto eccezionale è divenuta un fenomeno
abituale
»,
perdurando ancora il divario
tecnologico ed organizzativo, i livelli del–
la produttività continueranno enorme–
mente a crescere, suscitando fenomeni co–
spicui di ulteriore disoccupazione tecno–
logica, non più compensabili con la ridu–
zione delle forze di lavoro, le cui cause,
più sociali che economiche, non potranno
a lungo protrarsi.
Innanzi a tali prospettive sulla produt–
tività, divergçnti dal dato quantitativo .
del piano economico nazionale di svi–
luppo
(+
4,4% all'anno), urge la solu-
17


















