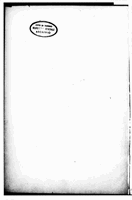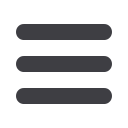
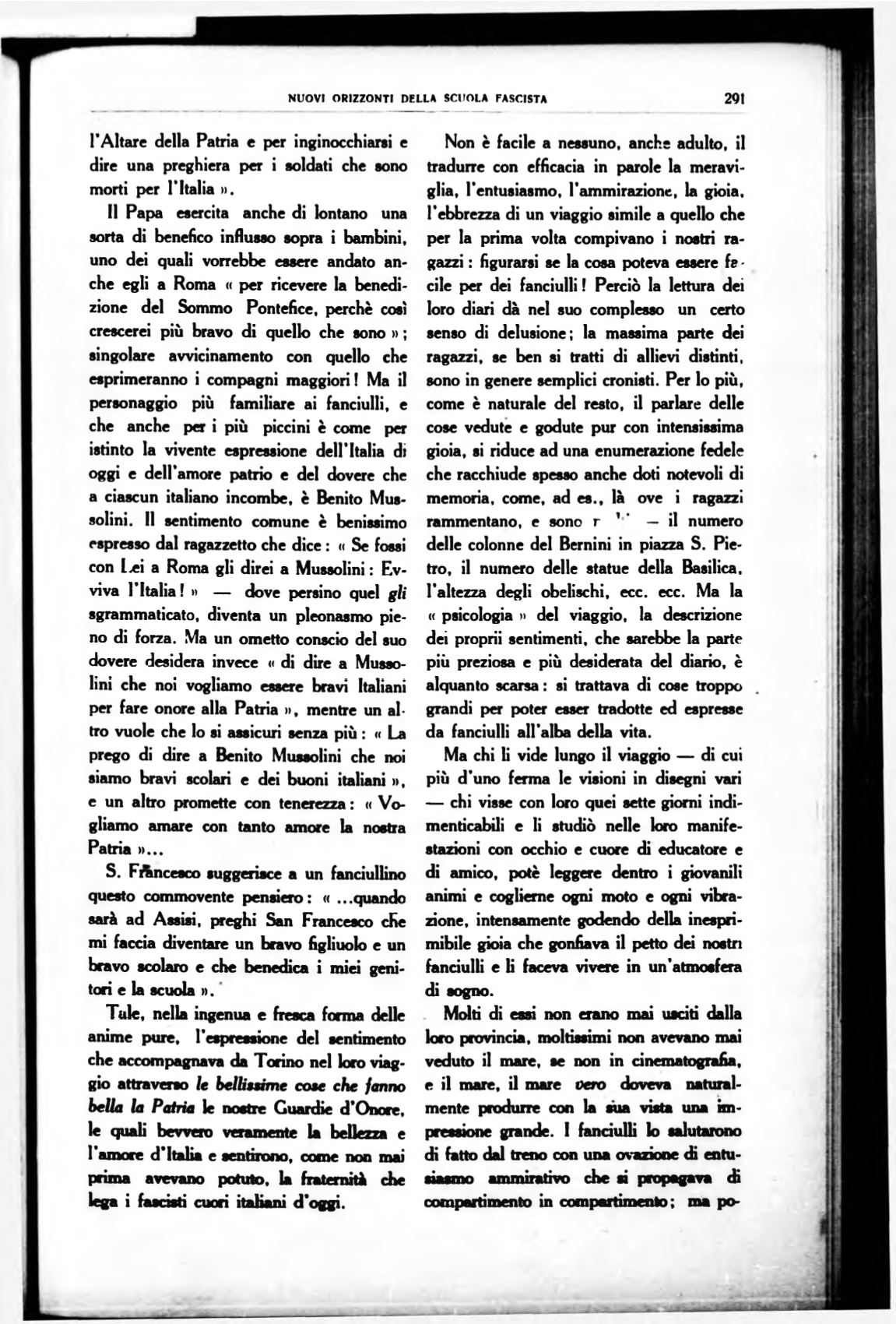
NUOV I OR IZZONT I DELLA SCUOLA FASCISTA
291
l’Altare della Patria e per inginocchiarsi e
dire una preghiera per i soldati che sono
morti per l ’Italia ».
Il Papa esercita anche di lontano una
sorta di benefico influsso sopra i bambini,
uno dei quali vorrebbe essere andato an
che egli a Roma « per ricevere la benedi
zione del Sommo Pontefice, perchè così
crescerei più bravo di quello che sono » ;
singolare avvicinamento con quello che
esprimeranno i compagni maggiori ! Ma il
personaggio più familiare ai fanciulli, e
che anche per i più piccini è come per
istinto la vivente espressione dell'Italia di
oggi e dell'amore patrio e del dovere che
a ciascun italiano incombe, è Benito Mus
solini. Il sentimento comune è benissimo
espresso dal ragazzetto che dice : « Se fossi
con L^i a Roma gli direi a Mussolini : Ev
viva l ’Italia! » — dove persino quel
gli
sgrammaticato, diventa un pleonasmo pie
no di forza. Ma un ometto conscio del suo
dovere desidera invece « di dire a Musso
lini che noi vogliamo essere bravi Italiani
per fare onore alla Patria », mentre un al
tro vuole che lo si assicuri senza più : « La
prego di dire a Benito Mussolini che noi
siamo bravi scolari e dei buoni italiani »,
e un altro promette con tenerezza : « Vo
gliamo amare con tanto amore la nostra
Patria » ...
S. Francesco suggerisce a un fanciullino
questo commovente pensiero: « ...quando
sarà ad Assisi, preghi San Francesco che
mi faccia diventare un bravo figliuolo e un
bravo scolaro e che benedica i miei geni
tori e la scuola ».
Tale, nella ingenua e fresca forma delle
anime pure, l’espressione del sentimento
che accompagnava da Torino nel loro viag
gio attraverso
le bellissime cose che fanno
bella la Patria
le nostre Guardie d'Onore,
le quali bevvero veramente la bellezza e
l ’amore d'Italia e sentirono, come non mai
prima avevano potuto, la fraternità die
lega i fascisti cuori italiani d'oggi.
Non è facile a nessuno, anche adulto, il
tradurre con efficacia in parole la meravi
glia, l’entusiasmo, l’ammirazione, la gioia,
l'ebbrezza di un viaggio simile a quello che
per la prima volta compivano i nostri ra
gazzi : figurarsi se la cosa poteva essere fe -
cile per dei fanciulli ! Perciò la lettura dei
loro diari dà nel suo complesso un certo
senso di delusione; la massima parte dei
ragazzi, se ben si tratti di allievi distinti,
sono in genere semplici cronisti. Per lo più,
come è naturale del resto, il parlare delle
cose vedute e godute pur con intensissima
gioia, si riduce ad una enumerazione fedele
che racchiude spesso anche doti notevoli di
memoria, come, ad es., là ove i ragazzi
rammentano, e sono
r
1 ’
—
il numero
delle colonne del Bernini in piazza S. Pie
tro, il numero delle statue della Basilica,
l'altezza degli obelischi, ecc. ecc. Ma la
« psicologia » del viaggio, la descrizione
dei proprii sentimenti, che sarebbe la parte
più preziosa e più desiderata del diario, è
alquanto scarsa : si trattava di cose troppo
grandi per poter esser tradotte ed espresse
da fanciulli all'alba della vita.
Ma chi li vide lungo il viaggio — di cui
più d'uno ferma le visioni in disegni vari
— chi visse con loro quei sette giorni indi
menticabili e li studiò nelle loro manife
stazioni con occhio e cuore di educatore e
di amico, potè leggere dentro i giovanili
animi e coglierne ogni moto e ogni vibra
zione, intensamente godendo della inespri
mibile gioia che gonfiava il petto dei nostri
fanciulli e li faceva vivere in un’atmosfera
di sogno.
Molti di essi non erano mai usciti dalla
loro provincia, moltissimi non avevano mai
veduto il mare, se non in cinematografia,
e il mare, il mare
vero
doveva natural
mente produrre con la sua vista una im
pressione grande. 1 fanciulli lo salutarono
di fatto dal treno con una ovazione di entu
siasmo ammirativo che si propagava di
compartimento in compartimento; ma pò