
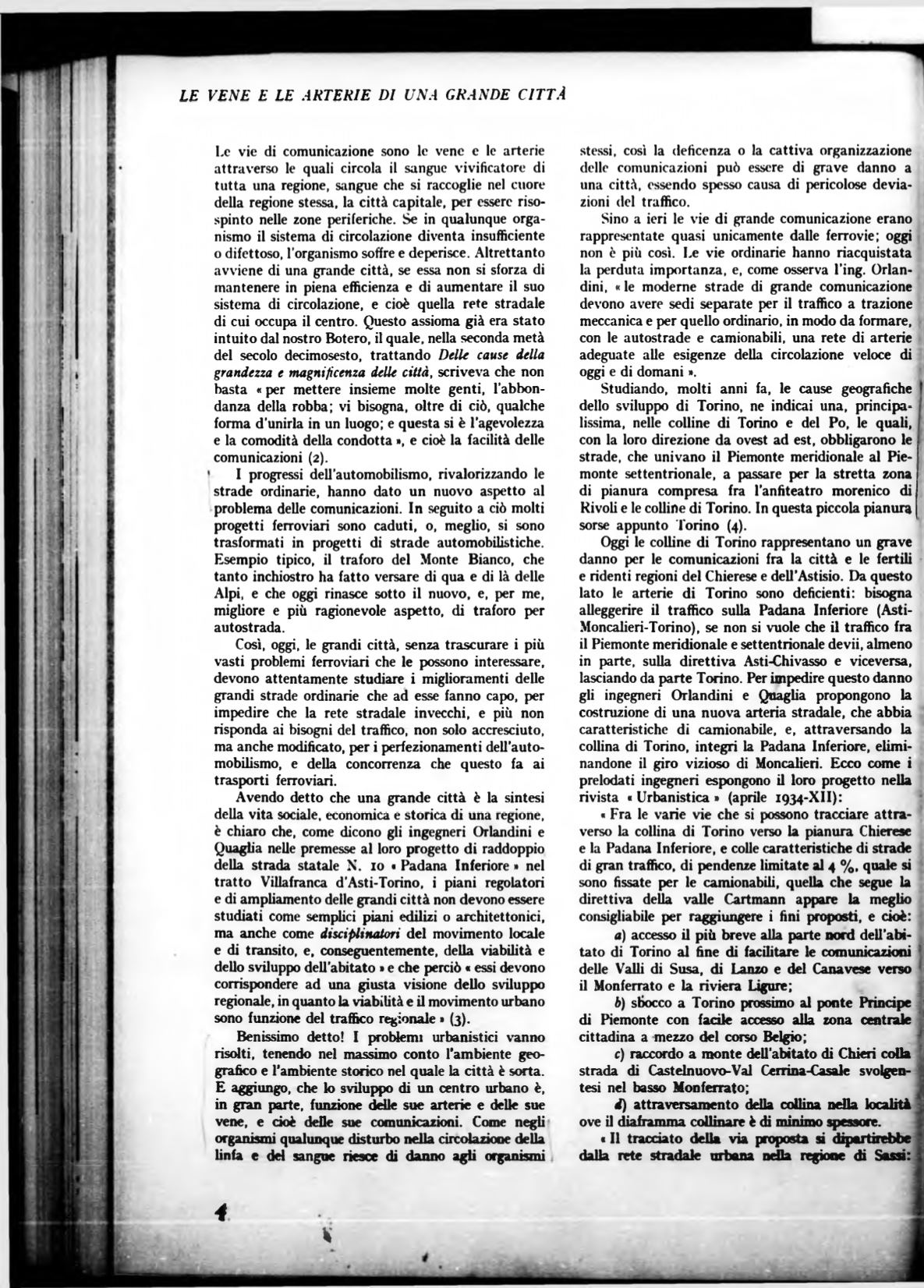
LE VENE E LE ARTER IE DI UNA GRANDE C I TTÀ
Le vie di comunicazione sono le vene e le arterie
attraverso le quali circola il sangue vivificatore di
tutta una regione, sangue che si raccoglie nel cuore
della regione stessa, la città capitale, per essere riso
spinto nelle zone periferiche. Se in qualunque orga
nismo il sistema di circolazione diventa insufficiente
o difettoso, l’organismo soffre e deperisce. Altrettanto
avviene di una grande città, se essa non si sforza di
mantenere in piena efficienza e di aumentare il suo
sistema di circolazione, e cioè quella rete stradale
di cui occupa il centro. Questo assioma già era stato
intuito dal nostro Botero, il quale, nella seconda metà
del secolo decimosesto, trattando
Delle cause della
grandezza e magnificenza delle città,
scriveva che non
basta «per mettere insieme molte genti, l’abbon
danza della robba; vi bisogna, oltre di ciò, qualche
forma d ’unirla in un luogo; e questa si è l ’agevolezza
e la comodità della condotta », e cioè la facilità delle
comunicazioni (2).
I
progressi dell’automobilismo, rivalorizzando le
strade ordinarie, hanno dato un nuovo aspetto al
problema delle comunicazioni. In seguito a ciò molti
progetti ferroviari sono caduti, o, meglio, si sono
trasformati in progetti di strade automobilistiche.
Esempio tipico, il traforo del Monte Bianco, che
tanto inchiostro ha fatto versare di qua e di là delle
Alpi, e che oggi rinasce sotto il nuovo, e, per me,
migliore e più ragionevole aspetto, di traforo per
autostrada.
Così, oggi, le grandi città, senza trascurare i più
vasti problemi ferroviari che le possono interessare,
devono attentamente studiare i miglioramenti delle
grandi strade ordinarie che ad esse fanno capo, per
impedire che la rete stradale invecchi, e più non
risponda ai bisogni del traffico, non solo accresciuto,
ma anche modificato, per i perfezionamenti dell’auto
mobilismo, e della concorrenza che questo fa ai
trasporti ferroviari.
Avendo detto che una grande città è la sintesi
della vita sociale, economica e storica di una regione,
è chiaro che, come dicono gli ingegneri Orlandini e
Quaglia nelle premesse al loro progetto di raddoppio
della strada statale N. 10 « Padana Inferiore » nel
tratto Villafranca d ’Asti-Torino, i piani regolatori
e di ampliamento delle grandi città non devono essere
studiati come semplici piani edilizi o architettonici,
ma anche come
disciplinatori
del movimento locale
e di transito, e, conseguentemente, della viabilità e
dello sviluppo dell'abitato »e che perciò « essi devono
corrispondere ad una giusta visione dello sviluppo
regionale, in quanto la viabilità e il movimento urbano
sono funzione del traffico regionale » (3).
Benissimo detto! I problemi urbanistici vanno
risolti, tenendo nel massimo conto l'ambiente geo
grafico e l’ambiente storico nel quale la città è sorta.
E aggiungo, che lo sviluppo di un centro urbano è,
in gran parte, funzione delle sue arterie e delle sue
vene, e cioè delle sue comunicazioni. Come negli
organismi qualunque disturbo nella circolazione della
linfa
e
del
sangue riesce di danno agii organismi
stessi, così la deficenza o la cattiva organizzazione
delle comunicazioni può essere di grave danno a
una città, essendo spesso causa di pericolose devia
zioni del traffico.
Sino a ieri le vie di grande comunicazione erano
rappresentate quasi unicamente dalle ferrovie; oggi
non
è
più così. Le vie ordinarie hanno riacquistata
la perduta importanza, e, come osserva l ’ing. Orlan
dini, «le moderne strade di grande comunicazione
devono avere sedi separate per il traffico a trazione
meccanica e per quello ordinario, in modo da formare,
con le autostrade e camionabili, una rete di arterie
adeguate alle esigenze della circolazione veloce di
oggi e di domani ».
Studiando, molti anni fa, le cause geografiche
dello sviluppo di Torino, ne indicai una, principa
lissima, nelle colline di Torino e del Po, le quali,
con la loro direzione da ovest ad est, obbligarono le
strade, che univano il Piemonte meridionale al Pie
monte settentrionale, a passare per la stretta zona
di pianura compresa fra l’anfiteatro morenico di
Rivoli e le colline di Torino. In questa piccola pianura
sorse appunto Torino (4).
Oggi le colline di Torino rappresentano un grave
danno per le comunicazioni fra la città e le fertili
e ridenti regioni del Chierese e dell’Astisio. Da questo
lato le arterie di Torino sono deficienti: bisogna
alleggerire il traffico sulla Padana Inferiore (Asti-
Moncalieri-Torino), se non si vuole che il traffico fra
il Piemonte meridionale e settentrionale devii, almeno
in parte, sulla direttiva Asti-Chivasso e viceversa,
lasciando da parte Torino. Per impedire questo danno
gli ingegneri Orlandini e Quaglia propongono la
costruzione di una nuova arteria stradale, che abbia
caratteristiche di camionabile, e, attraversando la
collina di Torino, integri la Padana Inferiore, elimi
nandone il giro vizioso di Moncalieri. Ecco come i
prelodati ingegneri espongono il loro progetto nella
rivista «Urbanistica » (aprile 1934-XII):
«Fra le varie vie che si possono tracciare attra
verso la collina di Torino verso la pianura Chierese
e la Padana Inferiore, e colle caratteristiche di strade
di gran traffico, di pendenze limitate al 4 % , quale si
sono fissate per le camionabili, quella che segue la
direttiva della valle Cartmann appare la meglio
consigliabile per raggiungere i fini proposti, e cioè:
a)
accesso il più breve alla parte
nord
dell’abi
tato di Torino al fine di facilitare le comunicazioni
delle Valli di Susa, di Lanzo e del Canavese
verso
il Monferrato e la riviera Ligure;
b)
sbocco a Torino prossimo al ponte Principe
di Piemonte con facile accesso alla zona centrale
cittadina a mezzo del corso Belgio;
c) raccordo a monte dell’abitato di Chieri
colla
strada di Castelnuovo-Val Cerrina-Casale svolgen-
tesi nel basso Monferrato;
4
)
attraversamento della collina nella località
ove il
diaframma collinare
è
di minimo spessore.
•
Il tracciato della via proposta si dipartireb
dalla rete stradale urbana nella regione di Sassi:
4
%


















