
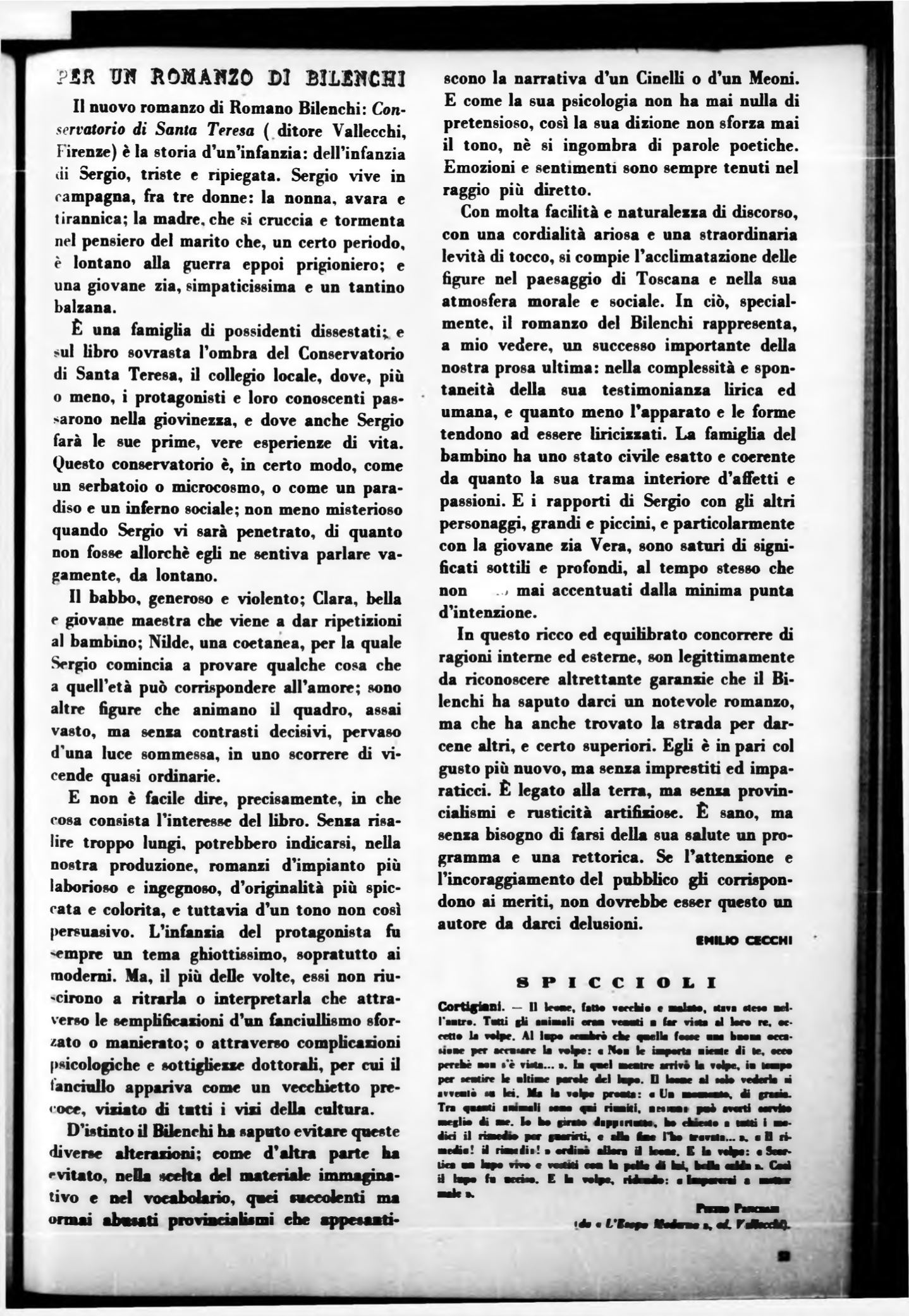
P I f t a if R
0
M À Ì
1 2 0
D I B I
1 1
M C H I
I l nuovo romanzo di Romano Bilench i:
Con
servatorio di Santa Teresa
( ditore Vallecchi,
Firenze) è la storia d’un’infanzia: dell’infanzia
cii
Sergio, triste e ripiegata. Sergio vive in
campagna, fra tre donne: la nonna, avara e
tirannica; la madre, che si cruccia e tormenta
nel pensiero del marito che, un certo perìodo,
è
lontano alla guerra eppoi prigioniero; e
una giovane zia, simpaticissima e un tantino
balzana.
È una famiglia di possidenti dissestati; e
sul libro sovrasta l’ombra del Conservatorio
di Santa Teresa, il collegio locale, dove, più
o meno, i protagonisti e loro conoscenti pas
sarono nella giovinezza, e dove anche Sergio
farà le sue prime, vere esperienze di v ita .
Questo conservatorio è, in certo modo, come
un serbatoio o microcosmo, o come un para
diso e un inferno sociale; non meno misterioso
quando Sergio v i sarà penetrato, di quanto
non fosse allorché egli ne sentiva parlare va
gamente, da lontano.
I l babbo, generoso e violento; Clara, bella
e giovane maestra che viene a dar ripetizioni
al bambino; Nilde, una coetanea, per la quale
Sergio comincia a provare qualche cosa che
a quell’età può corrispondere a ll’amore; sono
altre figure che animano il quadro, assai
vasto, ma senza contrasti decisivi, pervaso
d’una luce sommessa, in uno scorrere di v i
cende quasi ordinarie.
E non è facile dire, precisamente, in che
cosa consista l ’interesse del libro. Senza risa
lire troppo lungi, potrebbero indicarsi, nella
nostra produzione, romanzi d’impianto più
laborioso e ingegnoso, d’originalità più spic
cata e colorita, e tu ttavia d’un tono non così
persuasivo. L ’infanzia del protagonista fu
>empre un tema ghiottissimo, sopratutto ai
moderni. Ma, il più delle volte, essi non riu-
'cirono a ritraria o interpretarla che attra
verso le semplificazioni d’un fanciullismo sfor
zato o manierato; o attraverso complicazioni
psicologiche e sottigliezze dottorali, per cui il
fanciullo appariva come un vecchietto pre
coce, viziato di ta tti i vizi della cultura.
D ’istinto il Bilenchi ha saputo evitare queste
diverse alterazioni; come d’a ltra parte ha
^vitato, nella «celta del materiale immagina-
tivo e nel vocabolario, quei succolenti ma
ormai abusati provincialism i che appesanti*
scono la narrativa d’un C inelli o d’un Meoni.
E come la sua psicologia non ha mai nulla di
pretensioso, così la sua dizione non sforza mai
il tono, nè si ingombra di parole poetiche.
Emozioni e sentimenti sono sempre tenuti nel
raggio più diretto.
Con molta facilità e naturalezza di discorso,
con una cordialità ariosa e una straordinaria
levità di tocco, si compie l ’acclimatazione delle
figure nel paesaggio di Toscana e nella sua
atmosfera morale e sociale. In ciò, special-
mente, il romanzo del B ilench i rappresenta,
a mio vedere, un successo importante della
nostra prosa u ltim a: nella complessità e spon
taneità della sua testimonianza lirica ed
umana, e quanto meno l ’apparato e le forme
tendono ad essere liricizzati. L a famiglia del
bambino ha uno stato c iv ile esatto e coerente
da quanto la sua tram a interiore d’affetti e
passioni. E i rapporti di Sergio con gli a ltri
personaggi, grandi e piccini, e particolarmente
con la giovane zia Vera, sono saturi di signi
ficati so ttili e profondi, al tempo stesso che
non
..
j
mai accentuati dalla minima punta
d’intenzione.
In questo ricco ed equilibrato concorrere di
ragioni interne ed esterne, son legittimamente
da riconoscere altrettan te garanzie che il B i
lenchi ha saputo darci un notevole romanzo,
ma che ha anche trovato la strada per dar
cene a ltri, e certo superiori. Eg li è in pari col
gusto più nuovo, ma senza im prestiti ed impa
raticci. È legato a lla terra, ma senza provin
cialism i e rusticità artifiziose. È sano, ma
senza bisogno di farsi della sua salute un pro
gramma e una rettorica. Se l ’attenzione e
l’incoraggiamento del pubblico g li corrispon
dono ai m eriti, non dovrebbe esser questo un
autore da darci delusioni.
EMILIO CECCHI
S P I C C I O L I
Cortigiani. — Il Inm, fatto vecchio e Malato, stava tfeso ari-
l'an tro . T atti
gli aaiaaali eraa «casti
a
far
«irta al
br* re,
ce
retta la
valpe.
Al
lapa
«embrò
rbe
quella
foaee («a baona
oeea-
Mone per arrotare la wlpe: « Non le iaparta niente di le, ecco
perebè non
c'è vista... a. la quel mentre
arriva
la «alpe, ia Itap*
per
«entire
le altiatt parale del lapa.
D
leene al «ala vederla
ai
avventò
ta lei.
Ma
la volpe praaU:
a Ua
aaaeato, di graaia.
Tra
qaarti ammali «aaa qai ri
a a iti,
an a li pai averti aanrfea
meglio di aw. le ba girala dapprnam, ha ebanite
a
tatti i
me-
diri
il
ria ri» par gaarirti,
e
alla ina l'ha travaia...
a. a
D ri-
aiedia? il ria» di»!
a
ordina aliata il leene.
E
la volpe: aScor
tica
aa lapa
vtv» e
venni
een
la pelle di lai, bella calda
a.
Cari
il lapa fa acriaa.
E
la volpe, ridendo: a Impacerai a
aarttcr
aule
a.
hma Pw aia
•ria e
V
fa o p . « a d ra a a.
mL V d h n
if l


















