
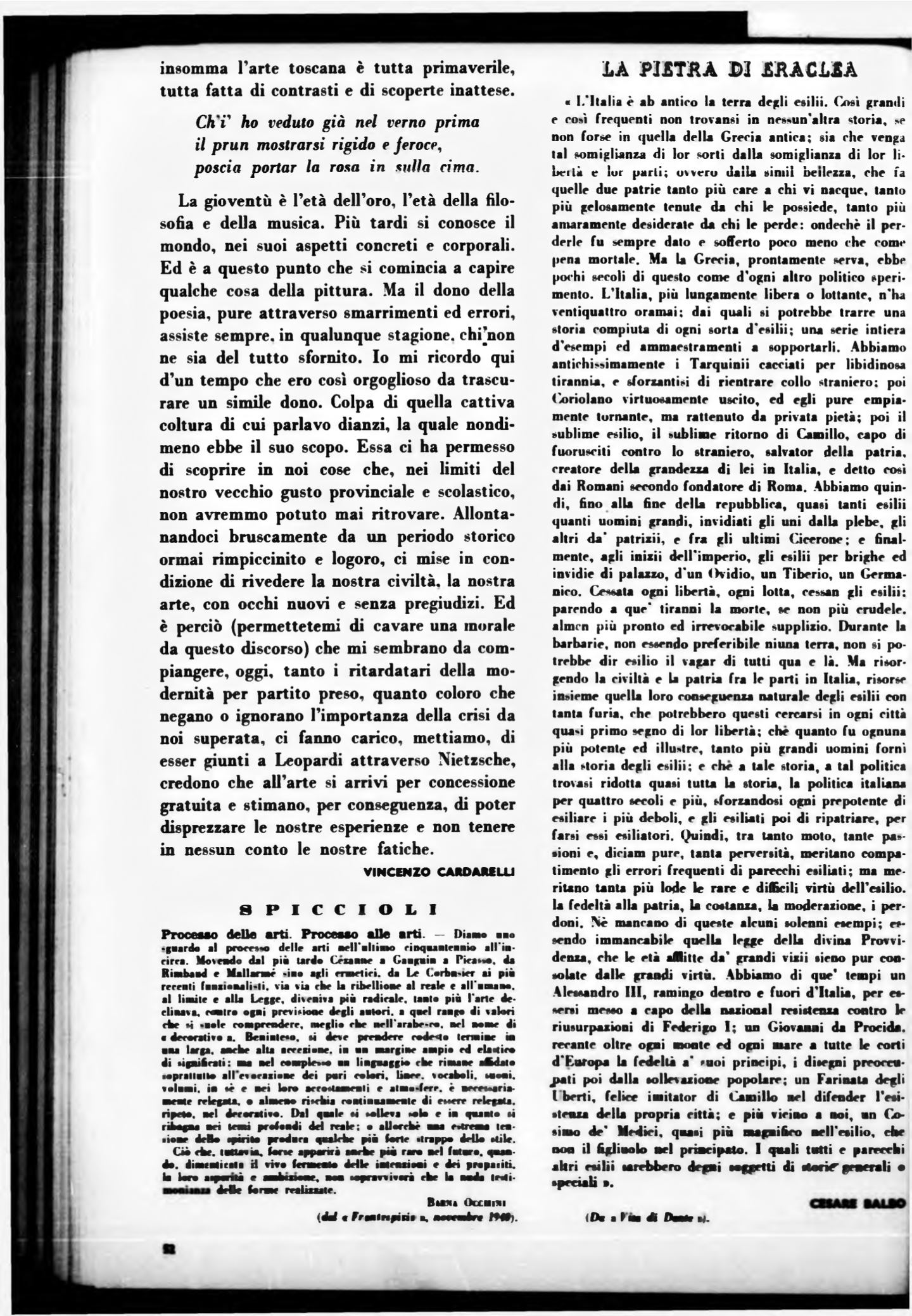
insomma l'a rte toscana è tu tta prim averile,
tu tta fatta di contrasti e di scoperte inattese.
Ch i' ho veduto già nel verno prima
il prun mostrarsi rigido e feroce,
poscia portar la rosa in sulla
cima.
La gioventù è l’età dell’oro, l’età della filo
sofia e della musica. P iù tard i si conosce il
mondo, nei suoi aspetti concreti e corporali.
Ed è a questo punto che si comincia a capire
qualche cosa della p ittura. Ma il dono della
poesia, pure attraverso smarrimenti ed errori,
assiste sempre, in qualunque stagione, chignon
ne sia del tutto sfornito. Io mi ricordo qui
d’un tempo che ero così orgoglioso da trascu
rare un sim ile dono. Colpa di quella cattiva
coltura di cui parlavo dianzi, la quale nondi
meno ebbe il suo scopo. Essa ci ha permesso
di scoprire in noi cose che, nei lim iti del
nostro vecchio gusto provinciale e scolastico,
non avremmo potuto mai ritrovare. A llonta
nandoci bruscamente da un periodo storico
ormai rim piccinito e logoro, ci mise in con
dizione di rivedere la nostra c iv iltà , la nostra
arte, con occhi nuovi e senza pregiudizi. Ed
è perciò (permettetem i di cavare una inorale
da questo discorso) che mi sembrano da com
piangere, oggi, tanto i ritard atari della mo
dernità per partito preso, quanto coloro che
negano o ignorano l’importanza della crisi da
noi superata, ci fanno carico, mettiamo, di
esser giunti a Leopardi attraverso Nietzsche,
credono che a ll’arte si a rriv i per concessione
gratuita e stimano, per conseguenza, di poter
disprezzare le nostre esperienze e non tenere
in nessun conto le nostre fatiche.
VINCENZO CARDARELLI
S P I C C I O L I
Processo delle a rti. Processo alle arti. — Diamo un»
-guardo al prom<o delle arti neU 'ullim o cinquantennio all'in-
rirra . Molenda dal più tardo C rianne a Gaugnin a Pira»»*, da
Rimbaud e M allarm é -ino afeli m a rtiri, da Le (-orbn-irr ai piè
rrrrn ti funzionali-li. via via che la ribellione al reale e all'umano,
al lim ite e alla Legge, di\eniva piè radicale, tanto piè l'arte de
clinava. contro ogni previsione degli autori, a quel rango di valori
che fri -noie comprendere, meglio che nell'arabe-co. nel nome di
• decorativo a. Beninteso, ri deve prendere codcMo termine in
■na larga, anche alta accezione, in un margine ampio ed elastico
di significati: ma nel complesso un linguaggio che rimane aSdato
soprattutto all e»orazione dei puri co lo ri, linee, vocaboli. Moni,
volum i, in tè e nei loro accoramenti e atmo-ferc. è necessaria
mente relegata, • almeno rischi» continuamente di essere relegata,
ripeto, nel decorativo . Dal quale ri solleva solo e in quanto ri
ribagna nei tem i prof ondi del reale; o allorché una estrema ten
sione dello spirito produca qualche p iè forte strappo dello stile.
Ciò che. tuttavia, forte apparirà anche piè rara nel futuro, quan
do. dimentirala H rivo fermento delle intenzioni e dei propaliti,
la loco asperità e Ambiatone, non sopravviverà rbe la nnda testi-
delle forme realizzate.
B in i
Occhiai
(da
I
a
f r m i n p iti t ».
a tm a b e
tWÈ).
là
p i è t r a
m
s r a c ls a
« I.‘ Ita lia è ab antico la terra degli esilii. Così granili
e così frequenti non trovanti in nessun’altra storia, se
non forse in quella della G recia antica; sia che venga
tal somiglianza di lor sorti dalla somiglianza di lor li-
iie ilà e Sor p a rli; ovvero dalla sintii bellezza, che fa
quelle due patrie tanto più care a chi v i nacque, tanto
più gelosamente tenute da chi le possiede, tanto più
amaramente desiderate da chi le perde: ondechè il per
derle fu sempre dato e sofferto poco meno che come
pena mortale. Ma la G recia, prontamente serva, ebbe
pochi secoli di questo come d'ogni altro politico speri
mento. L ’Ita lia , più lungamente libera o lottante, n'ha
ventiquattro oram ai; dai quali si potrebbe trarre una
storia compiuta di ogni sorta d 'e s ilii; una serie intiera
d'esempi ed ammaestramenti a sopportarli. Abbiamo
antichissimamente i Tarqu in ii cacciati per libidinosa
tirann ia, e sforzanti^ di rientrare collo straniero: poi
(W io la n o virtuosamente uscito, ed egli pure empia
mente tornante, ma rattenuto da privata pietà; poi il
sublime esilio, il sublime ritorno di Cam illo, capo di
fuorusciti contro lo straniero, salvator della patria,
creatore della grandezza d i lei in Ita lia , e detto cosi
dai Romani secondo fondatore di Roma. Abbiamo quin
d i, fino alla fine della repubblica, quasi tanti esilii
quanti uomini grandi, in vid ia ti gli uni dalla plebe, gli
a ltri d a ' patrizii, e fra gli u ltim i C icerone; e final
mente, agli in iz ii de ll'im perio , gli esilii per brighe ed
invidie di palazzo, d'un O vid io , un T iberio , un Germa
nico. Cessata ogni libertà, ogni lotta, cessan gli e s ilii:
parendo a que* tiranni la morte, se non più crudele,
aimrn più pronto ed irrevocabile supplizio. Durante la
barbarie, non essendo preferib ile niuna terra, non si po
trebbe d ir esilio il vagar d i tutti qua e là. Ma risor
gendo la civiltà e la patria fra le parti in Ita lia , risorse
insieme quella loro conseguenza naturale degli esilii con
tanta fu ria, che potrebbero questi cercarsi in ogni città
quasi primo segno di lor libertà ; che quanto fu ognuna
più potente ed illustre, tanto più grandi uomini fornì
alla storia degli e s ilii; e che a tale storia, a tal politica
trovasi ridotta quasi tutta la storia, la politica italiana
per quattro secoli e più, sforzandosi ogni prepotente di
esiliare i più deboli, e gli esiliati poi d i ripatriare, per
farsi essi esiliatori. (Quindi, tra tanto moto, tante pas
sioni e, diciam pure, tanta perversità, meritano compa
timento gli errori frequenti di parecchi esilia ti; ma me
ritano tanta più lode le rare e difficili virtù deU*esilio.
la fedeltà alla patria, la costanza, la moderazione, i per
doni. Nè mancano di queste alcuni solenni esempi; es
sendo immancabile quella legge della divina Pro vv i
denza, che le età afflitte da ' grandi vix ii sieno pur con
solate dalle grandi virtù . Abbiamo di que' tempi un
Alessandro I I I , ramingo dentro e fuori d 'Ita lia , per es
sersi messo a capo della nazional resistenza contro le
riusurpazioni d i Federigo I ; un Giovanni da Precida,
recante oltre ogni monte ed ogni mare a tutte le corti
d 'Eu ropa la fedeltà a* suoi p rincip i, i disegni preoccu
p a ti poi dalla sollevazione popolare; un Farinata degli
( berti, felice im itator di Cam illo nel difender l'e si
stenza della propria c ittà ; e più vicino a noi, un Co
simo de ' Medici, quasi più magnifico nell’esilio, che
non il figlinolo nel principato. I quali ta tti e parecchi
a ltri esilii sarebbero degni soggetti di storiò' generali •
speciali ».
iDm
a I na
é i
D M r st.


















