
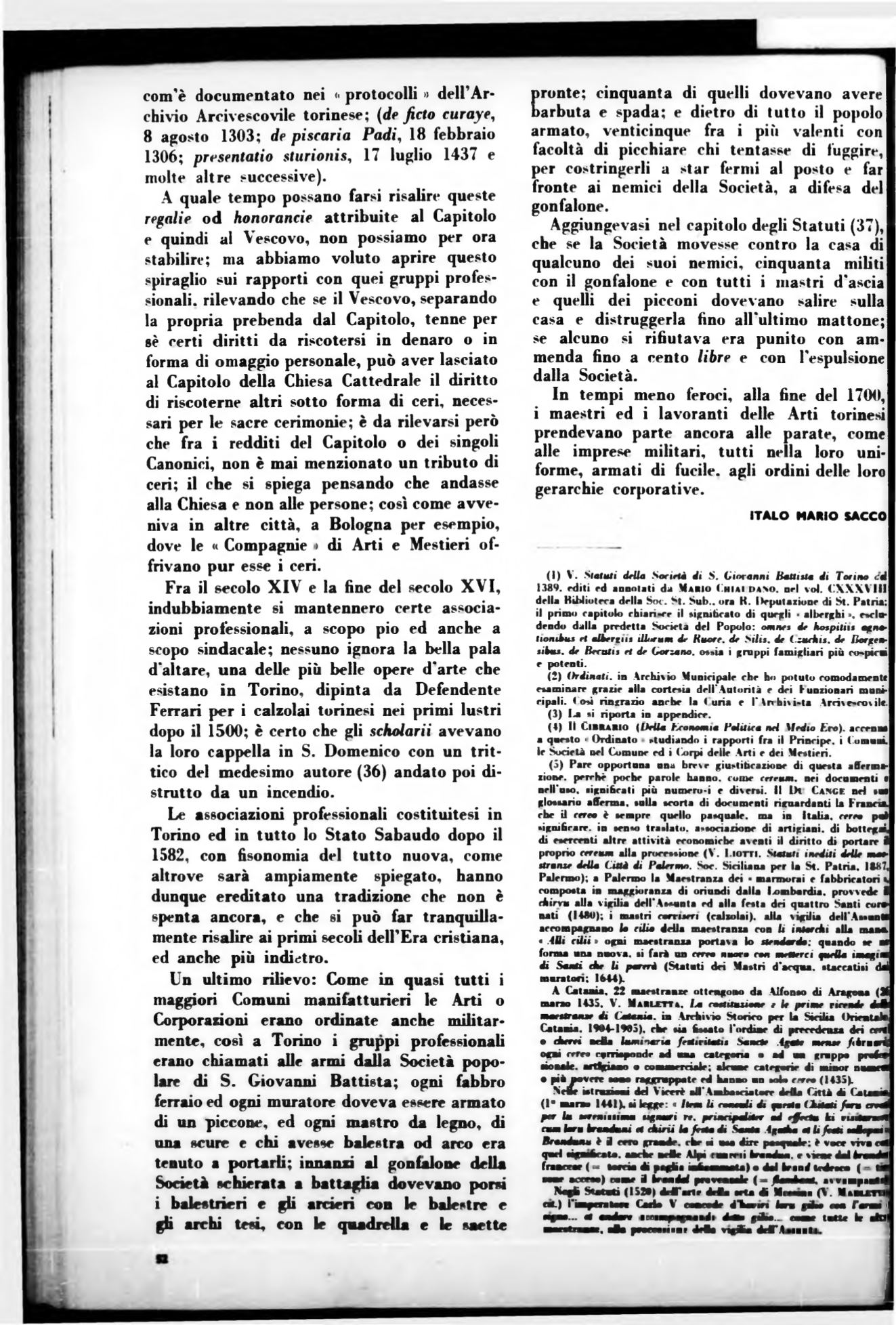
com’è documentato nei <>protocolli » dell’Ar
chivio Arcivescovile torinese;
(de fido curaye
,
8 agosto 1303;
de piscaria Padi
, 18 febbraio
1306;
presentalo sturionis
, 17 luglio 1437 e
molte altre successive).
A quale tempo possano farsi risalire queste
regalie
od
honorancie
attribuite al Capitolo
e quindi al Vescovo, non possiamo per ora
stabilire; ma abbiamo voluto aprire questo
spiraglio sui rapporti con quei gruppi profes
sionali. rilevando che se il Vescovo, separando
la propria prebenda dal Capitolo, tenne per
sè certi diritti da riscotersi in denaro o in
forma di omaggio personale, può aver lasciato
al Capitolo della Chiesa Cattedrale il diritto
di riscoterne altri sotto forma di ceri, neces
sari per le sacre cerimonie; è da rilevarsi però
che fra i redditi del Capitolo o dei singoli
Canonici, non è mai menzionato un tributo di
ceri; il che si spiega pensando che andasse
alla Chiesa e non alle persone; così come avve
niva in altre città, a Bologna per esempio,
dove le « Compagnie » di Arti e Mestieri of
frivano pur esse i ceri.
Fra il secolo XIV e la fine del secolo XVI,
indubbiamente si mantennero certe associa
zioni professionali, a scopo pio ed anche a
scopo sindacale; nessuno ignora la bella pala
d'altare, una delle più belle opere d*arte che
esistano in Torino, dipinta da Defendente
Ferrari per i calzolai torinesi nei primi lustri
dopo il 1500; è certo che gli
scholarii
avevano
la loro cappella in S. Domenico con un trit
tico del medesimo autore (36) andato poi di
strutto da un incendio.
Le associazioni professionali costituitesi in
Torino ed in tutto lo Stato Sabaudo dopo il
1582, con fisonomia del tutto nuova, come
altrove sarà ampiamente spiegato, hanno
dunque ereditato una tradizione che non è
spenta ancora, e che si può far tranquilla
mente risalire ai primi secoli dell’ Era cristiana,
ed anche più indietro.
Un ultimo rilievo: Come in quasi tutti i
maggiori Comuni manifatturieri le Arti o
Corporazioni erano ordinate anche militar
mente, così a Torino i gruppi professionali
erano chiamati alle armi dalla Società popo
lare di S. Giovanni Battista; ogni fabbro
ferraio ed ogni muratore doveva essere armato
di un piccone, ed ogni mastro da legno, di
una scure e chi avesse balestra od arco era
tenuto a portarli; innanzi al gonfalone della
Società schierata a battaglia dovevano porsi
i balestrieri e gli arcieri con le balestre e
gli archi tesi, con le quadretta e le saette
pronte; cinquanta di quelli dovevano avere
barbuta e spada; e dietro di tutto il popolo
armato, venticinque fra i più valenti con
facoltà di picchiare chi tentasse di fuggire,
per costringerli a star fermi al posto e far
fronte ai nemici della Società, a difesa del
gonfalone.
Aggiungevasi nel capitolo degli Statuti (37),
che se la Società movesse contro la casa di
qualcuno dei suoi nemici, cinquanta militi
con il gonfalone e con tutti i mastri d'ascia
e quelli dei picconi dovevano salire sulla
casa e distruggerla fino all'ultimo mattone;
se alcuno si rifiutava era punito con am
menda fino a cento
libre
e con l'espulsione
dalla Società.
In tempi meno feroci, alla fine del 1700,
i maestri ed i lavoranti delle Arti torinesi
prendevano parte ancora alle parate, come
alle imprese militari, tutti nella loro uni
forme, armati di fucile, agli ordini delle loro
gerarchie corporative.
ITALO MARIO SACCO
(1) V.
Statuti della Società di S. Cioranni Battista di Torino <:é
1389. editi rd annotati da
M a r i o C h i ai d a > o .
nel voi.
C X X X V 1 I I
drlia Biblioteca delia Soc. St. Sub., ora K. Deputazione di St. Patria:
il primo rapitolo chiarisce il significato di quegli •alberghi >. esclu
dendo dalla predetta Società del Popolo:
omnes de hospiliis
ajtn»
nomili)
et albereti* Hhtrum de Kuorc. de Silit. de l.zuckis. de lìorgem-
sii
tu.
de Becutis ri de Gorzano.
ossia i gruppi famigliari più cospirai
e potenti.
(2)
(hdinati.
in Archivio Municipale che ho potuto comodamente
esaminare grazie alla cortesia dell'Autorità e dei Funzionari munì*
ripali. Cosi ringrazio anche la ( uria e r\nhi\i<ta Arci\e»covile
(3) U si riporta in appendice.
(() Il CtBKABlO (
Della fconomia Politica nel Medio Ero),
accenna
a questo ■Ordinato studiando i rapporti fra il Principe, i Comuni,
le Società nel Comune ed i Corpi delle Arti e dei Mestieri.
(5)
Pare opportuna una breve giustificazione di questa afferma*
zione. perchè poche parole hanno, come rereiun. nei documenti »
nell'uso, significati più numcro-i e diverti. Il IH Ca*GE nel tu*
glossario afferma, culla «corta di documenti riguardanti la Francia,
che il cereo
è
sempre quello pasquale, ma in Italia,
rerem
pai
«ignifirare. in senso traslato, associazione di artigiani, di bottegai,
di esercenti altre attività economiche aventi il diritto di portare
i
proprio rereiun alla processione (V. I.torri.
Statuti inediti delle
ma*
tirante della Città di Palermo.
Soc. Siciliana per la St. Patria. 1887,
Palermo); a Palermo la Maestranza dei •marmorai e fabbricatori •.
composta in maggioranza di oriundi dalia I-ombardia. provvede I
chimi
alla vigilia deH'Asminta ed alla festa dei quattro Santi cor»
nati (1480); i mastri
rom sen
(calzolai), alla vigilia dell*Assunta
accompagnano
la rilio
della maestranza con
li inlarrki
alla man*.
•
Alli rilii
> ogni maestranza portava lo
stendardo:
quando
se
mi
forma una nuova, si farà un rereo
nuoto con metterci quella imagi
a»
di Samti che li pareri
(Statati dei Mastri d'acqua, staccatisi da
muratori: 1644).
A Catania. 22 maestranze ottengono da Alfonso di Aragona (3f
marzo 1433.
V . M
ab le tta
.
La cotiitutione e le prime vicende detl
maturala» di
Catania, in .Archivio Storico per la Sicilia Orientala
Catania. 1904-1905). che sia fissato l'ordine di precedenza dei
ceri
o citerei
nella
lumi-.aria fetiiritatis Sanele Agate mente
/làraarj
ogni rereo corrisponde ad una categoria o ad un gruppo prole»
sionaie, artigiano o commerciale; alcune categorie di minor n ia M
• piè povere tono raggnippate ed hanno un win
cerea
(1435).
Netfr istruzioni del Viceré all*Ambasciatore della Città di Caiani*
(1° marzo 1441). ai legge: •
llem li camtmli di
f
reta fitta ti
/am
crea
I
per Ut
iermissima
signori
re.
primeipaiitrr ad efeeUt ki
ruitararM
cum laeu hramdmmi ri dùrii
la
fetta
di Santa
Aga+a et li frati saliepmi
»
Brami
mmu
è 3
erto
grande, che si s u dire pasquale: è voce viva ra)
quel sipnficato. anche nelle Alpi rnun li
iraadun. e
virar dal
irmrném
franceac ( = uw ia di pattila infin— ala) o dal Iranrf tedesco ( - M
aone ncceao) ronse il Ir w r t p w w n l r ( —jk n èn a . avvampanti
Kfffi Statati (1320) deTarte detta seta di Messa. (V.
MablCTTJ
est.)
l'imperatare Caria V cawcdr d'harin lara friso eoa Tanta <
«tao...
et
andar* i p n i n ^ y i i l i
dette gilta..
cone tutte Ir aÉB
taueotmaar. afta
femt
e a.i.nrdriU n fS a deC.j
.aati


















