
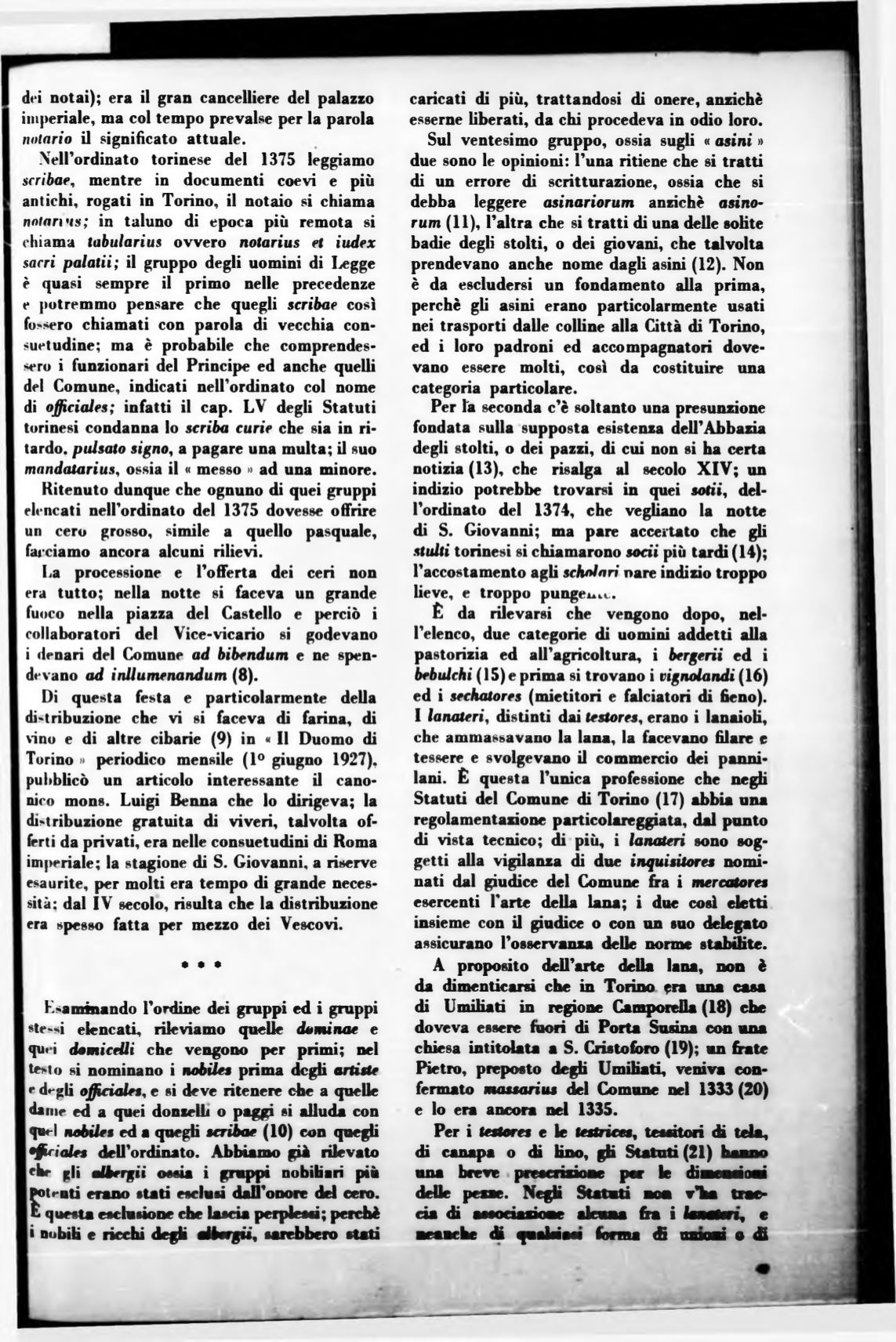
dei notai); era il gran cancelliere del palazzo
imperiale, ma col tempo prevalse per la parola
twtnrio
il significato attuale.
Nell’ordinato torinese del 1375 leggiamo
scribae
, mentre in documenti coevi e più
antichi, rogati in Torino, il notaio si chiama
notori u$;
in taluno di epoca più remota si
chiama
tabularius
ovvero
notarius et iudex
sacri palatii
;
il gruppo degli uomini di I^egge
è quasi sempre il primo nelle precedenze
e potremmo pensare che quegli
scribae
così
fo.-sero chiamati con parola di vecchia con
suetudine; ma è probabile che comprendes
sero i funzionari del Principe ed anche quelli
del Comune, indicati nell’ordinato col nome
di
ojficiales
;
infatti il cap. LV degli Statuti
torinesi condanna lo
scriba curie
che sia in ri
tardo.
pulsato signo,
a pagare una multa; il suo
mandatarius,
ossia il « messo » ad una minore.
Ritenuto dunque che ognuno di quei gruppi
elencati nell’ordinato del 1375 dovesse offrire
un cero grosso, simile a quello pasquale,
farciamo ancora alcuni rilievi.
La processione e l’offerta dei ceri non
era tutto; nella notte si faceva un grande
fuoco nella piazza del Castello e perciò i
collaboratori del Vice-vicario si godevano
i denari del Comune
ad bibendum
e ne spen
devano
ad inllumenandum
(8).
Di questa festa e particolarmente della
di>tribuzione che vi si faceva di farina, di
vino e di altre cibarie (9) in « Il Duomo di
Torino » periodico mensile (1° giugno 1927),
pubblicò un articolo interessante il cano
nico mons. Luigi Benna che lo dirigeva; la
dMribuzione gratuita di viveri, talvolta of
ferti da privati, era nelle consuetudini di Roma
imperiale; la stagione di S. Giovanni, a riserve
esaurite, per molti era tempo di grande neces
sità: dal IV secolo, risulta che la distribuzione
era spesso fatta per mezzo dei Vescovi.
• • •
Ksaminando l’ordine dei gruppi ed i gruppi
stessi elencati, rileviamo quelle
dominoe
e
qui i
domicelii
che vengono per primi; nel
testo si nominano i
nobiles
prima degli
artiste
* d»*gli
ojficiales
, e si deve ritenere che a quelle
dame ed a quei donzelli o paggi si alluda con
qat-l
nobiles
ed a quegli
scribae
(10) con quegli
•ficiales
dell’ordinato. Abbiamo già rilevato
ebe gli
albergii
OMÌa i grappi nobiliari più
r
t**nti erano stati esclusi dall’onore del cero.
questa esclusione che lascia perplessi; perché
i nobili e ricchi degli
alkrrgii,
sarebbero stati
caricati di più, trattandosi di onere, anziché
esserne liberati, da chi procedeva in odio loro.
Sul ventesimo gruppo, ossia sugli «
asini
»
due sono le opinioni: l’ una ritiene che si tratti
di un errore di scritturazione, ossia che si
debba leggere
asinariorum
anziché
asino-
rum
(11), l’ altra che si tratti di una delle solite
badie degli stolti, o dei giovani, che talvolta
prendevano anche nome dagli asini (12). Non
è da escludersi un fondamento alla prima,
perchè gli asini erano particolarmente usati
nei trasporti dalle colline alla Città di Torino,
ed i loro padroni ed accompagnatori dove
vano essere molti, così da costituire una
categoria particolare.
Per fa seconda c’è soltanto una presunzione
fondata sulla supposta esistenza dell’Abbazia
degli stolti, o dei pazzi, di cui non si ha certa
notizia (13), che risalga al secolo X IV ; un
indizio potrebbe trovarsi in quei
sotii,
del
l’ordinato del 1374, che vegliano la notte
di S. Giovanni; ma pare accertato che gli
stulti
torinesi si chiamarono
sodi
più tardi (14);
l’ accostamento agli
scholari
nare indizio troppo
lieve, e troppo pungelllC.
È da rilevarsi che vengono dopo, nel
l’elenco, due categorie di uomini addetti alla
pastorizia ed all’agricoltura, i
bergerii
ed i
bebulchi
(15) e prima si trovano i
vignolandi
(16)
ed i
sechatores
(mietitori e falciatori di fieno).
I
lanateri
, distinti dai
testores
, erano i lanaioli,
che ammassavano la lana, la facevano filare e
tessere e svolgevano il commercio dei panni-
lani. £ questa l’unica professione che negli
Statuti del Comune di Torino (17) abbia una
regolamentazione particolareggiata, dal punto
di vista tecnico; di più, i
lanateri
sono sog
getti alla vigilanza di due
inquisitores
nomi
nati dal giudice del Comune fra i
mercatores
esercenti l’ arte della lana; i due così eletti
insieme con il giudice o con un suo delegato
assicurano l’osservanza delle norme stabilite.
A proposito dell’arte della lana, non è
da dimenticarsi che in Torino era una casa
di Umiliati in regione Camporella (18) che
doveva essere fuori di Porta Susina con una
chiesa intitolata a S. Cristoforo (19); un frate
Pietro, preposto degli Umiliati, veniva con
fermato
massarius
del Comune nel 1333 (
20
)
e lo era ancora nel 1335.
Per i testores e le
testrices
, tessitori di tela,
di canapa o di lino, gli Statuti (21) *»■■■«
una breve prescrizione per le iHnm iiw i
delle pezze. Negli Statuti usa v’ha trac
cia di associazione alcuna fra i iamtfm, e
neanche éi qualsiasi forma di ramni o
di


















