
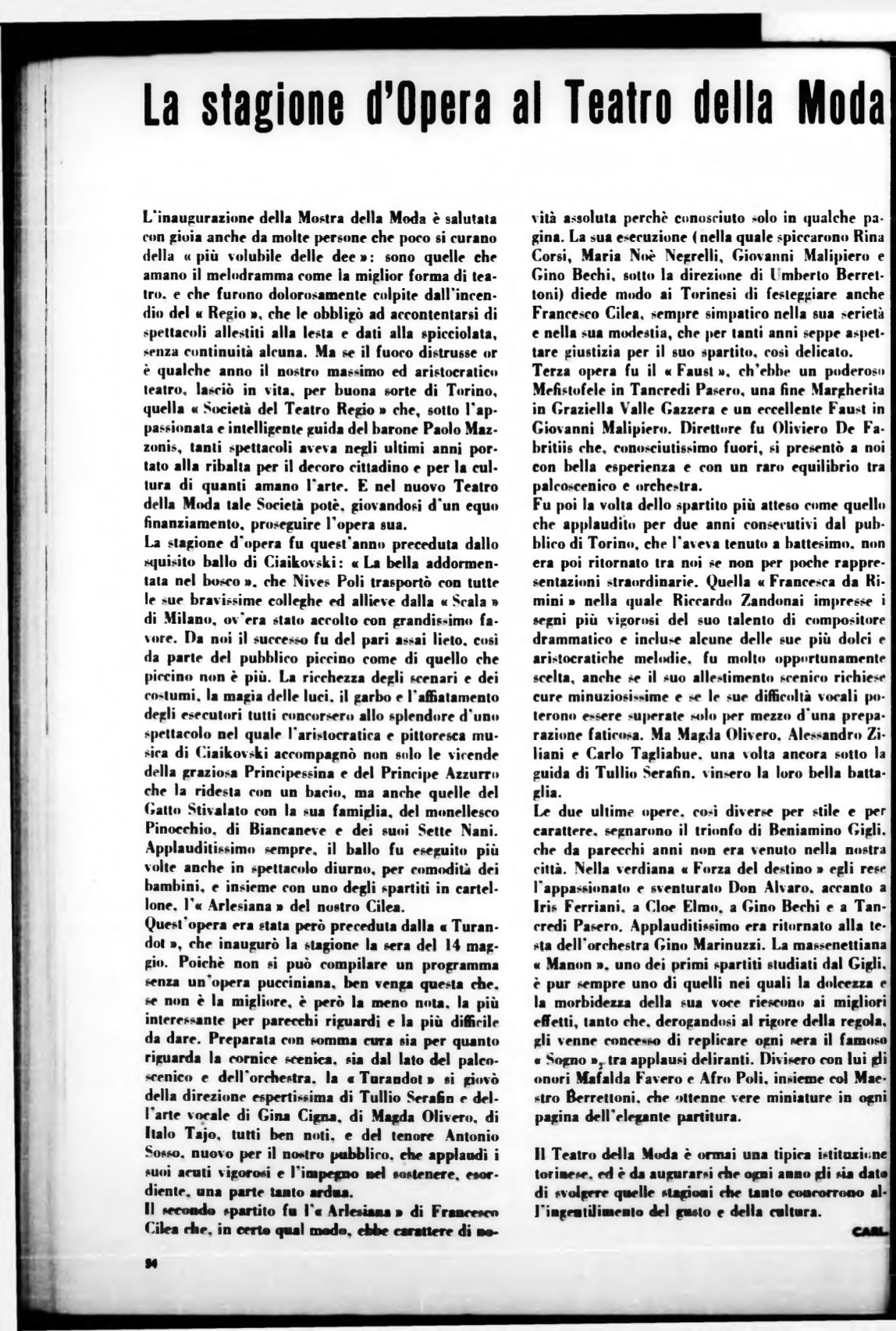
La stagione d’Opera al Teatro della Moda
L'inaugurazione della Mostra della Moda è salutata
con gioia anche da molte persone che poco si curano
delia « più volubile delle dee » : sono quelle che
amano il melodramma come ia miglior forma di tea
tro. e che furono dolorosamente colpite dall'incen-
dio del « Regio », che le obbligò ad accontentarsi di
spettacoli allestiti alla lesta e dati alla spicciolata,
senza continuità alcuna. Ma se il fuoco distrusse or
è
qualche anno il nostro massimo ed aristocratico
teatro, lasciò in vita, per buona sorte di Torino,
quella « Società del Teatro Regio » che, sotto l’ ap
passionata e intelligente guida del barone Paolo Maz-
zonis, tanti spettacoli aveva negli ultimi anni por
tato alla ribalta per il decoro cittadino e per la cul
tura di quanti amano l'arte. E nel nuovo Teatro
della Moda tale Società potè, giovandosi d'un equo
finanziamento, proseguire l'opera sua.
La stagione d'opera fu quest'anno preceduta dallo
squisito ballo di Ciaikovski : « La bella addormen
tata nel bosco ». che Nives Poli trasportò con tutte
le sue bravissime colleghe ed allieve dalla « Scala »
di Milano, ov'era stato accolto con grandissimo fa
vore. Da noi il successo fu del pari assai lieto, così
da parte del pubblico piccino come di quello che
piccino non è più. La ricchezza degli scenari e dei
costumi, la magia delle luci, il garbo e l'affiatamento
degli esecutori tutti concorsero allo splendore d'uno
spettacolo nel quale l'aristocratica e pittoresca mu
sica di Ciaikovski accompagnò non solo le vicende
della graziosa Principessina e del Principe Azzurro
che la ridesta con un bacio, ma anche quelle del
Gatto Stivalato con la sua famiglia, del monellesco
Pinocchio, di Biancaneve e dei suoi Sette Nani.
Applauditissimo sempre, il ballo fu eseguito più
volte anche in spettacolo diurno, per comodità dei
bambini, e insieme con uno degli spartiti in cartel
lone. IV Arlesiana » del nostro Cilea.
Quest'opera era stata però preceduta dalla « Turan
do! », che inaugurò la stagione la sera del 14 mag
gio. Poiché non si può compilare un programma
senza un opera pucciniana. ben venga questa che.
se non è la migliore, è però la meno nota, la più
interessante per parecchi riguardi e la più difficile
da dare. Preparata con somma cura sia per quanto
riguarda la cornice scenica, sia dal lato del paleo
cenico e dell'orchestra, la « Turando! » si giovò
della direzione espertissima di Tullio Serafin e del-
I arte vocale di Gina Cigna, di Magda Olivero, di
Italo Tajo, tutti ben noti, e del tenore Antonio
Sosso, nuovo per il nostro pubblico, che applaudì i
suoi acuti vigorosi e l'impegno nel sostenere, esor
diente. una parte tanto
ardua.
II secondo spartito fn l'« Arlesiana » di Francesco
Cilea che, in certo qual modo, ebbe carattere di no
vità assoluta perchè conosciuto
solo
in qualche pa
gina. La sua esecuzione ( nella quale spiccarono Rina
Corsi, Maria Noè Negrelli, Giovanni Malipiero e
Gino Bechi, sotto la direzione di l mberto Berret
toni) diede modo ai Torinesi di festeggiare anche
Francesco Cilea, sempre simpatico nella sua serietà
e nella sua modestia, che per tanti anni seppe aspet
tare giustizia per il suo spartito, così delicato.
Terza opera fu il « Faust », ch'ebbe un poderosi»
Mefistofele in Tancredi Pasero, una fine Margherita
in Graziella Valle Gazzera e un eccellente Faust in
Giovanni Malipiero. Direttore fu Oliviero De Fa-
britiis che, conosciutissimo fuori, si presentò a noi
con bella esperienza e con un raro equilibrio tra
palcoscenico e orchestra.
Fu poi la volta dello spartito più atteso come quello
che applaudito per due anni consecutivi dal pub
blico di Torino, che l'aveva tenuto a battesimo, non
era poi ritornato tra noi se non per poche rappre
sentazioni straordinarie. Quella « Francesca da Ri
mini » nella quale Riccardo Zandonai impresse i
segni più vigorosi del suo talento di compositore
drammatico e incluse alcune delle sue più dolci e
aristocratiche melodie, fu molto opportunamente
scelta, anche se il suo allestimento scenico richiese
cure minuziosissime e se le sue difficoltà vocali po
terono essere superate solo per mezzo d'una prepa
razione faticosa. Ma Magda Olivero. Alessandro Zi-
liani e Carlo Tagliabue. una \olta ancora sotto la
guida di Tullio Serafin. vinsero la loro bella batta
glia.
Le due ultime opere, cosi diverse per stile e per
carattere, segnarono il trionfo di Beniamino Gigli,
che da parecchi anni non era venuto nella nostra
città. Nella verdiana « Forza del destino » egli rese
l'appassionato e sventurato Don Alvaro, accanto a
Iris Ferriani. a Cloe Elmo, a Gino Bechi e a Tan
credi Pasero. Applauditissimo era ritornato alla te
sta dell'orchestra Gino Marinuzzi. La massenettiana
« Manon ». uno dei primi spartiti studiati dal Gigli,
è pur sempre uno di quelli nei quali la dolcezza e
la morbidezza della sua voce riescono ai migliori
effetti, tanto che. derogandosi al rigore della regola,
gli venne concesso di replicare ogni sera il famoso
« Sogno », tra applausi deliranti. Divisero con lui gli
onori Mafalda Favero e Afro Poli, insieme col Mae
stro Berrettoni, che ottenne vere miniature in ogni
pagina dell'elegante partitura.
Il Teatro della Moda è ormai una tipica istituzione
torinese, ed è da augurarsi che ogni anno gii sia dato
di svolgere quelle stagioni che tanto concorrono al-
l'ingentilimento del gusto e della coltura.
M


















