
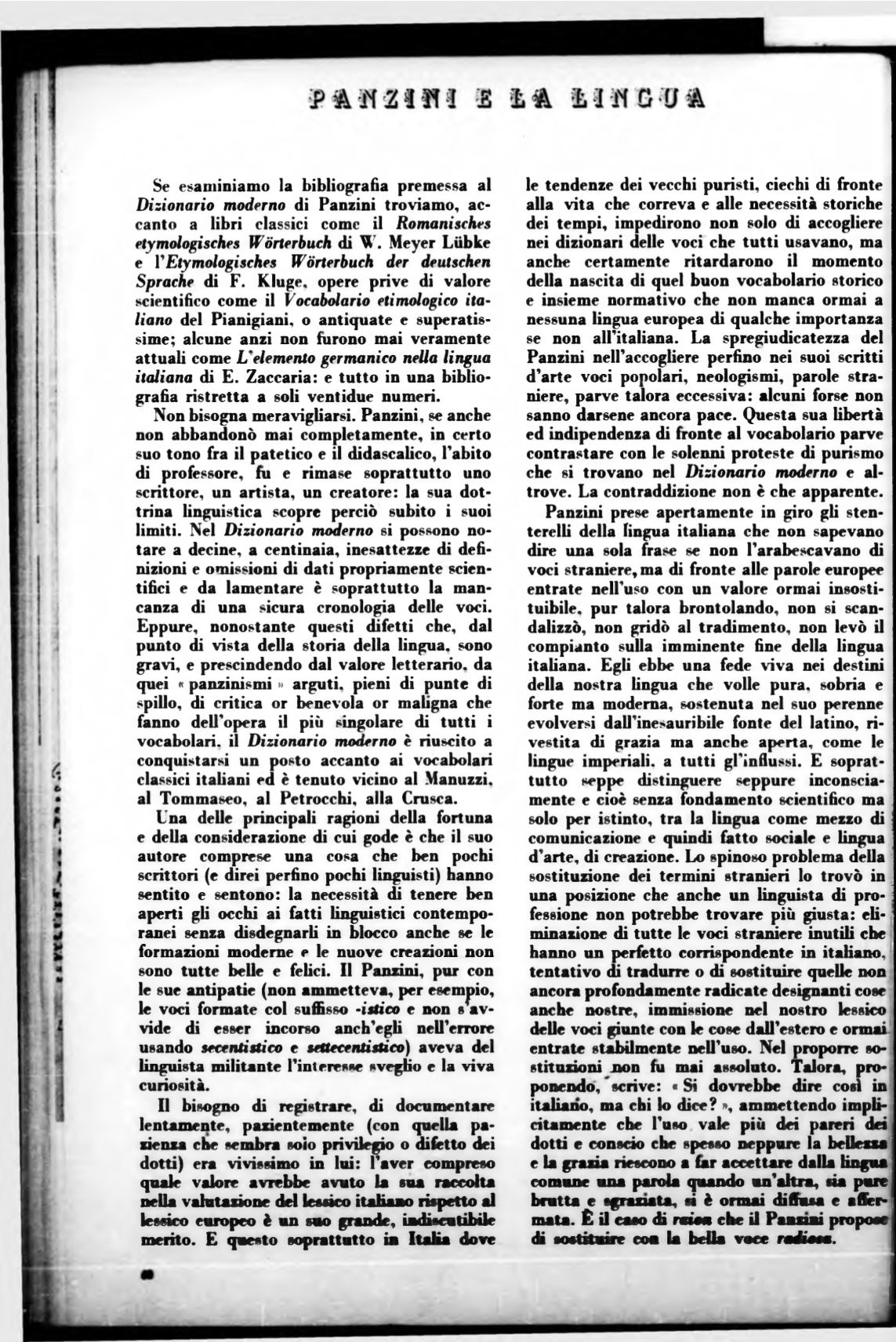
Se esaminiamo la bibliografìa premessa al
Dizionario moderno
di Panzini troviamo, ac
canto a libri classici come il
Romanisches
etymologisches Wòrterbuch
di W. Meyer Liibke
e r
Etymologisches Wòrterbuch der deutschen
Sprache
di F. Kluge, opere prive di valore
scientifico come il
Vocabolario etimologico ita
liano
del Pianigiani, o antiquate e superatis
sime; alcune anzi non furono mai veramente
attuali come
L'elemento germanico nella lingua
italiana
di E. Zaccaria: e tutto in una biblio
grafia ristretta a soli ventidue numeri.
Non bisogna meravigliarsi. Panzini, se anche
non abbandonò mai completamente, in certo
suo tono fra il patetico e il didascalico, l'abito
di professore, fu e rimase soprattutto uno
scrittore, un artista, un creatore: la sua dot
trina linguistica scopre perciò subito i suoi
limiti. Nel
Dizionario moderno
si possono no
tare a decine, a centinaia, inesattezze di defi
nizioni e omissioni di dati propriamente scien
tifici e da lamentare è soprattutto la man
canza di una sicura cronologia delle voci.
Eppure, nonostante questi difetti che, dal
punto di vista della storia della lingua, sono
gravi, e prescindendo dal valore letterario, da
quei « panzinismi ><arguti, pieni di punte di
spillo, di critica or benevola or maligna che
fanno dell'opera il più singolare di tutti i
vocabolari, il
Dizionario moderno
è riuscito a
conquistarsi un posto accanto ai vocabolari
classici italiani ed è tenuto vicino al Manuzzi.
al Tommaseo, al Petrocchi, alla Crusca.
Una delle principali ragioni della fortuna
e della considerazione di cui gode è che il suo
autore comprese una cosa che ben pochi
scrittori (e direi perfino pochi linguisti) hanno
sentito e sentono: la necessità di tenere ben
aperti gli occhi ai fatti linguistici contempo
ranei senza disdegnarli in blocco anche se le
formazioni moderne e le nuove creazioni non
sono tutte belle e felici. Il Panzini, pur con
le sue antipatie (non ammetteva, per esempio,
le voci formate col suffisso
-istico
e non s av
vide di esser incorso anch'egli nell'errore
usando
secentistico
e
settecentistico)
aveva del
linguista militante l’interesse sveglio e la viva
curiosità.
Il
bisogno di registrare, di documentare
lentamente, pazientemente (con quella pa
zienza che sembra soio privilegio o difetto dei
dotti) era vivissimo in lui: l’ aver compreso
quale valore avrebbe avuto la sua raccolta
nella valutazione del lessico italiano rispetto al
lessico europeo è un suo grande, indiscutibile
merito. E questo soprattutto in Italia dove
le tendenze dei vecchi puristi, ciechi di fronte
alla vita che correva e alle necessità storiche
dei tempi, impedirono non solo di accogliere
nei dizionari delle voci che tutti usavano, ma
anche certamente ritardarono il momento
della nascita di quel buon vocabolario storico
e insieme normativo che non manca ormai a
nessuna lingua europea di qualche importanza
se non all’ italiana. La spregiudicatezza del
Panzini nell’accogliere perfino nei suoi scritti
d’arte voci popolari, neologismi, parole stra
niere, parve talora eccessiva: alcuni forse non
sanno darsene ancora pace. Questa sua libertà
ed indipendenza di fronte al vocabolario parve
contrastare con le solenni proteste di purismo
che si trovano nel
Dizionario moderno
e al
trove. La contraddizione non è che apparente.
Panzini prese apertamente in giro gli sten
terelli della lingua italiana che non sapevano
dire una sola frase se non l’arabescavano di
voci straniere, ma di fronte alle parole europee
entrate nell’uso con un valore ormai insosti
tuibile. pur talora brontolando, non si scan
dalizzò, non gridò al tradimento, non levò il
compianto sulla imminente fine della lingua
italiana. Egli ebbe una fede viva nei destini
della nostra lingua che volle pura, sobria e
forte ma moderna, sostenuta nel suo perenne
evolversi dall’ inesauribile fonte del latino, ri
vestita di grazia ma anche aperta, come le
lingue imperiali, a tutti gl’ influssi. E soprat
tutto seppe distinguere seppure inconscia
mente e cioè senza fondamento scientifico ma
solo per istinto, tra la lingua come mezzo di
comunicazione e quindi fatto sociale e lingua
d’ arte, di creazione. Lo spinoso problema della
sostituzione dei termini stranieri lo trovò in
una posizione che anche un linguista di pro
fessione non potrebbe trovare più giusta: eli
minazione di tutte le voci straniere inutili che
hanno un perfetto corrispondente in italiano,
tentativo di tradurre o di sostituire quelle non
ancora profondamente radicate designanti cose
anche nostre, immissione nel nostro lessico
delle voci giunte con le cose dall’estero e ormai
entrate stabilmente nell’uso. Nel proporre so
stituzioni non fu mai assoluto. Talora, prò*
ponendo, scrive: « Si dovrebbe dire cosi in
italiano, ma chi lo dice? », ammettendo impli
citamente che l’uso vale più dei pareri dei
dotti e conscio che spesso neppure la bellezza
e la grazia riescono a far accettare dalla lingua
comune una paiola quando un’ altra, sia pure
brutta e sgranata, si è ormai diffusa e affer
mata. £ il caso di
raion
che il Pannai propose
di sostituire con la bella voce
radiosa.


















