
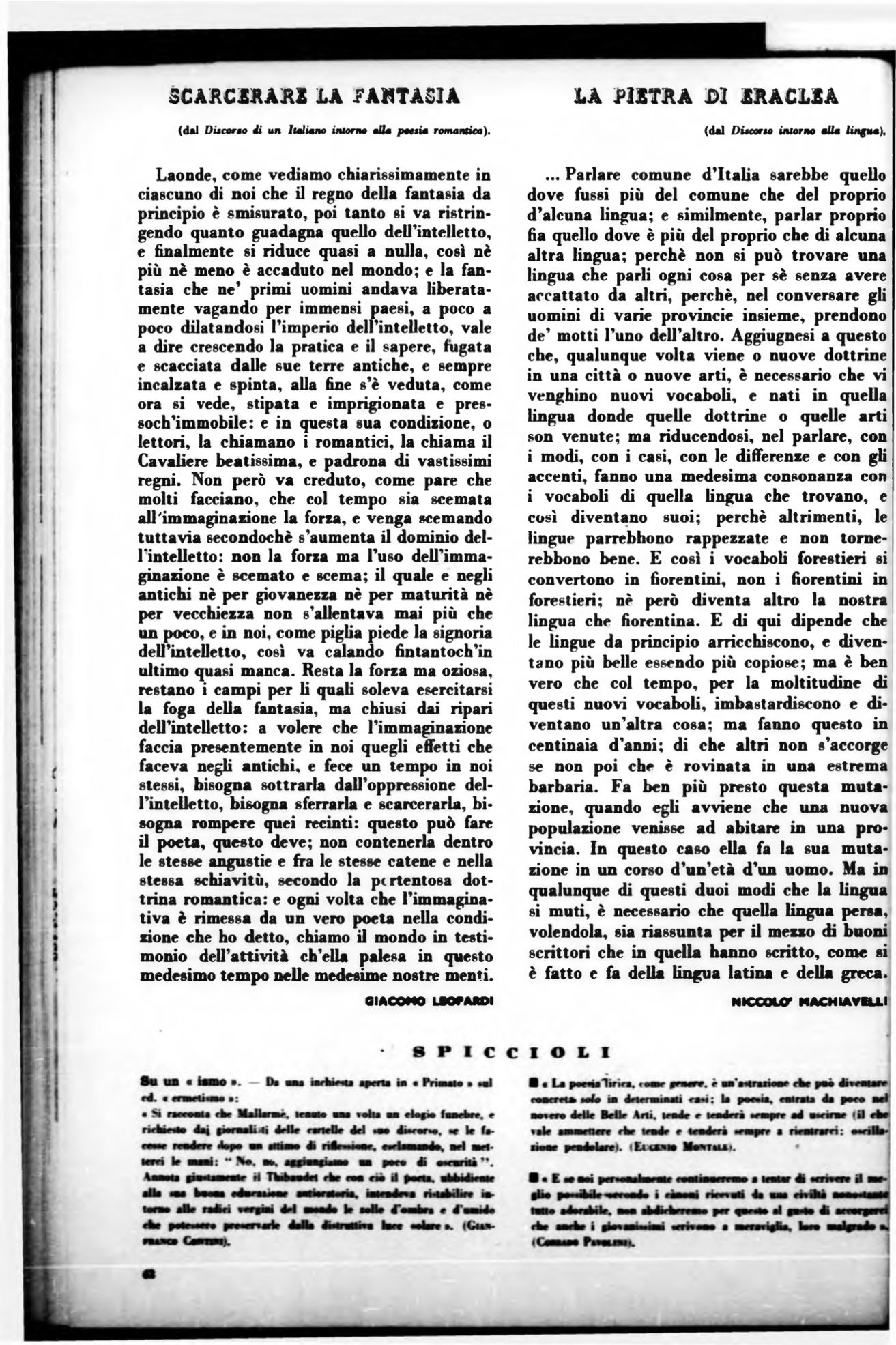
SCÀR C iR ÀK Ì LA iAM TA S IA
LA M BTKA £ 1 jSRACLiSA
(dal
Discorso
di
un Italiano intorno alla poesia romantica).
Laonde, come vediamo chiarissimamente in
ciascuno di noi che il regno della fantasia da
principio è smisurato, poi tanto si va ristrin-
gendo quanto guadagna quello dell'intelletto,
e finalmente si riduce quasi a nulla, così nè
più nè meno è accaduto nel mondo; e la fan
tasia che ne’ primi uomini andava liberata*
mente vagando per immensi paesi, a poco a
poco dilatandosi l’ imperio dell’intelletto, vale
a dire crescendo la pratica e il sapere, fugata
e scacciata dalle sue terre antiche, e sempre
incalzata e spinta, alla fine s’è veduta, come
ora si vede, stipata e imprigionata e pres-
soch’immobile: e in questa sua condizione, o
lettori, la chiamano i romantici, la chiama il
Cavaliere beatissima, e padrona di vastissimi
regni. Non però va creduto, come pare che
molti facciano, che col tempo sia scemata
all'immaginazione la forza, e venga scemando
tuttavia secondochè s’aumenta il dominio del
l'intelletto: non la forza ma l’uso dell’imma
ginazione è scemato e scema; il quale e negli
antichi nè per giovanezza nè per maturità nè
per vecchiezza non s’allentava mai più che
un poco, e in noi, come piglia piede la signoria
dell’intelletto, così va calando fintantoch’in
ultimo quasi manca. Resta la forza ma oziosa,
restano i campi per li quali soleva esercitarsi
la foga della fantasia, ma chiusi dai ripari
dell’intelletto: a volere che l’immaginazione
faccia presentemente in noi quegli effetti che
faceva negli antichi, e fece un tempo in noi
stessi, bisogna sottrarla dall’oppressione del
l’ intelletto, bisogna sferrarla e scarcerarla, bi
sogna rompere quei recinti: questo può fare
il poeta, questo deve; non contenerla dentro
le stesse angustie e fra le stesse catene e nella
stessa schiavitù, secondo la pirtentosa dot
trina romantica: e ogni volta che l’ immagina
tiva è rimessa da un vero poeta nella condi
zione che ho detto, chiamo il mondo in testi
monio dell’attività ch’ella palesa in questo
medesimo tempo nelle medesime nostre menti.
(dal
Discorso intorno alla lingua).
... Parlare comune d’ Italia sarebbe quello
dove fussi più del comune che del proprio
d’ alcuna lingua; e similmente, parlar proprio
fia quello dove è più del proprio che di alcuna
altra lingua; perchè non si può trovare una
lingua che parli ogni cosa per sè senza avere
accattato da altri, perchè, nel conversare gli
uomini di varie provincie insieme, prendono
de’ motti l’uno dell’altro. Aggiugnesi a questo
che, qualunque volta viene o nuove dottrine
in una città o nuove arti, è necessario che vi
venghino nuovi vocaboli, e nati in quella
lingua donde quelle dottrine o quelle arti
son venute; ma riducendosi, nel parlare, con
i modi, con i casi, con le differenze e con gli
accenti, fanno una medesima consonanza con
i vocaboli di quella lingua che trovano, e
così diventano suoi; perchè altrimenti, le
lingue parrebhono rappezzate e non tome-
rebbono bene. E così i vocaboli forestieri si
convertono in fiorentini, non i fiorentini in
forestieri; nè però diventa altro la nostra
lingua che fiorentina. E di qui dipende che
le lingue da principio arricchiscono, e diven
tano più belle essendo più copiose; ma è ben
vero che col tempo, per la moltitudine di
questi nuovi vocaboli, imbastardiscono e di
ventano un’altra cosa; ma fanno questo in
centinaia d’anni; di che altri non s’accorge
se non poi che è rovinata in una estrema
barbaria. Fa ben più presto questa muta
zione, quando egli avviene che una nuova
populazione venisse ad abitare in una pro
vincia. In questo caso ella fa la sua muta
zione in un corso d’un’età d’un uomo. Ma in
qualunque di questi duoi modi che la lingua
si muti, è necessario che quella lingua persa,
volendola, sia riassunta per il mezzo di buoni
scrittori che in quella hanno scritto, come si
è fatto e fa della lingua latina e della greca.
GIACOMOLEOPARDI
NICCOLO* MACHIAVELLI


















