
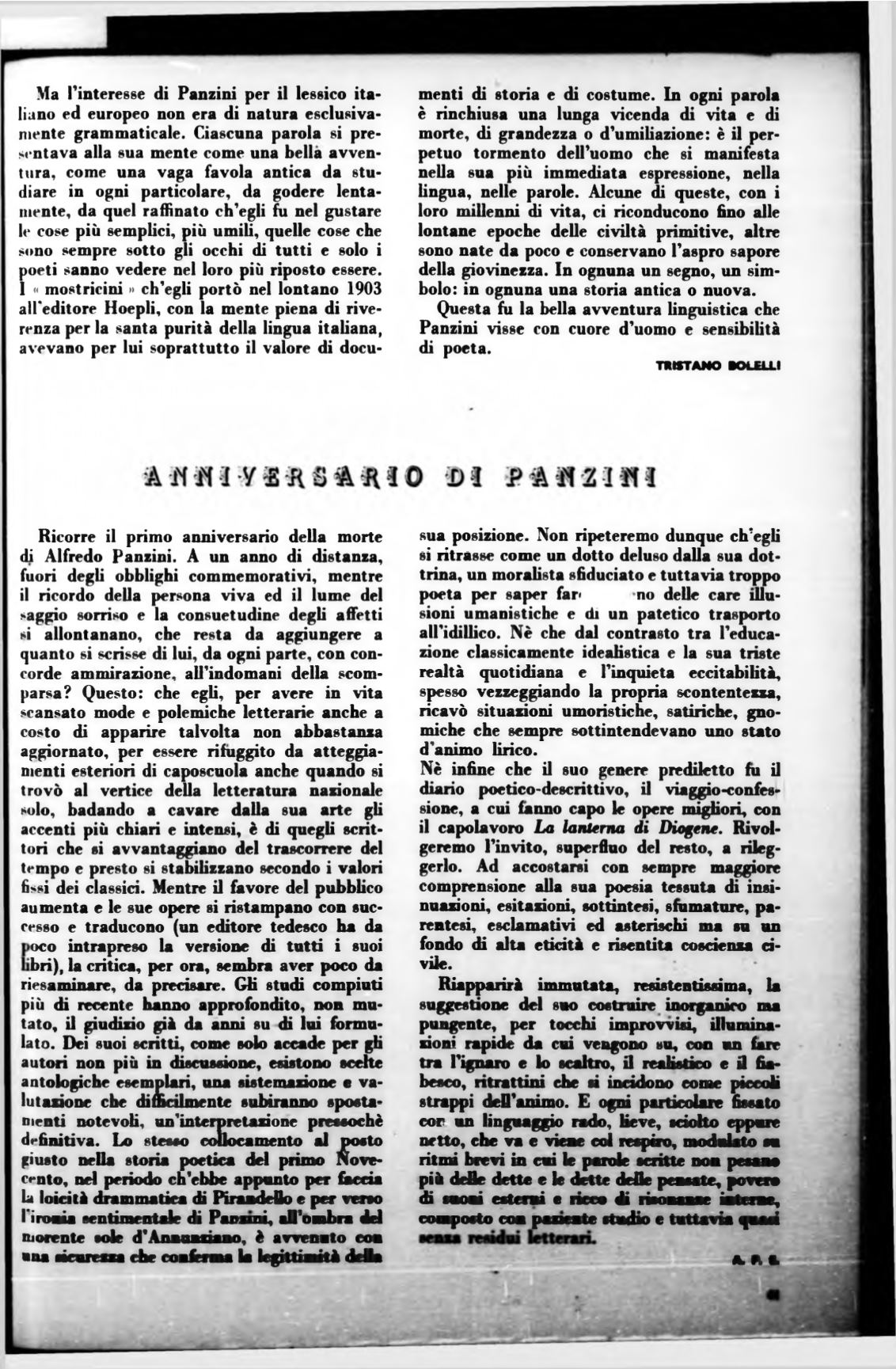
Ma l'interesse di Panzini per il lessico ita
liano ed europeo non era di natura esclusiva
mente grammaticale. Ciascuna parola si pre
sentava alla sua mente come una bella avven
tura, come una vaga favola antica da stu
diare in ogni particolare, da godere lenta
mente, da quel raffinato ch'egli fu nel gustare
le cose più semplici, più umili, quelle cose che
sono sempre sotto gli occhi di tutti e solo i
poeti sanno vedere nel loro più riposto essere.
I « mostricini » ch'egli portò nel lontano 1903
all'editore Hoepli, con la mente piena di rive
renza per la santa purità della lingua italiana,
avevano per lui soprattutto il valore di docu
menti di storia e di costume. In ogni parola
è rinchiusa una lunga vicenda di vita e di
morte, di grandezza o d'umiliazione: è il per
petuo tormento dell'uomo che si manifesta
nella sua più immediata espressione, nella
lingua, nelle parole. Alcune di queste, con i
loro millenni di vita, ci riconducono fino alle
lontane epoche delle civiltà primitive, altre
sono nate da poco e conservano l'aspro sapore
della giovinezza. In ognuna un segno, un sim
bolo: in ognuna una storia antica o nuova.
Questa fu la bella avventura linguistica che
Panzini visse con cuore d'uomo e sensibilità
di poeta.
TRISTANO OOLELLI
Ricorre il primo anniversario della morte
di Alfredo Panzini. A un anno di distanza,
fuori degli obblighi commemorativi, mentre
il ricordo della persona viva ed il lume del
saggio sorriso e la consuetudine degli affetti
si allontanano, che resta da aggiungere a
quanto si scrisse di lui, da ogni parte, con con
corde ammirazione, all'indomani della scom
parsa? Questo: che egli, per avere in vita
scansato mode e polemiche letterarie anche a
costo di apparire talvolta non abbastanza
aggiornato, per essere rifuggito da atteggia
menti esteriori di caposcuola anche quando si
trovò al vertice della letteratura nazionale
solo, badando a cavare dalla sua arte gli
accenti più chiarì e intensi, è di quegli scrit
tori che si avvantaggiano del trascorrere del
tempo e presto si stabilizzano secondo i valori
fìssi dei classici. Mentre il favore del pubblico
aumenta e le sue opere si ristampano con suc
cesso e traducono (un editore tedesco ha da
oco intrapreso la versione di tutti i suoi
bri), la critica, per ora, sembra aver poco da
riesaminare, da precisare. Gli studi compinti
più di recente hanno approfondito, non mu
tato, il giudizio già da anni su di lui formu
lato. Dei suoi scritti, come solo accade per gli
autori non più in discussione, esistono scelte
antologiche esemplari, una sistemazione e va
lutazione che difficilmente subiranno sposta
menti notevoli, un'interpretazione pressoché
definitiva. Lo stesso collocamento al posto
giusto nella storia poetica del primo Nove
cento, nel periodo ch'ebbe appunto per Caccia
la loicità drammatica di Pirandello e per verso
l'ironia sentimentale di Panami, all'ombra del
morente sole d’ Annunziano, è avvenuto con
una sicurezza c
he
conferma la legittiaoità M a
sua posizione. Non ripeteremo dunque ch'egli
si ritrasse come un dotto deluso dalla sua dot
trina, un moralista sfiduciato e tuttavia troppo
poeta per saper far
no delle care illu
sioni umanistiche e di un patetico trasporto
aH'idillico. Nè che dal contrasto tra l'educa
zione classicamente idealistica e la sua triste
realtà quotidiana e l'inquieta eccitabilità,
spesso vezzeggiando la propria scontentezza,
ricavò situazioni umoristiche, satiriche, gno
miche che sempre sottintendevano uno stato
d'animo lirico.
Nè infine che il suo genere prediletto fu il
diario poetico-descrittivo, il viaggio-confes
sione, a cui fanno capo le opere migliori, con
il capolavoro
La lanterna di Diogene.
Rivol
geremo l'invito, superfluo del resto, a rileg
gerlo. Ad accostarsi con sempre maggiore
comprensione alla sua poesia tessuta di insi
nuazioni, esitazioni, sottintesi, sfumature, pa
rentesi, esclamativi ed asterischi ma su un
fondo di alta eticità e risentita coscienza ci
vile.
Riapparirà immutata, resistentissima, la
suggestione del suo costruire inorganico ma
pungente, per tocchi improvvisi, illumina
zioni rapide da cui vengono su, con un fare
tra Tignalo e lo scaltro, il realistico e il fia
besco, ritrattini che si incidono come piccoli
strappi dell'animo. E ogni particolare fissato
cor un linguaggio rado, Beve, sciolto eppure
netto, che va e viene eoi respiro,
modalato sa
ritmi brevi in cai le
parole
scritte non
pesano
più delle dette e le dette delle pensate,
povera
di
saoai calerai
e
ricco di risonanze interne,
conforto eoa
pancate
stadio
e
tuttavia quasi
A Pi l i


















