
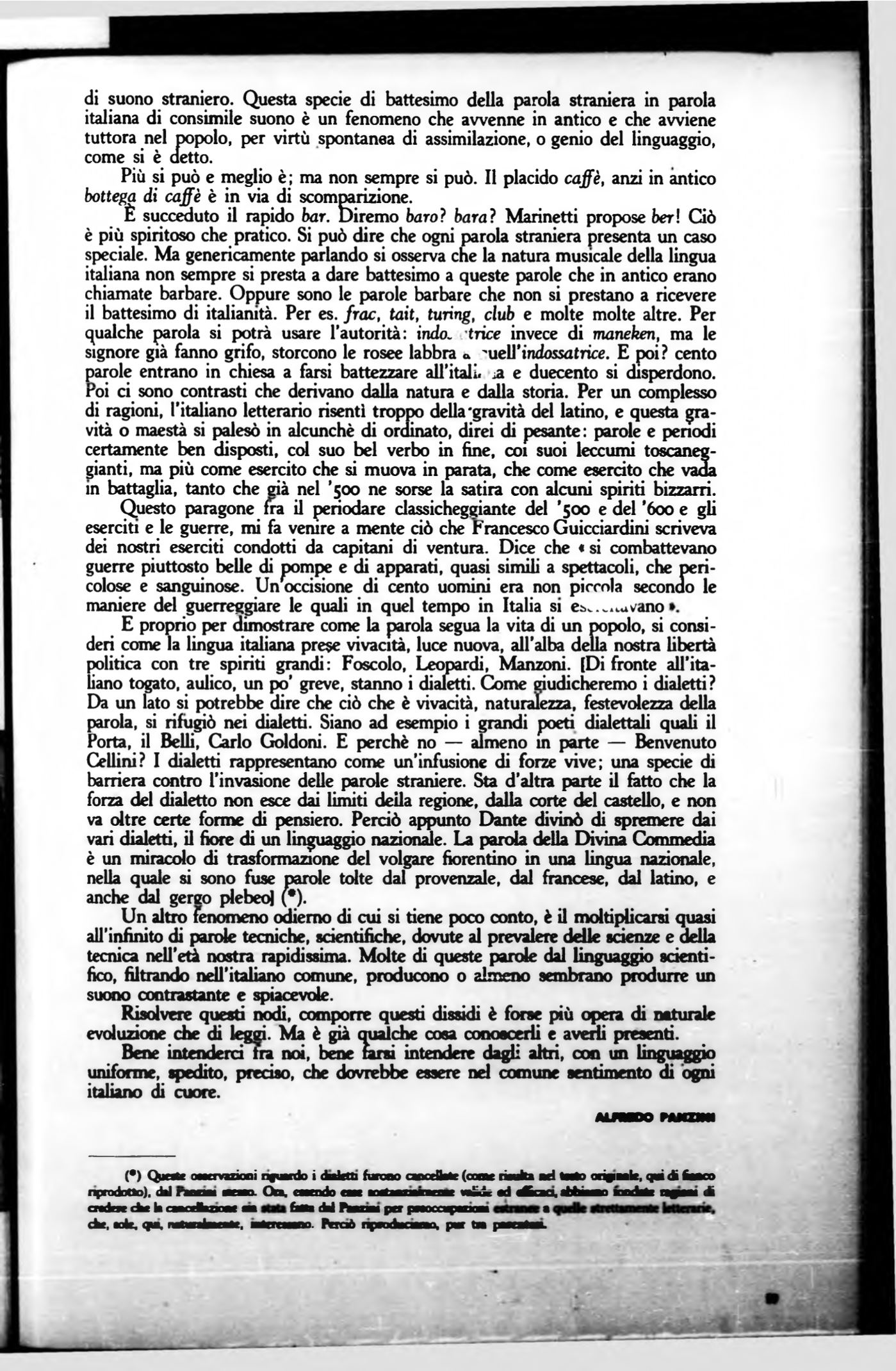
di suono straniero. Questa specie di battesimo della parola straniera in parola
italiana di consimile suono è un fenomeno che avvenne in antico e che avviene
tuttora nel popolo, per virtù spontanea di assimilazione, o genio del linguaggio,
come si è detto.
Più si può e meglio è ; ma non sempre si può. Il placido
caffè,
anzi in antico
bottega di caffè è
in via di scomparizione.
È succeduto il rapido
bar.
Diremo
baro
?
bara?
Marinetti propose
beri
Ciò
è più spiritoso che pratico. Si può dire che ogni parola straniera presenta un caso
speciale. Ma genericamente parlando si osserva che la natura musicale della lingua
italiana non sempre si presta a dare battesimo a queste parole che in antico erano
chiamate barbare. Oppure sono le parole barbare che non si prestano a ricevere
il battesimo di italianità. Per es.
frac, tait, turing, club
e molte molte altre. Per
qualche parola si potrà usare l’autorità: indo,
trice
invece di
maneken,
ma le
signore già fanno grifo, storcono le rosee labbra a 'uell’iruiossatrice. E poi? cento
parole entrano in chiesa a farsi battezzare all’itali.
jl
e duecento si disperdono,
roi ci sono contrasti che derivano dalla natura e dalla storia. Per un complesso
di ragioni, l’italiano letterario risentì troppo della'gravità del latino, e questa gra
vità o maestà si palesò in alcunché di ordinato, direi di pesante: parole e penodi
certamente ben disposti, col suo bel verbo in fine, coi suoi leccumi toscaneg-
gianti, ma più come esercito che si muova in parata, che come esercito che vada
m battaglia, tanto che già nel '500 ne sorse la satira con alcuni spiriti bizzarri.
Questo paragone fra il periodare classicheggiante del *500 e del ’6oo e gli
eserciti e le guerre, mi fa venire a mente ciò che Francesco Guicciardini scriveva
dei nostri eserciti condotti da capitani di ventura. Dice che « si combattevano
guerre piuttosto belle di pompe e di apparati, quasi simili a spettacoli, che peri
colose e sanguinose. Unoccisione di cento uomini era non piccola secondo le
maniere del guerreggiare le quali in quel tempo in Italia si
0 5 ^ .4
viiu^cino
E proprio per dimostrare come la parola segua la vita di un popolo, si consi
deri come la lingua italiana prese vivacità, luce nuova, all’alba della nostra libertà
politica con tre spiriti grandi: Foscolo, Leopardi, Manzoni. |Di fronte all’ita
liano togato, aulico, un po’ greve, stanno i dialetti. Come giudicheremo i dialetti?
Da un lato si potrebbe dire che ciò che è vivacità, naturalezza, festevolezza della
parola, si rifugiò nei dialetti. Siano ad esempio i grandi poeti dialettali quali il
Porta, il Belli, Carlo Goldoni. E perchè no — almeno in parte — Benvenuto
Cellini? I dialetti rappresentano come un’infusione di forze vive; una specie di
barriera contro l’invasione delle parole straniere. Sta d’altra parte il fatto che la
forza del dialetto non esce dai limiti della regione, dalla corte del castello, e non
va oltre certe forme di pensiero. Perciò appunto Dante divinò di spremere dai
vari dialetti, il fiore di un linguaggio nazionale. La parola della Divina Commedia
è un miracolo di trasformazione del volgare fiorentino in una lingua nazionale,
nella quale si sono fuse parole tolte dai provenzale, dal francese, dal latino, e
anche dal gergo plebeo] (*).
Un altro fenomeno odierno di cui si tiene poco conto, è il moltiplicarsi quasi
all’infinito di parole tecniche, scientifiche, dovute al prevalere delle scienze e della
tecnica nell’età nostra rapidissima. Molte di queste parole dal linguaggio scienti
fico, filtrando nell’italiano comune, producono 0 almeno sembrano produrre un
suono contrastante e spiacevole.
Risolvere questi nodi, comporre questi dissidi è forse più opera di naturale
evoluzione che di leggi. Ma è già qualche cosa conoscerli e averli presenti.
Bene intenderci tra noi, bene tarsi intendere dagli altri, con un linguaggio
uniforme, spedito, preciso, che dovrebbe essere nel comune sentimento di ogni
italiano di cuore.
ALfMDO FANZINI
(•) Quote
QTTvuioni
riguardo
i
dialetti furano cwceUate (come risulta ad tato originair, qui di fina»
1
| n É tn .\ 4 . 1
-------- ---------------------- /" W »
-----------i
--------------------->________________________ L J _ - -»
***
-»-* ■ ?----------
1
-
----------------j ;
n p ro a o cs o j, u n r a n n i skcm o. u n , c w o a o o b a o n u u i m e m e v a » c o a n o , le n ia m o lo o a a t c n p o t i a
CTC
ótTC
d lC l i canO tU lllOM n
fa tti d ii ^HHBDI p f f pVBOCCHpHMHI
t
cht, 8ok, <y i, nsturabnente, n ltrm n o . Perciò nprodu om o, pur In pHBÉSL


















