
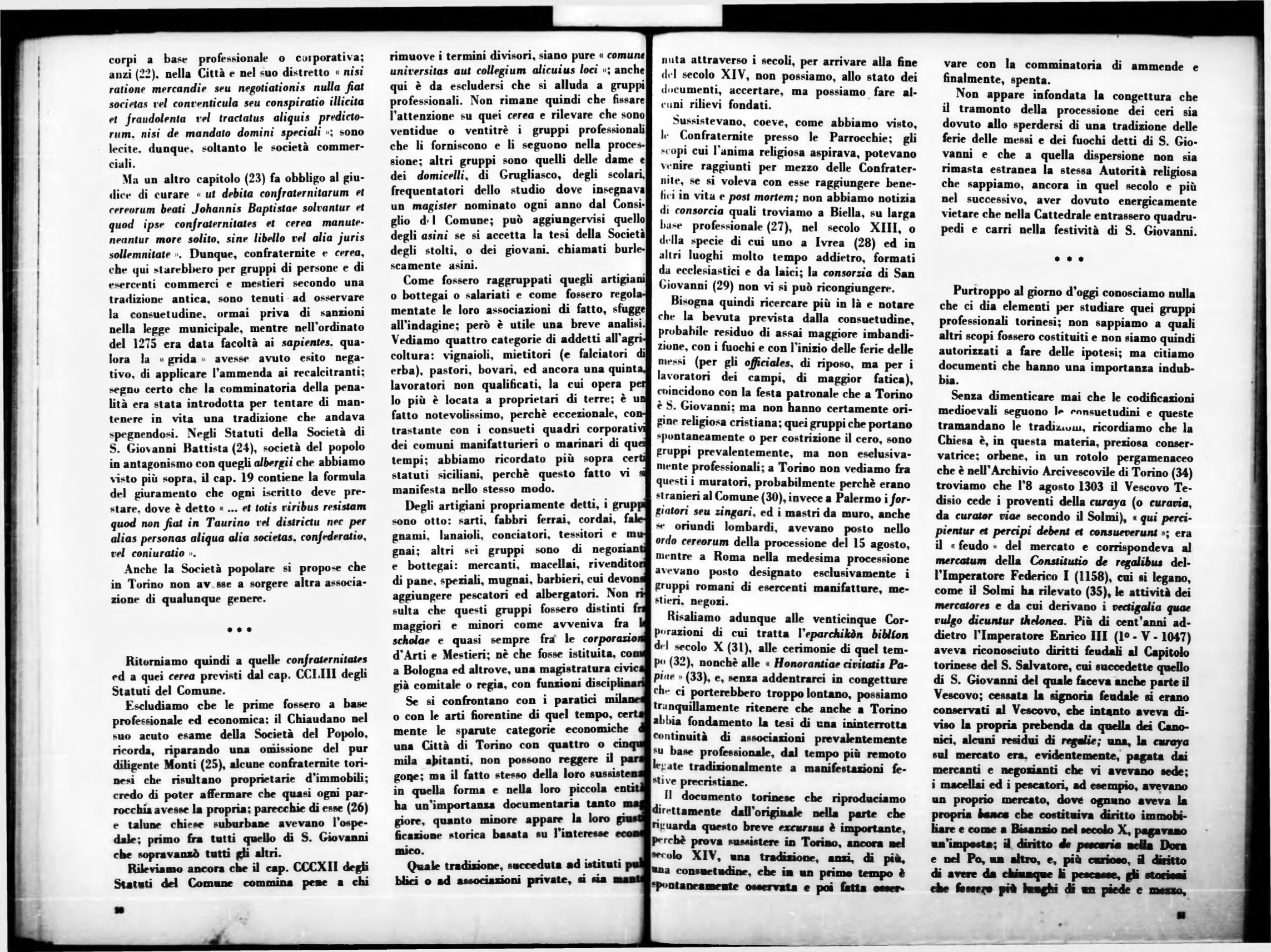
corpi a base professionale o coiporativa;
anzi (22), nella Città e nel suo distretto «
nisi
ralione mercandie seu negotiationis nulla fiat
societas rei conventicula seu conspiratio illicita
et fraudolenta rei tractatus aliquis predicto-
rum. nisi de mandato domini speciali
*>; sono
lecite, dunque, soltanto le società commer
ciali.
Ma un altro capitolo (23) fa obbligo al giu
dice di curare «
ut debita conjraternitarum et
cereorum beati Johannis Baptistae solvantur et
quod ipse confraternitates et cerea manute-
neantur more solito
,
sine libello vel alia juris
sollemnitate
». Dunque, confraternite e
cerea
,
che qui darebbero per gruppi di persone e di
esercenti commerci e mestieri secondo una
tradizione antica, sono tenuti ad osservare
la consuetudine, ormai priva di sanzioni
nella legge municipale, mentre nell'ordinato
del 1275 era data facoltà ai
sapientes.
qua
lora la « grida » avesse avuto esito nega
tivo, di applicare l'ammenda ai recalcitranti;
segno certo che la comminatoria della pena
lità era stata introdotta per tentare di man
tenere in vita una tradizione che andava
spegnendosi. Negli Statuti della Società di
S. Giovanni Battista (24), società del popolo
in antagonismo con quegli
albergii
che abbiamo
visto più sopra, il cap. 19 contiene la formula
del giuramento che ogni iscritto deve pre
stare. dove è detto « ...
et totis riribus resistam
quod non fiat in Taurino vel districtu nec per
alias personas aliqua alia societas. confederati
,
vel coniuratio ».
Anche la Società popolare si propose che
in Torino non av sse a sorgere altra associa
zione di qualunque genere.
• • •
Ritorniamo quindi a quelle
conjraternitates
ed a quei
cerea
previsti dal cap. CCLI11 degli
Statuti del Comune.
Escludiamo ebe le prime fossero a base
professionale ed economica; il Chiaudano nel
suo acuto esame della Società del Popolo,
ricorda, riparando una omissione del pur
diligente Monti (25), alcune confraternite tori
nesi che risultano proprietarie d'immobUi;
credo di poter affermare che quasi ogni par
rocchia avesse la propria; parecchie di esse (26)
e talune chiese suburbane avevano l'ospe
dale; primo fra tatti quello di S. Giovanni
che sopravanzo tatti gli altri.
Rileviamo ancora che il cap. CCCXII degli
Statati del Cornane commina pene a chi
rimuove i termini divisori, siano pure «
comune
universitas aut collegium alicuius loci
»; anche
qui è da escludersi che si alluda a gruppi
professionali. Non rimane quindi che fissare
l'attenzione su quei
cerea
e rilevare che sono
ventidue o ventitré i gruppi professionali
che li forniscono e li seguono nella proces
sione; altri gruppi sono quelli delle dame e
dei
domicelli
, di Grugliasco, degli scolari,
frequentatori dello studio dove insegnava
un
magister
nominato ogni anno dal Consi*
glio d>1 Comune; può aggiungervisi quello
degli
asini
se si accetta la tesi della Società
degli stolti, o dei giovani, chiamati burle
scamente asini.
Come fossero raggruppati quegli artigiani
o bottegai o salariati e come fossero regola
mentate le loro associazioni di fatto, sfugge
all'indagine; però è utile una breve analisi.
Vediamo quattro categorie di addetti all'agri
coltura: vignaioli, mietitori (e falciatori di
erba), pastori, bovari, ed ancora una quinta,
lavoratori non qualificati, la cui opera per
lo più è locata a proprietari di terre; è un
fatto notevolissimo, perchè eccezionale, con
trastante con i consueti quadri corporativi
dei comuni manifatturieri o marinari di quei
tempi; abbiamo ricordato più sopra certi
statuti siciliani, perchè questo fatto vi si
manifesta nello stesso modo.
Degli artigiani propriamente detti, i grup
sono otto: sarti, fabbri ferrai, cordai, fai
gnami. lanaioli, conciatori, tessitori e m
gnai; altri sei gruppi sono di negozian
e bottegai: mercanti, macellai, rivendita
di pane, speziali, mugnai, barbieri, cui devo
aggiungere pescatori ed albergatori. Non
sulta che questi gruppi fossero distinti
maggiori e minori come avveniva fra
scholae
e quasi sempre fra le
corporozio
d'Arti e Mestieri; nè che fosse istituita, co
a Bologna ed altrove, una magistratura civic
già comitale o regia, con funzioni discipli
Se si confrontano con i paratici milan
o con le arti fiorentine di quel tempo, cert
mente le sparute categorie economiche
una Gttà di Torino con quattro o cin
mila abitanti, non possono reggere il p
goqe; ma il fatto stesso della loro sussiste
in quella forma e nella loro piccola enti
ha un'importanza documentaria tanto
giore, quanto minore appare la loro gi
ficazione storica basata su l'interesse
mico.
Quale tradizione, sacceduta ad istituti
blici o ad associazioni private, si sia
nata attraverso i secoli, per arrivare alla fine
del secolo XIV, non possiamo, allo stato dei
documenti, accertare, ma possiamo fare al
cuni rilievi fondati.
Sussistevano, coeve, come abbiamo visto,
le Confraternite presso le Parrocchie; gli
scopi cui l'anima religiosa aspirava, potevano
venire raggiunti per mezzo delle Confrater
nite, se si voleva con esse raggiungere bene
fici in vita e
post mortem;
non abbiamo notizia
di
consorcia
quali troviamo a Biella, su larga
base professionale (27), nel secolo X III, o
della specie di cui uno a Ivrea (28) ed in
altri luoghi molto tempo addietro, formati
da ecclesiastici e da laici; la
consorzia
di San
Giovanni (29) non vi si può ricongiungere.
Bisogna quindi ricercare più in là e notare
che la bevuta prevista dalla consuetudine,
probabile residuo di assai maggiore imbandi-
zione, con i fuochi e con l'inizio delle ferie delle
messi (per gli
officiales
, di riposo, ma per i
lavoratori dei campi, di maggior fatica),
coincidono con la festa patronale che a Torino
è S. Giovanni: ma non hanno certamente ori
gine religiosa cristiana; quei gruppi che portano
spontaneamente o per costrizione il cero, sono
gruppi prevalentemente, ma non esclusiva-
niente professionali; a Torino non vediamo fra
questi i muratori, probabilmente perchè erano
stranieri al Comune (30), invece a Palermo i
for
giatori seu zingari
, ed i mastri da muro, anche
se oriundi lombardi, avevano posto nello
ordo cereorum
della processione del 15 agosto,
mentre a Roma nella medesima processione
avevano posto designato esclusivamente i
gruppi romani di esercenti manifatture, me
stieri, negozi.
Risaliamo adunque alle venticinque Cor
porazioni di cui tratta
Veparchikdn biblion
del secolo X (31), alle cerimonie di quel tem
po (32), nonché alle «
Honorantiae civitatis Pa
pine
" (33), e, senza addentrarci in congetture
ohe ci porterebbero troppo lontano, possiamo
tranquillamente ritenere che anche a Torino
abbia fondamento la tesi di una ininterrotta
continuità di associazioni prevalentemente
su base professionale, dal tempo più remoto
legate tradizionalmente a manifestazioni fe
stive precristiane.
Il
documento torinese che riproduciamo
direttamente dall'originale nella parte che
riguarda questo breve
excursus
è importante,
prrchè prova sassistere in Torino, ancora nel
•croio X IV , una tradizione, anzi, di piò,
una consuetudine, che in un primo teaapo è
"pontaneamente osservata e poi fatta « s e r
vare con la comminatoria di ammende e
finalmente, spenta.
Non appare infondata la congettura che
il tramonto della processione dei ceri sia
dovuto allo sperdersi di una tradizione delle
ferie delle messi e dei fuochi detti di S. Gio
vanni e che a quella dispersione non sia
rimasta estranea la stessa Autorità religiosa
che sappiamo, ancora in quel secolo e più
nel successivo, aver dovuto energicamente
vietare che nella Cattedrale entrassero quadru
pedi e carri nella festività di S. Giovanni.
• • •
Purtroppo al giorno d'oggi conosciamo nulla
che ci dia elementi per studiare quei gruppi
professionali torinesi; non sappiamo a quali
altri scopi fossero costituiti e non siamo quindi
autorizzati a fare delle ipotesi; ma citiamo
documenti che hanno una importanza indub
bia.
Senza dimenticare mai che le codificazioni
medioevali seguono 1*» consuetudini e queste
tramandano le tradiziuui, ricordiamo che la
Chiesa è, in questa materia, preziosa conser
vatrice; orbene, in un rotolo pergamenaceo
che è nell'Archivio Arcivescovile di Torino (34)
troviamo che l'8 agosto 1303 il Vescovo Te-
disio cede i proventi della
curaya
(o
curavia
,
da
curator viae
secondo il Solmi), «
qui perei-
pientur et percipi debent et consueverunt
»; era
il « feudo
»
del mercato e corrispondeva al
mercatum
della
Constitutio de regalibus
del
l'imperatore Federico I (1158), cui si legano,
come il Solmi ha rilevato (35), le attività dei
mercatores
e da cui derivano i
vectigalia quae
vulgo dicuntur thelonea.
Più di cent'anni ad
dietro l'imperatore Enrico III (1° - V - 1047)
aveva riconosciuto diritti feudali al Capitolo
torinese del S. Salvatore, cui succedette quello
di S. Giovanni del quale faceva anche parte il
Vescovo; cessata la signoria feudale si erano
conservati al Vescovo, che intanto aveva di
viso la propria prebenda da quella dei Cano
nici, alcuni residui di
regalie;
una, la
eurmyo
sol mercato era. evidentemente, pagata dai
mercanti e negozianti che vi avevano sede;
i macellai ed i pescatori, ad esempio, avevano
un proprio mercato, dove ognuno aveva la
propria
bmnem
che costituiva diritto immobi
liare e come a Bisansio nel secolo X , pagavano
un'imposta; il diritto
de pttcmrim
nella Dora
e nel Po, ma altro, e, più curioso, il diritto
di avere da chiunque li pescasse, gli storioni
che
fcsseaps
piè lunghi di un piede e mezzo.


















