
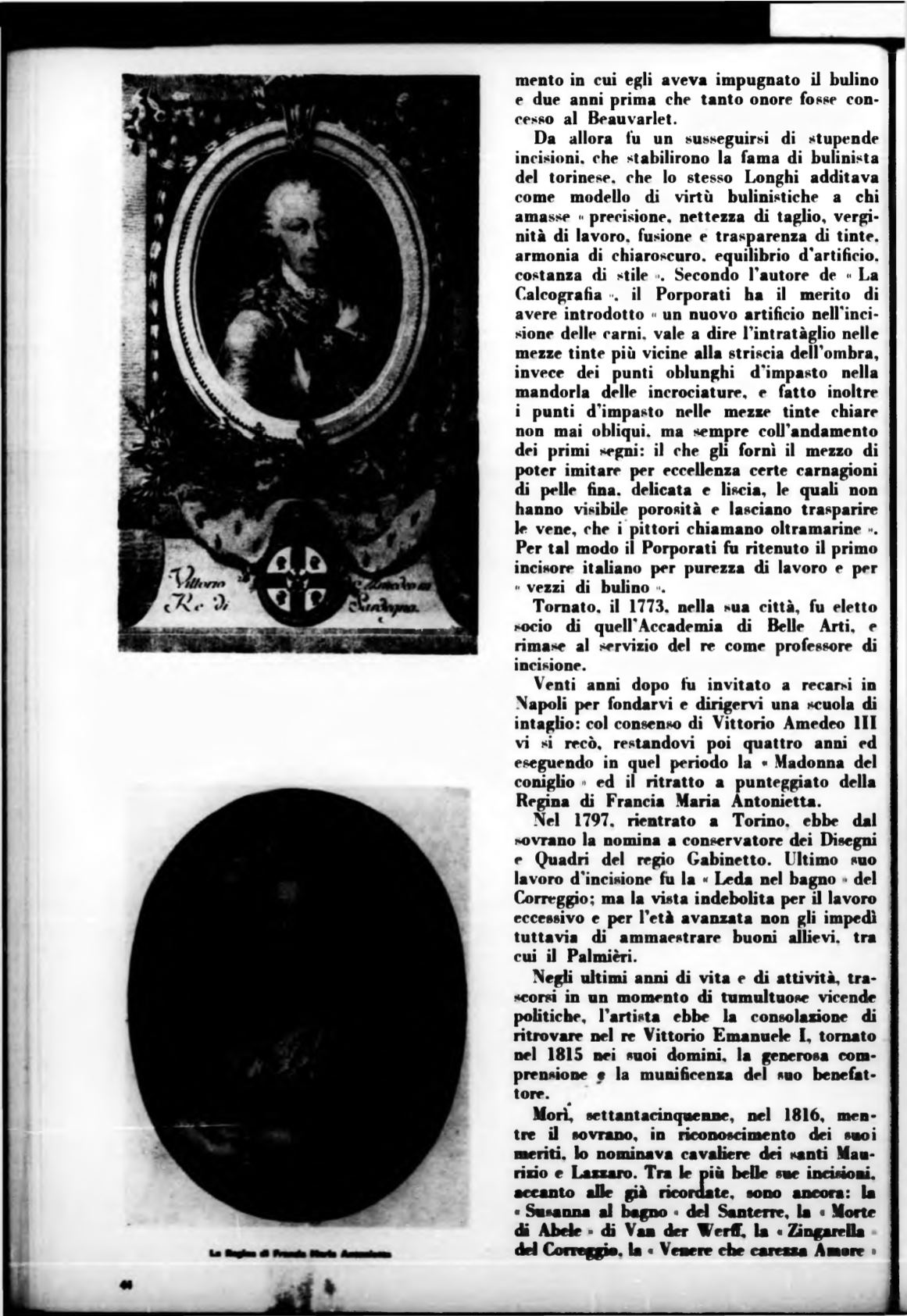
mento in cui egli aveva impugnato il bulino
e due anni prima che tanto onore fosse con*
cesso al Beauvarlet.
Da allora fu un susseguirsi di stupende
incisioni, che stabilirono la fama di bulinista
del torinese, che lo stesso Longhi additava
come modello di virtù bulinistiche a chi
amasse " precisione, nettezza di taglio, vergi*
nità di lavoro, fusione e trasparenza di tinte,
armonia di chiaroscuro, equilibrio d'artificio,
costanza di stile >. Secondo l'autore de « La
Calcografia ". il Porporati ha il merito di
avere introdotto « un nuovo artificio nell'inci
sione delle carni, vale a dire l'intratàglio nelle
mezze tinte più vicine alla striscia dell'ombra,
invece dei punti oblunghi d'impasto nella
mandorla delle incrociature, e fatto inoltre
i punti d'impasto nelle mezze tinte chiare
non mai obliqui, ma sempre coll'andamento
dei primi segni: il che gli fornì il mezzo di
poter imitare per eccellenza certe carnagioni
di pelle fina, delicata e liscia, le quali non
hanno visibile porosità e lasciano trasparire
le vene, che i pittori chiamano oltramarìne ».
Per tal modo il Porporati fa ritenuto il primo
incisore italiano per purezza di lavoro e per
>•vezzi di bulino ».
Tornato, il 1773. nella sua città, fu eletto
socio di quell'Accademia di Belle Arti, e
rimase al servizio del re come professore di
incisione.
Venti anni dopo fu invitato a recarsi in
Napoli per fondarvi e dirigervi una scuola di
intaglio: col consenso di Vittorio Amedeo 111
vi si recò, restandovi poi quattro anni ed
eseguendo in quel periodo la « Madonna del
coniglio » ed il ritratto a punteggiato della
Regina di Francia Maria Antonietta.
Nel 1797, rientrato a Torino, ebbe dal
sovrano la nomina a conservatore dei Disegni
e Quadri del regio Gabinetto. Ultimo suo
lavoro d'incisione fu la « Leda nel bagno •del
Correggio; ma la vista indebolita per il lavoro
eccessivo e per l'età avanzata non gli impedì
tuttavia di ammaestrare buoni allievi, tra
cui il Palmièri.
Negli ultimi anni di vita e di attività, tra*
scorsi in un momento di tumultuose vicende
politiche, l'artista ebbe la consolazione di
ritrovare nel re Vittorio Emanuele I, tornato
nel 1815 nei suoi domini, la generosa com
prensione e la munificenza del suo benefat
tore.
«
Morì, settantacinquenne, nel 1816, men
tre il sovrano, in riconoscimento dei suoi
meriti, lo nominava cavaliere dei saati Mau
rizio e Lazzaro. Tra le più belle sue incisioni,
accanto alle già ricordate, sono ancora: la
•Susanna al bagno •del Saatene, la •Morte
di Abele - di Van der WerfF. la « Ziagarella
del Carreggia, la •Veaere che carezza Amare
*


















