
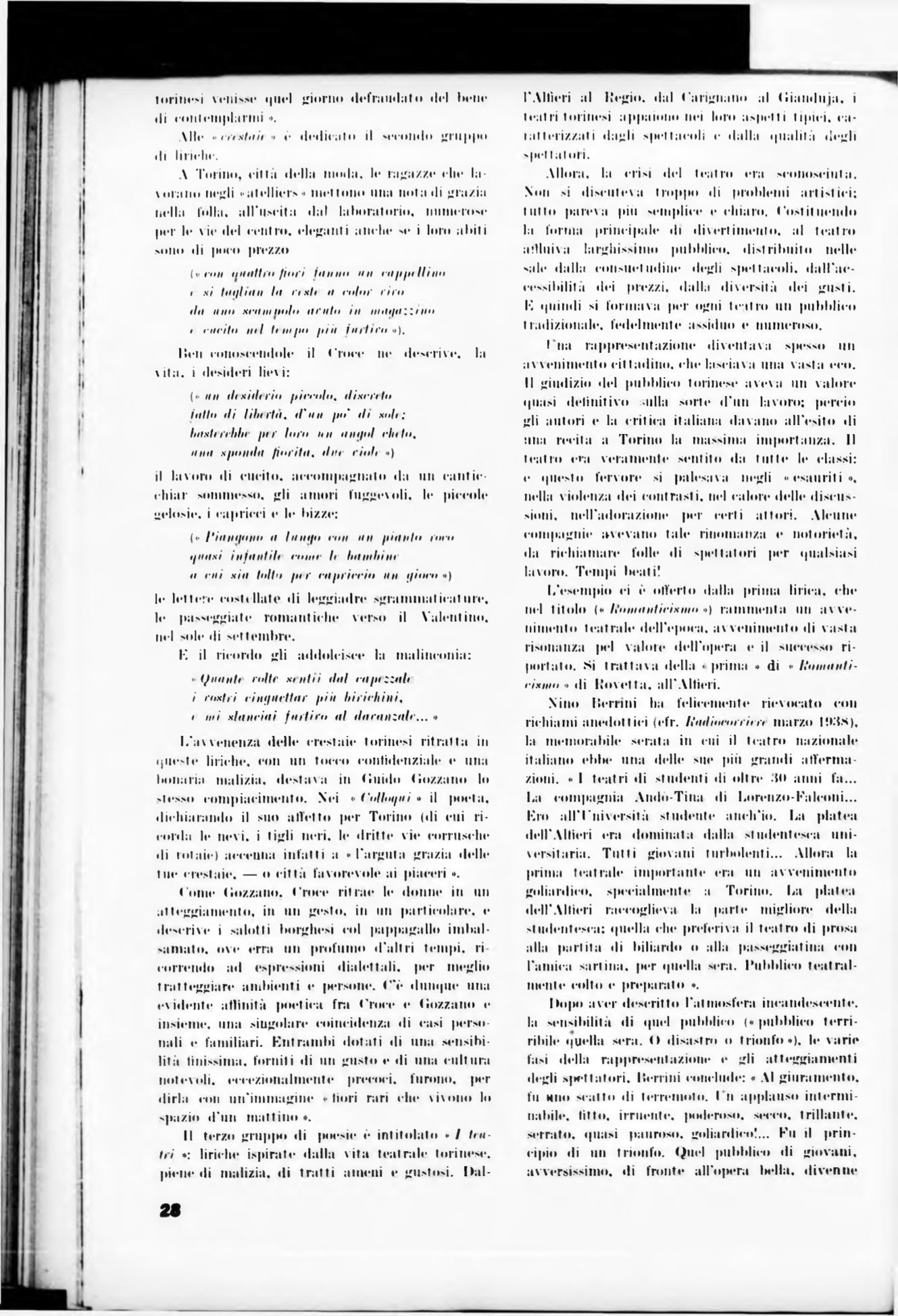
torinesi venisse quel giorno defrau«lato ilei bene
di contemplarmi ».
Alle vrfistnii •> è
d e d i c a t o
il
s e c o n d o g r u p p o
ili liriche.
A Torino, città tirila moda, le ragazze eli»* la
vorano negli «atclliers» mettono una nota «li grazia
nella lolla, all'uscita «lai laboratorio, numerosi*
pel-le vie «lei centro, eleganti alleile >e i loro aititi
som» «li poco prezzo
{vimi iiiinttfo filtri fumili a n ni/i fu IIi ilo
i si tiii/liiiii In risii il mltir rifu
iln min srnin imiti tiriiln in umilimi im
t riiriln ntl limini /li il in iti in »).
lieti conoscendoli* il Croce tic descrivi*, la
\ ita. i «lesidcri lie\i:
(filli ili siili fin jiii'ftiln, ilisrfttn
lutiti ili Ulu lili, il'iiii iin' ili sali :
Imsti rrlibr jn i• loro un nni/til fin tu,
min s/nuiiln filtriti). ilnr rinlr »)
il lavoro «li cucito, accompagnato «la un cantic
chiar sommesso, gli amori fuggcvoli, le piccole
gelosie, i capricci e le bizze:
(<• l ’inin/tiini il Imititi con mi /tinniti funi
i/
h
tisi influitili mnir Ir Iniinhinr
n m i sin tnlt’i jn f rttjn'irriti un ijiont »)
le lett«*!•«* costellate «li leggia«lre sgraminaticatlire,
l«* passeggiate romantiche verso il Valentino,
nel sole ili settembre.
K il ricordo gli addolcisce la malinconia:
<• (l>inintt mite stntii lini rn /nzzilli
i lustri rimjurttnf /tiii b ifirh in i,
t mi simirini fu riirò ni ilnritnznlr... »
L'avvenenza delle crestaie torinesi ritratta in
q u e s t
«* liriche, eoli un tocco confidenziale e una
bonaria malizia, destava in Càllidi» Cozzano lo
>tesso compiacimento. Nei <■ ('nlliu/u i » il poeta,
«lichiarando il suo a fletto per Torino («li cui ri-
cftnla le nevi, i tigli neri, le dritte vie corrusche
ili rotaie) accenna infatti a « l'arguta grazia «Ielle
tue crestaie. — o città favorevole ai piaceri ».
Come Cozzali*». Croce ritrae le ilonnc in un
atteggiamento, iti un gesto, in un particolare, e
descrive i salotti borghesi col pappagallo imba l
samato. ove erra un profumo d'altri tempi, ri
«-orrendo ad espressioni dialettali, per meglio
tratteggiare ambienti e |n*rsone. C'è «lumpie una
evidente affinità poetica fra Croce e Cozzano e
insieme, una singolare coincidenza di casi perso
nali «* familiari. Kilt ramiti dotati «li una sensibi
lità finissima, forniti «li un gusto e «li una cultura
uot4-v «ili. eccezionalmente precoci, furono, per
dirla «-«ni un'immagine «• ti«*ri rari che vivono lo
spazio irm i mattino ».
Il
terzo gruppo «li poesie è intitolato <• / fru
tti »: liriche ispirate dalla vita teatrali* torinesi»,
piene di malizia, di tratti ameni •* gustosi. Dal-
1*Altieri al Ifcgio. «lai Carignano al (ìiam lu ja , i
teatri torinesi appaiono nei loro aspetti tipici, ca-
tattcrizzati dagli spettacoli c dalla qualità degli
'pel Iaio li.
Allora, la crisi del teatro era sconosciuta.
Non si discuteva troppo ili problemi artistici;
tutto pareva più semplice e chiaro. Costitimmiti
la forma principale ili «liverlimeiito. al teatro
ailluivsi larghissimo pubblico, «lisfribuitti nelle
s a l e
dalla colisuetUtline degli spettacoli. «laM'ae-
ccssibilifà ilei prezzi, tlalla diversità «lei gusti.
K «|iiimii si formava per ogni teatro un pubblico
tradizionale, fedelmente assiduo e numeroso.
I na rappresentazione diventava spesso
imi
av venimento cittadino, che lasciava una vasta eco.
Il giudizio «lei pubblico torinese aveva un valore
«piasi definitivo sulla sorte «l'un lavoro; perciò
gli autori e la critica italiana «lavano all'esito ili
una recita a Torino la massima importanza. Il
teatro era veramente sentito da tutti* le classi:
e questo fervore si palesava negli «esauriti»,
nella violenza dei contrasti, nel calore delle discus
sioni. ncU'adorazione per certi attori. Alcune
compagnie avevano tale rinomanza c notorietà,
ila richiamare folle ili spettatori per qualsiasi
lavoro. Tempi beati!
L'esempio ci è offerto dalla prima lirica, che
nel titolo (« Ikiiniinitirisniit ») rammenta un avve
nimento teatrale dell'epoca, avvenimento «li vasta
risonanza pel valore «IcU'opera e il successo ri
portato. Si trattava della • prima » di « Htnnunti-
risntti -, di Kovctta. all'Altieri.
Nino Iterimi ha felicemente rievocato etili
richiami aucdottici (efr. hìntlitirorrirn marzo P.tfM),
la memorabile serata in cui il teatro nazionale
italiano ebbe una delle sue più granili afferma
zioni. « I teatri ili stiulenti di oltre .{0 anni fa...
La compagnia Andò-Tina «li Ltirciizo-Falconi...
Kro airi'n ivers ità stmielite anch'io. La platea
«lei!'Alfieri era dominata tlalla studentesca un i
versitaria. Tutti giovani turbolenti... Allora la
prima teatrale importanti* era un avvenimento
goliardico, specialmente a Torino. La platea
«leU'Altieri raccoglieva la parte migliore della
studentesca: quella che preferiva il teatro ili prosa
alla partita «li biliardo o alla passeggiatimi con
l'amica sartina, per quella seni. Pubblico teatral
mente colto e preparato ».
Dopo aver descritto l'atmosfera incandescente,
la sensibilità tli quel pubblico (« pubblico ferri-
ribile quella sera. O disastri o trionfo»), le varie
fasi della rappresentazione e gli atteggiamenti
«legli sjtfttattiri. Iterrini concludi»: « Al giuramento,
fu Mito scatto di terremoto. I n applauso interm i
nabile, fitto, irruente. |tod»*mso, secco, trillante,
serrato, quasi pauroso, goliardico!... Fu il prin
cipio ili un trionfo, telici pubblico tli giovani,
avversissimo, «li fronte all'opera Itella, divenne
20


















