
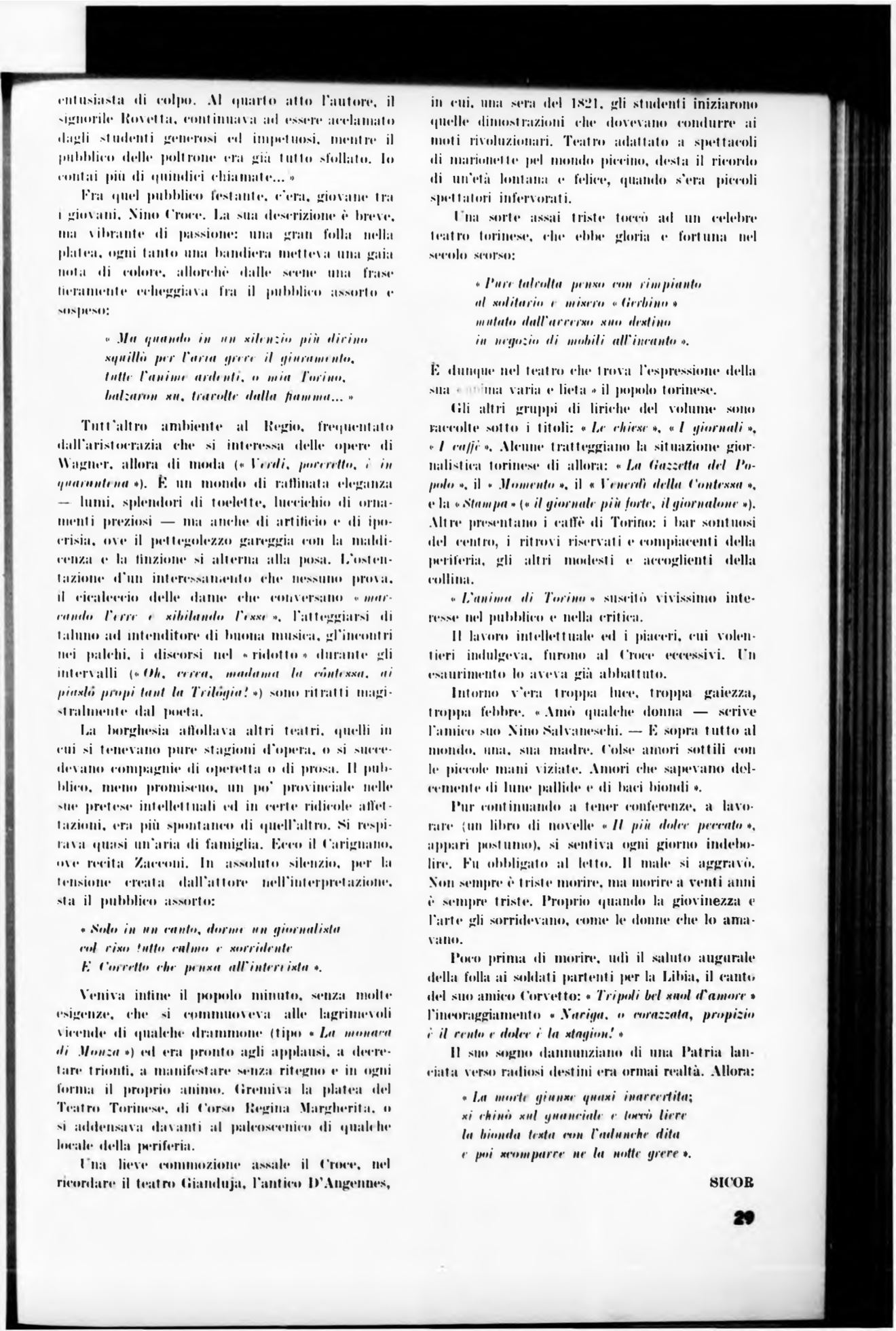
entusiasta di colpo. Al (|uai*to atto l'autore, il
'ignorile Rovctta, continuava a<I essere acclamato
dagli studenti generosi ed impetuosi, mentre il
pubblico delle poltrone era già tutto sfollato. Io
contai piii di i|iiindici chiamate... »
Fra (|iiel pubblico Icstante, c'era, giovane tra
i giovani. Nino Croce. I.a sua descrizione è breve,
ma vibrante di passione: una gran folla nella
platea, ogni tanto una bandiera metteva una gaia
nota di colon*, allorché dalli* scene una frase
Meramente echeggiava fra il pubblico assorto c
>ospeso:
«
Mi
i
i/nanilo in mi silenzio
/
iììi
ilirino
sifiiillò per Turni grere il giiirumt ilio,
tulli■ru llim i unii ufi, o min Torino,
luti:u ion
sii
, trainile iltilla fiuni imi... »
Tntt'altro ambiente al Regio, frc<|Ucntato
dall'aristocrazia che si interessa delle opere di
Wagner, allora di moda (« Virili, immetto, i in
ifiiuruntino »). K un mondo di ratlinata eleganza
— lumi, splendori di toelette, luccichio di orna
menti preziosi — ma anche di artificio e di ipo
crisia. ove il pettegolezzo gareggia con la maldi
cenza i* la finzione si alterna alla posa. L'o>tdi
lazione d'ini intercisa mento che nessuno pro\a,
il cicaleccio dell»* datile che conversano <■mar
i-mulo Terre < sihilmulo l'is s t •>. Patteggiarsi di
taluno ad intenditore di buona musica, gl'incontri
nei palchi, i discorsi nel « ridott....... Idrante gli
intervalli (<• ttli, r im i, miniamo hi rónhstta, ni
l>ia.sin /no/ii tmit In Trilogia! *) sonoritratti magi
stralmente dal poeta.
La borghesia affollava altri teatri. (|iiclli in
cui si tenevano pure stagioni d ’opera, o si succe
devano compagnie di operetta o di prosa. Il pub-
blico, meno promiscuo, un po' provinciale nelle
'tic pretese intellettuali ed in certe ridicole affet-
tazioni, era più >pontanco di (|iiell*altro. Si r«*>|»i-
rava (piasi un'aria di famiglia. Kcco il Cariguano.
ove recita /accolli. In assoluto silenzio, per la
tensione creata dall'attore nelPinterpn*t azione,
sta il pubblico assorto:
*
Solo in mi muto, dorme mi giornalista
eoi riso fatto rullilo r xorriih'ntr
E l 'tu rrito rhr fu usa all'interi istu ».
Veniva infine il popolo minuto, senza molte
esigenze, che si commuoveva alle lagrimcvoli
vicende di qualche drammone (tipo •L a immura
<H Monza ») ed era pronto agli applausi, a decre
tare trionfi, a manifestare senza ritegno e in ogni
forma il proprio animo. (ìreniiva la platea del
Teatro Torinese, di Corso Regina Margherita, o
si addensava davanti al palcoscenico di qualche
locale della |mtìferia.
I
na lieve commozione assale il Croce, nel
ricordare il teatro (iiandu ja, l'antico IPAngcnncs,
in cui. una sera del 1SLM, gli studenti iniziarono
quelle diniostrazioni che dovevano condurre ai
moti rivoluzionari. Teatro adattato a spettacoli
di marionette pel mondo piccino, desta il ricordo
di un'età lontana e felice, quando s'era piccoli
spettatori infervorati.
I na sorte assai triste toccò ad un celebre
teatro torinese, che ebbe gloria e fortuna nel
secolo scorso:
<• Ture talrolta penso ron rimpianto
ni solitario i misero « (Serbino »
umililo tlalTarrerso suo ilestino
in negozio ili mollili olTinronto ».
K dunque nel teatro che trova l'espressione della
.'ila
ina varia e lieta » il popolo torinese.
(ìli altri gruppi di liriche del volume sono
raccolte sotto i titoli: « Le rliiexr », « / ijitirnuli »,
<• / ra/jè », Alcune tratteggiano la situazione gior
nalistica torinese di allora: « La Gazzetta tiri To
ltolo •>. il * Momento », il « Pi nerii) ilella Contessa »,
e la <•Sfumila » (« il giornale più forte, ilijiornahine »).
Altre presentano i caffè di Torino: i bar sontuosi
del centro, i ritrovi riservati e compiacenti della
periferia, gli altri modesti e accoglienti della
collina.
<• L'nninni ili Torino >» suscitò vivissimo illtii-
rcsse nel pubblico e nella critica.
II lavoro intellettuale ed i piaceri, cui volen
tieri indulgeva, furono al Croce eccessivi. Un
esaurimento lo aveva già abbattuto.
Intorno v'era troppa luce, troppa gaiezza,
troppa febbre. « Amò qualche donna — scrive
l'amico suo Nino Saivaneschi. — K sopra tu tto al
mondo, una. sua madre. Colse amori sottili con
le piccole mani viziate. Amori che sapevano dol
cemente di lune pallide e di baci biondi ».
Pur continuando a tener conferenze, a lavo
rare (un libro di novelle « I l /
iììi
ilolee percalli »,
appari postumo), si sentiva ogni giorno indebo
lire. Fu obbligato al letto. Il mah* si aggravò.
Non sempre è triste morire, ma morire a venti anni
è sempre triste. Proprio (piando la giovinezza e
Parte gli sorridevano, come le donne che lo ama
vano.
Poco prima di morire, udì il saluto augurale
della folla ai soldati partenti per la Libia, il muto
del suo amico Corvetto: « Tripoli bel suol tTamore *
l'incoraggiamento « Sarigo. <> mrazzata, propizio
è il reniti e dolce è la stogimi! »
li suo sogno dannunziano di una Patria lan
ciata verso radiosi destini era ormai realtà. Allora:
* l.a intuii ijimise quasi inarreiUta;
si ehinò sul guanciale e Inerii liere
In bionda testa ron Vatlnnehe dita
e poi scomporre ne la notte grere ».
8 IC0R


















